Odontomachus bauri, Emery, 1892

Specie molto comune in centro e sudamerica.
Le ho trovate in Venezuela, Costarica, Colombia e Panamà, sia in foresta tropicale che in montagna.
Sono di facile allevamento, basta dar loro un certo tenore di umidità, e se tenute alla temperatura giusta (sopra i 21 gradi,ma meglio dai 23 ai 27) la covata sviluppa rapidamente.
Sono formiche attive, sempre in cerca di prede, come molte ponerine sono cacciatrici solitarie, si nutrono di prede e sostanze zuccherine.
Il mio primo incontro in un parco pubblico, sotto un ceppo marcescente a Caracas fu dolorosissimo, stetti attento avendo riconosciuto la "forma poneroide" ma non sapevo che potessero saltare!!
sentivo dei piccoli schiocchi, e vedevo molte operaie che saltavano 30-40 cm in alto! alcune mi cadevano addosso e poi usavano il pungiglione... fa male,poco meno di una vespa,nulla di tremendo, ma sorprende... e se poi sono molte non si resiste a lungo...
Questa interessante specie infatti ha la particolarità di avere le mandibole lunghe e può aprirle a 180gradi, poi con le antenne lunghe e filiformi individua la preda si porta a tiro; appena i sensori posti alla base dell'apertura boccale toccano la preda, le mandibole si chiudono di scatto, velocissime. Se colpiscono la preda la mutilano o uccidono facilmente, se invece il colpo va a vuoto la violenza dell'urto catapulta l'insetto per aria.
Questo movimento di chiusura a scatto è il piu rapido movimento realizzabile da un animale!!! avete capito bene: piu veloce del battito d'ali della mosca... per dirne una!
http://en.wikipedia.org/wiki/Odontomachus
http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/difesacolture-articoli/mascelle-formica-velocita-record11.html
In questa foto si può vedere come feci adottare operaie di Odontomachus eritrocefala a una regina di O. bauri (panamense)



Ecco foto delle regine trovate un mesetto fa in Thailandia (khao Lak). Dovrebbe essere Odontomachus simillimus


(clicca per ingrandire)

(clicca per ingrandire)
Ci sono diversi sistemi per allestire un nido di gesso adatto all'osservazione di una colonia di formiche.
Qui offro lo schema da me usato generalmente per ottenere uno stampo su cui lavorare in seguito, creando gallerie e collegamenti.
Come base dove colare il gesso si può usare una scatola di plastica, o di cartone. Le scatole di cartone o di legno hanno il vantaggio di poter essere rotte dopo la solidificazione, in modo di poter estrarre facilmente il blocco ottenuto. Mentre più difficile potrebbe essere estrarre il nido solidificato da una matrice di plastica o vetro.
Per predisporre la disposizione delle camere, sono ideali tutti gli oggetti facilmente estraibili dal gesso, come scatolette di fiammiferi, o tappi di bottiglia, o altro che la nostra fantasia ci metta a disposizione, ma io uso con successo forme di polistirolo sagomate ad hoc.
E' bene usare il polistirolo compresso, più compatto e meno soggetto a sfaldarsi in fase di estrazione.
Sono altrettanto funzionali stampi in plastilina, gomma, e qualsiasi altro materiale che non si fonda col gesso, rendendoli poi difficili da estrarre.
Come da schema, è bene incollare questi oggetti al vetro che servirà da base, possibilmente senza usare colle tossiche.
Qualche volta è consigliabile spalmare le forme e anche le pareti dello stampo di vaselina: questo può facilitare l'estrazione finale, anche se poi è necessario lavare bene il gesso in modo che non resti impregnato da odori che potrebbero infastidire certe formiche.
Studiate bene le dimensioni delle camere, delle gallerie che faranno seguito, dei collegamenti esterni, pensando a quale tipo di formiche vorrete alloggiare: piccole formiche come le Tetramorium o le Crematogaster, posso scavare facilmente nel gesso bagnato, o sfruttare un collegamento mal messo per trovare una via di fuga.
Colare il gesso in quantità sufficiente a coprire le forme incollate per ALMENO 1 cm di spessore. Mescolare bene e ben diluito, in modo che il gesso liquido vada a coprire ogni forma, facendo ben attenzione che non si stacchi dal vetro, altrimenti rischiate di dover rifare il lavoro!
E' sempre consigliabile non incollare le forme troppo vicino ai bordi esterni del vetro, per scoraggiare eventuali tentativi di scavo della colonia, né utilizzare forme troppo spesse, che farebbero risultare gallerie o stanze troppo profonde, permettendo alle formiche di sfuggire alla nostra vista.
All'estrazione del blocco, avvenuta quando il gesso sarà solidificato (cosa che può richiedere alcune ore, ma anche più di un giorno se avete usato un contenitore stagno che ritarderà l'asciugatura del gesso), una volta rimosse le sagome delle gallerie, sarà possibile scavare tutte le gallerie di collegamento usando uno strumento acuminato come un cacciavite, un temperino, o anche un piccolo trapano a punta fine.
Si potrebbe scavare integralmente in un blocco omogeneo, come si fa con il gasbeton, ma chi ha provato a scavare a mano nel gesso, concorderà che avere almeno la pianta già stabilita delle stanze principali risparmia un sacco di lavoro, soprattutto se il gesso è ben asciugato e compatto.
Per i formicai a due facce, prevedete più di una galleria di collegamento tra le due superfici: un solo collegamento rende difficile l'areazione e tende a creare ristagni di umidità sulla faccia meno riscaldata.
Solo colonie pluriennali hanno formiche così numerose da occupare grandi nidi integralmente, tanto che nelle prime fasi di crescita della colonia, è consigliabile mantenerla in provetta, o in nidi intermedi più piccoli. Le formiche non amano avere attorno al nucleo abitativo grandi spazi non protetti e difficili da gestire in quanto calore e umidità, mentre la smania di fornire loro un bel formicaio pervade l'allevatore...
Questo tipo di nido è consigliabile solo per le situazioni in cui si prevede una rapida espansione di una colonia già avviata, in modo da non doverla traslocare a breve: di solito si permette alle formiche di colonizzare per bene tutta la prima facciata, e quando la popolazione sta stretta, si aprono i collegamenti (chiusi precedentemente con tappi di cotone) che danno accesso alla seconda facciata.
E' bene effettuare questa operazione raffreddando prima la colonia, in modo da dare il tempo di togliere i tappi e sigillare con il vetro la seconda facciata prima che le formiche trovino questo sbocco.
Comunque normalmente questo non avviene in modo così rapido: la colonia tende a esplorare con attenzione i nuovi spazi, e c'è tutto il tempo di effettuare l'operazione.
Un formicaio artificiale è, al pari di un acquario, la riproduzione di un habitat, e ogni habitat presenta certi parametri e ha precise caratteristiche.
Quando decidiamo come fare il nostro formicaio, dobbiamo tenere in considerazione due aspetti principali:
1) Deve essere un ambiente ospitale per la nostra colonia e presentare tutti gli elementi
indispensabili a mantenerla in salute e consentirle di ingrandirsi;
2) Deve consentire a noi di poter osservare la nostra colonia senza causare “disturbo” alla stessa,
così da gustarci questo peculiare tipo di allevamento (come avviene in un acquario).
Un formicaio è composto anzitutto da due parti:
1) Formicaio vero e proprio; |

|
2) Arena. |

|
Il formicaio rappresenta lo spazio interno dove si svolge la maggior parte della vita della nostra colonia. E’ costituito essenzialmente da tunnel e stanze.
L’arena è invece la zona di foraggiamento e rappresenta lo spazio esterno del formicaio. E’ il luogo dove le nostre formiche “escono” per cercare cibo ed acqua e rappresenta l’areale che loro difendono.
Elementi indispensabili per la colonia
Gli elementi indispensabili per la colonia, in funzione della specie in possesso, sono:
(clicca sul titolo per visitare la sezione corrispondente)
1) Giusto materiale del formicaio;
2) Giusta dimensione e ambientazione dell’arena;
3) Giusta alimentazione;
4) Giusto grado di umidità;
5) Giusta temperatura;
6) Giusta luminosità.
Materiale del formicaio:
Per scegliere quale materiale usare conviene guardare ciò che avviene in natura. Essenzialmente le specie si dividono in due tipi principali. Le specie arboricole preferiranno formicai fatti nel legno, mentre specie terricole preferiranno nidi in terra, sabbia, argilla, gesso, y-tong, gasbeton.
 
Questo aspetto non è da sottovalutare, poiché specie particolarmente sensibili possono manifestare una sorta di “stress” causato dalla detenzione in un materiale non di loro gradimento e, in tali condizioni, possono deporre meno, mostrare difficoltà varie e, nei casi più gravi, smettere di deporre lasciando la colonia morire.
I formicai dovrebbero crescere insieme alla colonia. Quindi è del tutto controproducente porre colonie piccole in formicai enormi. Le operaie rischieranno, infatti, di perdersi e morire. Inoltre lo spazio vuoto non verrebbe tenuto pulito dalle poche operaie, causando la proliferazione di funghi e batteri (anche patogeni). Tutti i parametri sono più difficili da tenere sotto controllo e si rischia di causare un blocco alla crescita della colonia o, ancora peggio, la morte della stessa.
Meglio far passare la colonia da diversi formicai di "accrescimento" e solo quando avrà raggiunto diverse centinaia di operaie porla in un formicaio molto grande.
Giusta dimensione a ambientazione dell’arena:
L’arena è un misto di praticità, gusto estetico ed utilità (sia per noi che per le formiche stesse). Le dimensioni devono essere adatte alla colonia, tenendo in considerazione il fatto che in natura le operaie si allontanano dal formicaio solo nel momento in cui non trovano sufficiente cibo nei paraggi e, comunque, il numero di operaie che usciranno sarà sempre una esigua minoranza del numero complessivo di operaie della colonia.
Inutili sono, quindi, arene giganti per coloniette di poche decine di esemplari. Spazi troppo grandi possono, al contrario, causare disturbo, poiché le operaie possono sentirsi meno al sicuro avendo più spazio da dover controllare e difendere.

Il materiale da usare va scelto con cura. Teniamo presente che fondi di terra o sabbia troppo profondi potrebbero indurre colonie terricole a scavare e a portare la colonia sotto terra nell’arena (anziché usare il formicaio che gli abbiamo costruito). Così come l’aggiunta di pietre grosse può indurre la colonia a cercare riparo al di sotto di questa. Un modo di evitare tutto ciò è porre prima le pietre (incollandole magari al pavimento dell’arena, per poi disporre un sottile strato di terra, sabbia o altro materiale. Ricordiamoci infine che quasi sempre le operaie portano nel formicaio granuli di sabbia e pezzi di terra per coprire spifferi o il vetro di osservazione e aiutare le larve a creare i bozzoli.
 
Giusta alimentazione:
Non c’è al riguardo una linea precisa. Bisogna solo basarsi sulle esigenze della singole specie. Ciò di cui tutte hanno bisogno sono anzitutto:
1) Proteine (soprattutto regina e stadi larvali);
2) Carboidrati (soprattutto operaie);
Le fonti proteiche possono essere le più disparate. Le più comuni sono il latte, uova e gli insetti (questi ultimi sicuramente i più graditi e naturali … oltre che completi).


Riguardo ai carboidrati si usa soprattutto il miele che può essere lasciato in goccioline piccolissime poste su una piccola base lavabile o si può usare un batuffolo di cotone imbevuto di una soluzione di acqua e miele ( ideale per le specie più piccole che rischiano l’annegamento).

Infine ci sono gelatine per insetti e preparati casalinghi (Es. dieta Bhatkar), che offrono tutte le sostanze di cui necessita la colonia.
L’assunzione di insetti è comunque sempre consigliata per la ricchezza di proteine, carboidrati e micronutrienti.
Giusto grado di umidità:
Per alcune specie l’umidità non è un fattore importantissimo … ma per altre è essenziale. La Myrmica rubra, per esempio, richiede abbondante umidità del formicaio, mentre le Messor o le Camponotus vagus vivono bene anche in formicai più asciutti. Bisogna documentarsi bene su questo parametro così da decidere, in fase di costruzione del nido, quale metodo usare per creare il giusto tasso di umidità.

Si possono creare camere da riempire di acqua internamente al materiale o esternamente, si può usare una provetta attaccata ad una delle aperture del formicaio, si possono creare piedi da immergere in bacinelle o si può semplicemente versare dell’acqua nell’ arena. Esistono molte soluzioni ma, la più diffusa, è sicuramente la creazione di stanze isolate dal formicaio da riempire ogni tanto.
 
Giusta temperatura:
La temperatura è un fattore importante poiché stabilisce il grado di attività della colonia. Sicuramente far vivere la stagionalità (le 4 stagioni) è il modo più naturale per evitare brusche variazioni di temperatura (a volte letali), ma in cattività principalmente l’anno è diviso in due stagioni:
periodo di attività (primavera-estat-autunno con temperature tra i 20 e i 28 °C)
periodo di ibernazione (fine autunno-inverno con temperature dai 2 agli 8 °C)
Questi valori sono solo indicativi. Spesso colonie sono sopravvissute a giorni in cui le temperature sono scese sotto lo 0. Ma ricordiamo che anche quando la temperatura scende molto sotto lo 0, appena pochi centimetri sotto terra la temperatura è di diversi gradi sopra lo 0.
Cosa diversa sono le specie tropicali che, il più delle volte, richiedono costanti valori di temperatura durante tutto l’anno, ottenibili mediante l’uso di lampade riscaldanti, tappeti elettrici riscaldanti, cavetti riscaldanti, ecc.

Giusta luminosità:
La luminosità è uno dei fattori sui quali meno si sa. Che gioco ruoli e la sua importanza è ancora da capire appieno. Alcune specie amano il crepuscolo ed escono fuori in tarda serata o notte … altre preferisono ambienti molto luminosi.
E’ comunque sempre consigliabile dare alla colonia un “fotoperiodo”… così da riprodurre al meglio il ritmo giorno/notte.

I vetri del formicaio, soprattutto per le specie più sensibili alla luce, possono essere coperti con carta trasparente color rosso o essere coperti totalmente. Ma la maggior parte delle specie si abitua anche a non aver alcuna copertura.

In fase di fondazione, al contrario, è sempre meglio lasciare la regina al buio. Questo per causarle il meno stress possibile. Essendo sola è infatti più facilmente stressabile, poiché per istinto percepisce pericoli ovunque. Quindi conviene tenere la provetta contenente la regina in una scatola chiusa o in un cassetto.
Questa breve guida vuole gettare solo delle basi molto generiche al fine di capire meglio le schede di allevamento delle singole specie che troverete sul sito.

La mirmecologia è una branca della zoologia (studio degli animali e dei protozoi).
In particolare è un ramo della entomologia (studio degli insetti); la mirmecologia riguarda lo studio delle formiche a livello anatomico, fisiologico ed etologico.
Il mirmecologo è lo studioso di mirmecologia.
Storia della mirmecologia
I primi mirmecologi considerarono le colonie di formiche come forme di società ideali, e cercarono di trovare soluzioni ai problemi delle società umane attraverso lo studio delle colonie di formiche. Le formiche ancora oggi offrono agli scienziati molte risposte riguardo all'evoluzione dei sistemi sociali, grazie alle loro complesse e variate forme di eusocialità.
L'esistenza di numerosi e diversi tipi di formiche e la loro importanza all'interno degli ecosistemi hanno reso le formiche utili anche per lo studio della biodiversità e della tutela/conservazione di altri animali.
La parola mirmecologia fu coniata da William Morton Wheeler (1865-1937), anche se lo studio e l'osservazione delle formiche risale a tempi immemorabili, come testimoniano numerosi antichi documenti.
I primi veri studi scientifici basati sull'osservazione della vita delle formiche furono effettuati da Auguste Forel (1848-1931), psicologo svizzero interessato ai concetti di istinto, apprendimento e comportamento sociale. Nel 1874 Forel scrisse un libro sulle formiche del territorio svizzero: Les fourmis de la Suisse, e diede alla sua casa il nome La Fourmilière (il formicaio). I suoi primi studi riguardarono tentativi di unire diverse specie di formiche in un'unica colonia. Osservando la polidomia e la monodomia delle colonie di formiche, Forel paragonò la loro struttura a quella delle nazioni umane.
William Morton Wheeler osservò le formiche sotto una nuova luce, concentrandosi sulla loro organizzazione sociale e nel 1910 tenne la famosa lezione "La colonia di formiche intesa come organismo", che gettò le basi del concetto di super-organismo.
Wheeler considerò la trofallassi (ovvero il metodo di condivisione del cibo attuato dalle formiche) come caratteristica principale della società delle formiche. La trofallassi fu studiata aggiungendo coloranti alimentari al cibo offerto alle formiche, e osservando la diffusione del colorante all'interno della colonia.
Un altro pioniere della mirmecologia fu Horace Donisthorpe, col suo lavoro sulla sistematica delle formiche.
Lo studio della tassonomia e della sistematica delle formiche continua tuttora, stimolato dagli avanzamenti in altri campi della biologia. L'avvento della genetica, dell'etologia e della cladistica hanno fatto compiere alla mirmecologia passi da gigante; in particolare, il contributo del mirmecologo e premio Pulitzer E. O. Wilson ha portato alla creazione di un nuovo campo di studi: la sociobiologia.
  
Mini guida semplificata per la macro a cura di entoK, leggila sul forum! Ultimo aggiornamento (Sabato 15 Marzo 2014 14:58)

Nome: Camponotus cruentatus Tassonomia: Tribù: Camponotini Genere: Camponotus Sottogenere: Myrmosericus Areale di distribuzione: In Italia nel Nord-Ovest della Liguria, ampiamente diffusa nella Spagna continentale, zone costiere della Francia meridionale. Ginia: monoginica Regina: 16-18 mm, nera opaca con sfumatura arancione che si estende dal peziolo al primo tergite, colorazione arancione più meno evidente anche del femore. Le operaie medie e major hanno una colorazione di un tono più acceso. Maschio: 7.5 mm, nero opaco uniforme. Operaie: 6-15 mm. Sono presenti minor, medie e major con tutte le misure intermedie. Le minor sono tutte nere con una leggera sfumatura cinerea sul gastro, le medie cominciano ad assumere la sfumatura arancione caratteristica della specie, molto evidente e di colore più acceso nelle major che presentano anche un capo di dimensione massicce e possono essere considerati come soldati adibiti alla difesa. Alimentazione: in natura sostanze zuccherine prodotte dagli afidi e insetti di ogni tipo. In allevamento: miele diluito in acqua, melone; camole della farina, mosche, farfalle, drosophile, grilli, cavallette, blatte, tonno, prosciutto cotto, pollo, paté di pollo per gatti … Umidità: arena asciutta e nido per gran parte asciutto, leggermente più umido nella parte inferiore per uova e larve. I bozzoli vengono portati principalmente nelle camere superiori e meno umide. Temperatura consigliata: per lo sviluppo della covata, da 27 a 32°C costanti. A temperature di 23-24°C o inferiori si rischia di non vedere uno sviluppo apprezzabile, specialmente nella crescita delle larve. Ibernazione: da fine novembre a fine febbraio entra in diapausa, rallentando ogni attività, mantiene le larve inattive fino al risveglio primaverile. Necessaria una temperatura di 12-15°C, forse anche più bassa, ma non troppo (già a 15°C la colonia è ferma e non si alimenta “quasi per niente”). E' tuttavia una specie che potrebbe essere mantenuta abbastanza attiva anche nel periodo invernale (sconsigliato) se riscaldata. In natura, con l’arrivo dell’autunno, l’attività esterna è limitata alle ore centrali della giornata fino a cessare del tutto Nidificazione: prevalentemente nella terra asciutta sotto grossi sassi assolati sotto i quali portano la covata per approfittare del maggior calore. Nidi artificiali: gesso e gasbeton (ytong). A colonia matura (+ di 1000/2000 individui) aumenta il rischio che possano cavare il gasbeton. Preparare eventualmente nido con protezioni esterne. Difficoltà: passate le 50-60 operaie, se sottoposta ad elevate temperature costanti la regina comincia a deporre grandi pacchi di uova che svilupperanno presto nuova forza lavoro. Dopo il centinaio cominciano a nascere formiche di taglia superiore quindi sono da prevedere ampi spazi, specialmente in arena, dato che amano camminare a lungo. Da tenere conto anche la notevole lunghezza delle zampe e la grande velocità/agilità delle operaie. Un "soldato” di questa specie, taglia agevolmente a pezzi tutti gli altri tipi di formiche, e se riesce ad avere un buon appiglio può incidere anche la pelle umana. Dal punto di vista alimentare, ad un certo punto ci si trova ad avere centinaia di larve che necessitano di grandissime quantità di proteine perché dalle 300-400 operaie la taglia media aumenta notevolmente e il rapporto minor : medie : major pende molto verso le operaie maggiori. Le larve vengono alimentate moltissimo e si cominciano a osservare formiche di 13-14 mm. Comportamento e indole: specie inizialmente abbastanza timida, appena il numero delle operaie cresce diventa molto aggressiva nella difesa del territorio, dimostrando una vera ferocia nell'attaccare le prede. Tenere conto anche della grande quantità di acido formico che queste formiche possono produrre. Periodo di sciamatura: in Italia, nella Liguria occidentale, dalla metà di giugno alla fine di luglio. Sviluppo da regina fondatrice: a buone temperature la regina in fondazione può arrivare a 20-30 operaie per poi aumentare notevolmente già l’anno successivo. Consigliabile un riposo invernale per favorire una migliore partenza dal mese di marzo; il secondo anno superano tranquillamente le 500 operaie. Tempi di sviluppo: a temperatura ideale, circa 30°C: Uovo - larva: 16-20 giorni - Larva - pupa: 10-20 giorni (molto influenzata da: temperatura, umidità, numero di nutrici, disponibilità di fonti proteiche) - Pupa - adulto: 15-23 giorni (a seconda della taglia delle operaie: registrati 15-17 giorni per le minor, 17-20 giorni per le medie, 20-23 per le major). 

Ultimo aggiornamento (Martedì 08 Ottobre 2019 12:11)
La fase della fondazione è un momento cruciale e delicato della vita di una colonia.
La Regina, dopo l’accoppiamento, solitamente si stacca le ali (spesso anche a distanza di qualche giorno) e cerca immediatamente un luogo riparato dove passare le successive fasi, che possono durare parecchi mesi. Può rifugiarsi sotto una pietra, dentro una galla o, più comunemente, scavarsi un piccolo tunnel nella terra sigillando successivamente l’entrata.
Le regine delle diverse specie di formiche sciamano dalla primavera all’autunno, a seconda della specie. Ogni specie ha infatti periodi di sciamatura abbastanza definiti, che sono riassunti in questo schema.
Tali periodi sono comunque indicativi solo a livello generale, poiché non tengono in considerazione fattori ambientali quali la collocazione geografica della colonia madre, le variazioni annuali di temperature stagionali e i casi “eccezionali” (che, sebbene rari, si possono comunque presentare).
La maggior parte delle regine non si alimentano durante la fase di fondazione (fondazione in condizione claustrale). Alcune specie (ad esempio le appartenenti al genere Myrmica, Ponera e alcune Formica) fondano in condizioni di semi-claustralità, cioè la regina foraggia saltuariamente.
Quando troviamo una regina, la prima cosa da fare è quella di riprodurre le condizioni ideali perché essa inizi la fase di fondazione. Tali condizioni si ottengono mediante diversi punti essenziali:

1) Fornire alla regina un ambiente piccolo, nel quale possa sentirsi a suo agio e al sicuro come se stesse all’interno di un tunnel sotterraneo sigillato. Per fare ciò si può collocare la regina in una provetta: vanno bene sia in vetro che in plastica, e queste ultime sono facilmente reperibili in farmacia poiché usate per raccogliere i campioni di urina per le analisi.
2) Fornire un giusto grado di umidità. Questo lo si ottiene creando un serbatoio di acqua nel fondo della provetta. Per fare ciò si procede riempendo circa 1/3 della provetta con dell’acqua e creando subito dopo un “tappo” di cotone pressato il più possibile così da mantenere il serbatoio separato dallo spazio in cui sosterà la regina.

3) Chiudere l’entrata della provetta con del cotone non eccessivamente pressato, così da evitare che la regina possa scappare e fornendole un senso di protezione. La riserva di aria all’interno della provetta è sufficiente per i primi mesi, e comunque, dal cotone non eccessivamente pressato si ha un minimo di entrata di aria.
4) Porre la provetta in un ambiente buio e tranquillo (un cassetto, un armadio o una scatola) cercando di evitare di disturbare la regina: i controlli dovrebbero essere limitati ad 1 ogni 10-15 giorni circa.

Le regine di specie che fondano in condizione di claustralità non vanno mai alimentate fino alla nascita delle prime operaie.
Alle regine di specie che fondano in condizione di semi-claustralità andrebbe invece somministrato cibo di tanto in tanto (1 moscerino ogni 10-15 giorni è più che sufficiente) eliminando successivamente i resti.
Alla nascita delle prime operaie si può iniziare a somministrare, di tanto in tanto, una piccola gocciolina di miele (ad esempio immergendo nel miele la punta di uno stuzzicadenti e successivamente, dopo aver tolto l’eccesso, toccando appena la superficie interna della provetta) o un piccolo insetto (come un moscerino o una zanzara). Man mano che la colonia cresce si aumenta il numero di somministrazioni. Consideriamo che in natura la prima generazione di operaie è alimentata dalla regina e le operaie iniziano a girare in cerca di cibo quando sono circa 20-30. Quindi, inizialmente, non esageriamo con il cibo. Meglio darne un po’ meno che non rischiare di creare pericolosi inquinamenti della provetta con resti organici che potrebbero far morire la colonia.
Raggiunta una colonia di almeno 50-100 operaie (in base alla dimensione della specie) trasferirle in un formicaio di adeguate dimensioni: 5-6 stanze sono più che sufficienti.

Quest’ultimo passaggio può essere ottenuto in due modi:
1) Spostando la colonia in formicai via via più grandi man mano che la colonia cresce di numero;
2) Spostando la colonia in un formicaio grande al quale avremo chiuso l’accesso alle diverse stanze (eccetto 5-6) mediante tappi di sabbia compressa, sughero (per le specie che riescono a bucare il legno come Camponotus vagus, Camponotus ligniperda, Crematogaster scutellaris) o altro materiale per loro facilmente lavorabile e non tossico (nella foto sono le parti in giallo). La colonia, man mano che crescerà e si sentirà “stretta”, rimuoverà i tappi occupando le aree del formicaio inizialmente non accessibili.

Non va dimenticato che, sebbene in cattività la percentuale di successo in fase di fondazione è più alta che in natura, questa è una fase molto delicata e non tutte le regine hanno le carte in regola per riuscire nell’impresa. Morti improvvise non sono sempre sinonimo di errori da parte nostra.
cliccare sulle frecce a destra per scorrere la galleria di immagini.
Questo è un nido verticale che va bene per l'accrescimento iniziale di una giovane colonia (in base alla taglia della specie potrà contenere anche diverse centinaia di formiche). E' un nido molto economico (il costo totale del materiale si aggirerà sui 10 euro) ed è abbastanza funzionale.

Come base è stato usato un contenitore di plastica venduto nei supermercati per contenere la pasta. Solitamente è sempre meglio usarne due diversi, uno per lo stampo del gesso e l'altro per il vero e proprio contenitore (questo perchè il contenitore usato da stampo spesso si graffia e rovina).
Una volta preso il contenitore si procede come segue:
- Si prende il quantitativo necessario di acqua (in base al contenitore) e si miscela un colorante in polvere venduto proprio per colorare il gesso (lo si trova in colorificio e in alcune ferramenta). Il colore è un terra chiaro, così da far risaltare uova, larve, pupe e formiche scure. Questo colore non va bene per le formiche rosse.
- Si versa il gesso in polvere nell'acqua, arrivando quasi fino al livello dell'acqua stessa. Quindi si mescola e si cerca di ottenere una soluzione il più omogenea possibile e della giusta consistenza (prima di fare un nido definitivo fate qualche prova per capire qual' è la giusta consistenza...molto dipende, infatti, anche dal tipo di gesso usato).
- Versate rapidamente la colata di gesso nel contenitore di plastica le cui pareti ed il fondo sonos tate precedentemente spennellate con olio di vaselina.
- Lasciate asiugare un paio di giorni.
- Rovesciate il contenitore e dando qualche colpetto fate uscire lo stampo.
- Scavate con un cacciavite o un cucchiaio le celle e i cunicoli del formicaio (in questa fase il gesso è ancora abbastanza lavorabile).
- Lasciate asciugare per qualche altro giorno il gesso o ponetelo a cuocere in un forno a microonde.

In questo caso l'umidificazione del nido è realizzata mediante camera sul fondo (è sempre comunque consigliata una provetta nell'arena). Il nido è sollevato e poggia nell'acqua attraverso un piede centrale ricavato ponendo una lastra di polistirolo alla base del contenitore iprima della colatura del gesso. La lastra di polistirolo è bucata centralmente, così da creare un pezzo unico con il nido. Il riempimento avviene mediante un foro poco più in alto rispetto all' altezza massima di riempimento.
Purtroppo questo sistema di umidificazione ha lo svantaggio di rendere molto morbido il formicaio...quindi più facilmente scavabile. Non va quindi bene per specie che amano il secco e che facilmente scavano (come Messor, Crematogaster scutellaris, ecc...). Per queste specie è meglio toglierlo e sostituire il piede con uno spessore in plastica (così da sfruttare solo l'acqua che evapora dal serbatoio).
Va invece bene per specie da sottobosco, come le Myrmica rubra che amano l'umidità e non scavano molto.
Per le altre specie si può usare uno spessore in gasbeton di dimensioni più o meno grandi in funzione della quantità di umidità che vorremo far passare. Più è grande il pezzo di gasbeton, più rapidamente verrà umidificato il nido e con maggiore quantità di acqua.

L'arena si può arredare a piacimento. In fase di colatura si possono anche eseguire "rilievi" così da rendere l'arena più naturale. La parte in gesso è di circa 18 cm.
Vari lati:




Costo totale:
contenitore: 3,50 euro ;
Gesso: neanche 1 euro;
Colore: pochi centesimi (ci vuole giusto un cuccchiaio per ottenere questa colorazione);
Totale: meno di 10 euro.
Kibale Forest, Uganda
L’Africa, le formiche, le persone...
il mio viaggio, la mia avventura
di Ilaria Toni
Quando Fabrizio Rigato mi parlò per la prima volta del corso lo vedevo come un sogno irraggiungibile.
Mi hanno dato l’opportunità di viverlo e spero che quello che ho scritto trasmetta almeno un po’ di quello che ho provato e che ho imparato da questa grande esperienza.
Il Viaggio di andata: Entebbe, il Lago Vittoria e poi... la Foresta
A dire la verità non ricordo molto del viaggio di andata, solo il buio, la sonnolenza, il rumore delle ruote delle valigie, il suono di voci diverse e di diverse lingue e tutte queste persone in viaggio verso il continente nero.
All’aeroporto di Entebbe (Uganda) alle 4 del mattino ho incontrato Eunice, una ragazza che avrebbe partecipato al corso insieme a me e ci siamo dirette insieme verso l’albergo.
Quando siamo arrivate a destinazione era notte e abbiamo aspettato un po’ nella hall che si facesse giorno, poi appena abbiamo visto un po’ di luce siamo uscite ed è stato magico trovarsi di punto in bianco sulle sponde del Lago Vittoria; Il lago di cui avevo sempre sentito parlare fin dalle lezioni di geografia delle superiori o di cui avevo letto sul National Geographic.
Quella mattina, Eunice ed io, siamo andate a fare un giro sulla spiaggia e lungo le strade di Entebbe. E’ stato allora che ho notato l’innumerevole quantità di motociclette presenti, che credo siano per gli uomini della città una specie di Status Symbol. Ho capito dove sono finite tutte le cafe racer anni ’70: In Uganda.

Abbiamo passato la notte all’hotel e la mattina, dopo aver caricato le valigie su uno dei due pulmini che avremmo usato, siamo partiti alla volta della Kibale Forest situata nel Kibale Forest National Park.

Durante il tragitto, che è durato circa sei ore, non ho parlato molto e sono rimasta a fissare dal finestrino i paesaggi e le persone che si susseguivano lungo la strada. Tante persone, moto e macchine, mercati con tantissima frutta, fumo e polvere, tanti bambini a piedi nudi lungo la strada che ti salutano. Non appena arrivati abbiamo messo le valigie nelle camere e ci siamo riuniti vicino all’edificio che ospita il laboratorio per sentire il discorso di presentazione di Brian Fisher e del direttore della Biological Station. Il primo discorso di benvenuto ha segnato l’inizio del corso, che seguendo una precisa scaletta, è durato ben 10 giorni, intensi, ma non stancanti. La cosa più bella che questi giorni mi hanno lasciato è stata una nuova carica energetica per vivere a pieno questa passione per gli insetti e la natura.




L’aspetto comunicativo: fotografia e social media per far avvicinare le persone al mondo delle formiche
Alex Wild è il mirmecologo-fotografo della spedizione. Durante tutto il corso ci ha assistito da tutti i punti di vista e ci ha seguito giorno per giorno fotografando i vari momenti e le varie persone. Il 10 Agosto (il 4° giorno) ha tenuto una lecture sull’argomento: fotografia e media per promuovere la biodiversità.

E’ stato molto interessante e dalle sue parole è emersa una grande passione sia per la fotografia sia per il mondo degli insetti, una passione contagiosa in grado di regalare nuova voglia di scoprire, di informarsi ma anche di comunicare i nostri pensieri, le nostre ricerche, le nostre anche piccole scoperte. Su quest’ultimo punto si è soffermato in particolare, dando enfasi al fatto che molte persone sono completamente estranee al mondo degli insetti e che è importante che chi invece ne è immerso e lo vive giorno per giorno comunichi con la gente, perchè questo è l’unico modo che abbiamo per fare capire agli altri quanto la vita degli insetti (e delle formiche in particolare) può essere magica e stimolante.
Alcuni siti interessanti
Myrmecos.net (il blog di Alex, che ho notato essere già tra i link di formicarium.it)
Alexanderwild.com (il sito di Alex, con le sue foto e i suoi commenti)
http://llama.evergreen.edu (il sito del progetto svolto in Centro America da Jack Longino sugli Artropodi della lettiera)
Alcuni siti per aprire un proprio blog
Wordpress.com
Sibblog.com
Gli Studenti
E’ stato molto bello e stimolante venire in contatto con così tante persone provenienti da varie parti del mondo, tutte così appassionate e piene di energia. Forse 10 giorni o poco più sono pochi per poter veramente stringere dei legami, ma penso che gli obiettivi e gli interessi comuni siano un legante fortissimo. Una delle cose che Brian ripeteva più spesso era l’importanza di parlare tra di noi e crearsi dei contatti, perchè uno degli obiettivi del corso era proprio quello di far entrare in contatto persone che lavorano nello stesso campo e che con ogni probabilità saranno colleghi in futuro.
Lucila (Argentina) Caswell (Sud Africa) ed Eunice (Singapore) sono state le persone con cui ho trascorso la maggior parte del tempo e quelle con cui ho parlato di più.
Eunice, in particolare, è stata la prima ragazza che ho conosciuto, perchè ci siamo incontrate all’aeroporto di Entebbe alle 4 del mattino, il giorno prima dell’inizio del corso. E’ stata la persona alla quale mi sono sentita più vicina e spero di rivederla un giorno. Era la più giovane partecipante al corso ed è una grande appassionata della natura e delle formiche, dotata di metodo, dedizione, determinazione e grande intelligenza. Mi disse che, una volta tornata a casa, avrebbe lavorato per realizzare la checklist delle formiche di Singapore e credo proprio che presto la vedremo pubblicata.
Le Formiche e come raccoglierle
Essendo un corso su base tassonomica le nostre attività principali sono state:
- raccogliere le formiche (facendo pratica delle diverse tecniche disponibili normalmente utilizzate);
- determinare gli esemplari (almeno a livello di genere) una volta tornati in laboratorio.
Durante tutta la spedizione Brian era alla ricerca di un genere in particolare, quello che è diventato per noi mitico, del quale sono stati raccolti prima dei maschi vivi attraverso raccolta diretta e poi delle operaie grazie ai Winkler sample. Le formiche in questione fanno parte della sottofamiglia Aenictogitoninae, genere Aenictogiton.







Un giro lungo la strada verso il villaggio... raccogliendo qua e là:
Meranoplus e Rhoptromyrmex
Anche io ho avuto la fortuna di fare una raccolta abbastanza interessante. Uno degli ultimi giorni siamo andati a fare un giro lungo la strada che collega la Makerere University Biological Station con il villaggio vicino. E’ stato molto divertente e lo ricordo come uno dei momenti più belli. Camminavamo raccontandoci i vari episodi divertenti e Caswell ci spiegava e ci indicava la specie delle varie formiche che incontravamo. Raccoglievamo qua e là alla ricerca di operaie di Meranoplus ed oltre a queste ultime ho raccolto quello che pensavo fossero dei Tetramorium, ma una volta in laboratorio Brian mi disse che erano invece operaie di Rhoptromyrmex, un genere opportunista che non possiede una propria colonia ma “si appoggia” a colonie di Tetramorium.

Trap Jaw ants: Formiche dalle mandibole a trappola
Ho raccolto anche formiche dei generi Odontomachus, Microdaceton (le cosiddette “trap-jaw ants”) e Strumigenys. Devo dire che ne sono rimasta particolarmente affascinata, per il loro particolare metodo di catturare le prede ma anche per la loro morfologia e la scultura.


Andrew Suarez ci ha fatto una presentazione sulle trap-jaw ant, facendoci vedere anche un video veramente impressionante dove veniva messa in evidenza la grande forza che queste formiche possono sprigionare azionando le loro mandibole, un meccanismo che utilizzano per predare e per fuggire dal pericolo (Patek, S.N., Baio, J.E., Fisher, B.L., and Suarez, A.V. (2006) Multifunctionality and mechanical origins: ballistic jaw propulsion in trap-jaw ants. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 103, 12787-92).
The Sausage Ant: il maschio del genere Dorylus

Jack Longino: istruzioni pratiche per la caccia alle formiche
Jack Longino è stato il professore che ha dato il via alle lezioni previste durante il corso, partendo quindi dalle basi: come trovare e raccogliere le formiche. Con questa affermazione: “Il censimento faunistico (inteso come lista delle specie presenti in un’area ben definita) riveste una grande importanza perché fornisce dati per studi ecologici e biogeografici; per esempio, in genere fornisce il dato basilare per studi di altro tipo, perciò è un servizio che viene offerto alla ricerca.”
Per raccogliere le formiche bisogna sapere innanzitutto dove trovarle, infatti esistono specie arboricole (che vivono soprattutto sugli alberi e sulla chioma), specie che si trovano soprattutto al suolo, a livello della lettiera oppure sotterranee (fino ai primi 15 cm di profondità), specie che creano la loro colonia all’interno dei rami (secchi o vivi) ed esistono anche altre tipologie come: formiche scacciatrici, infestanti, simbionti di piante, parassite e i riproduttori alati che naturalmente possono essere raccolti in volo.
Il metodo del Winkler sample è probabilmente il più adatto per ottenere un alto numero di specie, ma in realtà il miglior metodo per poter analizzare a fondo un’area in termini di specie presenti è utilizzare il maggior numero di metodi diversi (controllare alberi recentemente caduti e le banchine, utilizzare sempre la lampada frontale, controllare sotto le rocce, nel legno morto, uscire di notte e utilizzare vari tipi di trappole).
Una tecnica per localizzare le colonie è quella di preparare un attrattivo (zucchero, olio, proteine), aspettare le operaie e seguirle poi fino alla colonia. E’ stato molto divertente quando Jack ci ha raccontato di come alcune volte bisogna aspettare e avere pazienza, perchè alcune operaie pare quasi che si accorgano di essere pedinate e prima di ritornare alla colonia sembrano vagare in direzioni casuali per un po’.
Si è parlato anche del problema delle specie introdotte (Pheidole megacephala, Linepithema humile, Anoplolepis gracilipes, Wasmannia auropunctata, Solenopsis invicta) e del perchè queste specie hanno un così grande successo (il fatto che siano specie generaliste, di piccole dimensioni ma presenti in grandi numeri, con alto potenziale riproduttivo, spesso presentano unicolonialità e poliginia, sono buone competitrici, più aggressive rispetto alle specie native e non hanno nemici naturali nei luoghi di introduzione).
A partire da questo problema conservazionistico abbiamo parlato di una condizione particolare che rende vulnerabili alcuni ecosistemi: la bassa resistenza biotica, cioè una bassa biodiversità (numero di specie presenti).
Infatti le comunità indisturbate, ricche di specie e perciò di interconnessioni, hanno meno invasori.
Per la prevenzione delle invasioni sono importantissimi i dati di intercettamento cioè i dati raccolti alle frontiere (prima che gli individui possano entrare in nuovi paesi).
Altro aspetto importantissimo: il quaderno di campo. Deve essere infatti compilato il più dettagliatamente possibile e in modo preciso e immediato dopo ogni singolo campione raccolto. Durante il corso ho aggiunto alle mie precedenti conoscenze il fatto di come sia più immediato e pratico utilizzare un “numero di collezione” che è associato alla singola raccolta e che viene riportato sul cartellino nella provetta e sul quaderno di campo, affiancato a tutti i dettagli.

Phil Ward e Leeanne Alonso
Due nomi che per me sono sempre stati due nomi stampati sui libri in biblioteca, nomi di personaggi mitici e indefinibili. E’ stato bello vederli dal vivo e rendersi conto che sono persone normali e simpatiche, che ballano alle feste e che sono allo stesso tempo il punto di riferimento per le ricerche sulle formiche.
Leeanne Alonso è una persona molto propositiva ed intelligente, perciò è una dei professori che più ho apprezzato. Si occupa soprattutto di sviluppare quel campo della mirmecologia che vede le formiche come bioindicatori (vi segnalo il libro credo più significativo da questo punto di vista: “Ants: Standard Methods for Measuring and Monitoring Biodiversity”).
E’ stato molto stimolante anche l’incontro che Leeanne e Christian Peeters (unaltro istruttore) hanno deciso di organizzare uno degli ultimi giorni , incontro aperto a tutti quelli che avessero voluto partecipare, per fare una specie di “brain storming” e interagendo, tra domande e proposte, potessimo pensare ed esporre nuove idee su come utilizzare le formiche come bioindicatori.
Uno dei punti più interessanti per me è stato rendersi conto di come le formiche possono essere associate alle piante, a causa della loro organizzazione in colonie, per cui possono essere considerati come organismi sessili. Perciò spesso le analisi che utilizzano le formiche come bioindicatori prendono spunto dai metodi utilizzati dai botanici.
Leeanne ha pure tenuto una lezione in cui si parlava di conservazione delle formiche, per cui ci ha illustrato le più serie minacce alle formiche (per esempio: intensificazione agricola, cambiamenti nel microclima, variazioni nella composizione delle comunità) e le tipologie di formiche che sono maggiormente minacciate, in quanto più vulnerabili a questi cambiamenti (i mutualisti/parassiti, le formiche di altitudini elevate, le formiche scacciatrici e quelle con le regine attere).

Le formiche meritano attenzione dal punto di vista conservazionistico perchè in base alla loro biomassa e alla loro attività hanno grande impatto sull’ambiente e modificano perciò i servizi che l’ecosistema fornisce alle altre specie (uomo compreso).
Negli ambienti tropicali, le formiche compiono il lavoro che di solito negli ambienti temperati è riservato ai lombrichi, cioè il movimento del suolo, e hanno un ruolo importante anche nell’aerazione dello stesso, nel mixaggio dei nutrienti nella pulizia del materiale organico e nella predazione su specie dannose per i raccolti.
Il punto chiave da analizzare riguarda come i gruppi funzionali possono essere messi in relazione con i singoli servizi dell’ecosistema, per poi poter mettere in relazione la comunità delle formiche con lo stato dell’ecosistema stesso.
Phil Ward, professore al dipartimento di entomologia dell’università della California a Davis, è il punto di riferimento per la sistematica delle formiche e quindi è spettato naturalmente a lui introdurci alle basi della morfologia, sistematica e filogenesi del gruppo.

Una cosa che mi ha colpito è che mentre ero ancora in Italia e mentre tutti discutevano via e-mail sul problema ebola e sul fatto di andare o non andare (infatti poco prima che partissimo si sono verificati due focolai di ebola nel distretto vicino a dove dovevamo recarci), ho ricevuto l’e-mail con in allegato i pdf che riguardavano la sua lezione. In poche parole ha chiarito la sua opinione sul fatto di fare o non fare il corso.
Morfologicamente parlando, le formiche non sono altro che vespe altamente modificate; quindi i termini morfologici per definire le parti anatomiche sono gli stessi utilizzati per gli imenotteri in genere.
Il contesto e le tempistiche concesse al professor Ward per parlare di ciò di cui si occupa non erano minimamente sufficienti neppure per un’introduzione generale, però è stato lo stesso molto interessante poichè ci ha spiegato molto bene in che cosa consiste il lavoro del tassonomo.
Walt: dentro i nidi...
Walter Tschinkel (Department of Biological Science Florida State University) ha tenuto una presentazione sull’architettura sotterranea dei nidi delle formiche. Partendo dal fatto che, seguendo il concetto del superorganismo, la selezione naturale a livello di colonia supera la selezione naturale che opera a livello di organismo, ci ha spiegato gli innumerevoli aspetti dell’importanza insita nella morfologia del nido. Il nido fa parte del fenotipo: è soggetto a selezione naturale, è specie-specifico ed è il risultato di schemi comportamentali.

Tutti i nidi sono variazioni, specie specifici, al tema ancestrale che li accomuna: il modello a camera e a corridoio.
Molti, anche se non tutti i nidi, sono più sviluppati nella parte superiore e la forma non cambia al crescere della colonia.
Alla domanda: cresce più velocemente il nido o la colonia? Si risponde sempre grazie a degli studi effettuati da Walt per cui si è reso conto di come colonie più grandi hanno una maggior densità.
Le colonie sono organizzate verticalmente secondo lo stadio vitale: mano a mano che le operaie invecchiano si spostano verso la zona più alta, più vicina alla superficie. E questa organizzazione funziona perchè i singoli individui sanno bene dove si trovano.
... e dentro le formiche
Devo dire che questa è la parte di laboratorio che meno mi ha entusiasmato, forse perchè nelle scuole italiane non si usa dissezionare gli organismi per studiare e vedere coi propri occhi la struttura interna.
Dissezionare una femmina di Camponotus è stato per me tutto sommato interessante, anche se la mia totale inesperienza nel campo non mi ha permesso di fare un ottimo lavoro e sono riuscita a vedere chiaramente solo poche parti interne: i corpi grassi (fat bodies) che hanno funzione di depurare dalle tossine oltre alla normale funzione metabolica di conversione e immagazzinamento dei grassi e delle proteine e lo stomaco sociale.
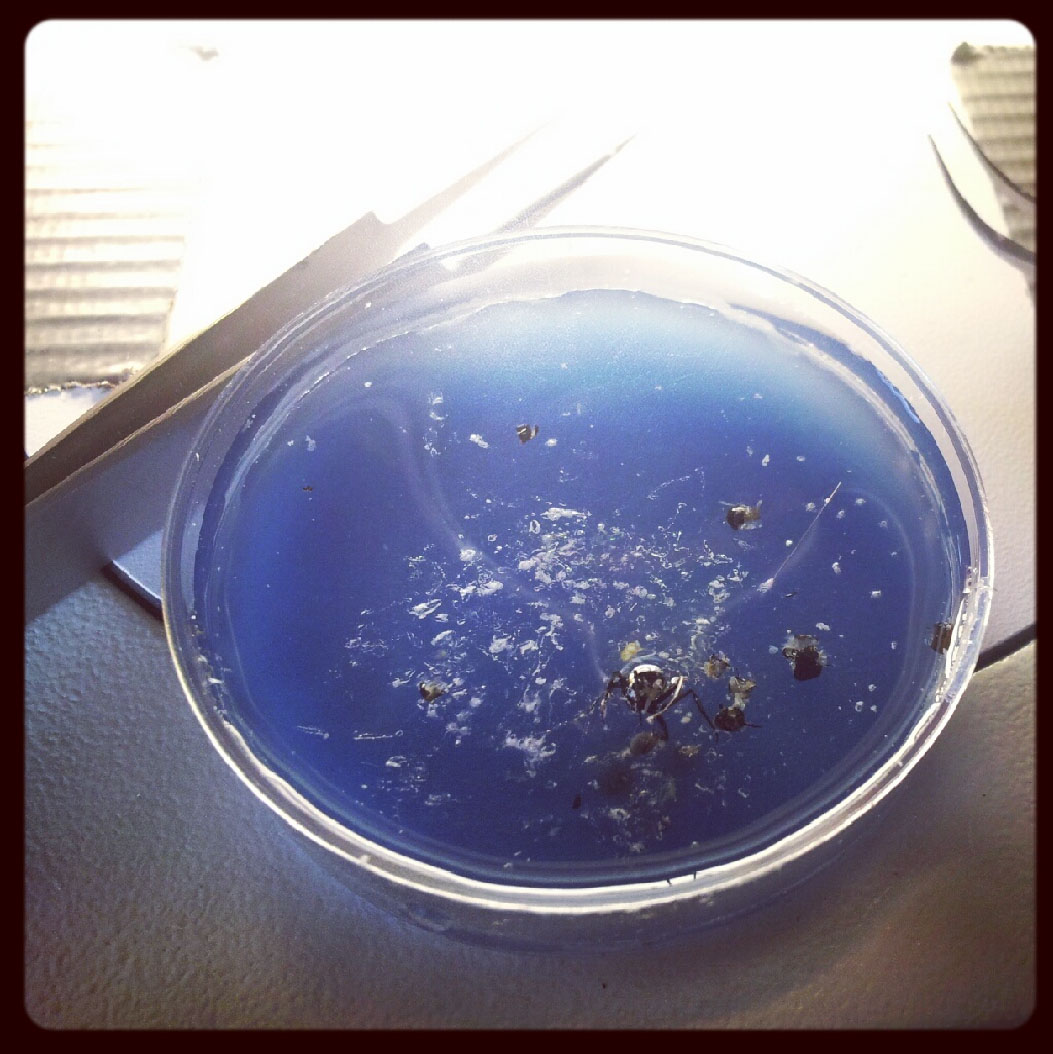
La vita alla Biological Station e il laboratorio
Alla Biological Station abbiamo avuto tutto quello di cui avevamo bisogno, ottimo cibo, acqua calda e ottima sistemazione per la notte. Tra l’altro su ogni letto avevamo le zanzariere, ma credo che non fossero strettamente necessarie. L’unica cosa che mi aveva fatto veramente paura erano le mango flies (Ditteri Calliforidi) che depongono le uova sui vestiti bagnati stesi al sole facendo sì che le larve appena schiuse penetrino sotto pelle una volta che i vestiti sono indossati. La soluzione più semplice è stirare i vestiti prima di indossarli, perchè il calore uccide le uova. In realtà parlando con le persone della Stazione mi hanno detto che eravamo già troppo in quota per questi ditteri e che non c’era un vero pericolo. Ad ogni modo dopo aver lavato i miei vestiti li ho accuratamente stirati, ma non ho avuto il coraggio di mettermeli prima che fossero passati 4 giorni (il tempo di sviluppo delle uova).


Il laboratorio rappresentava la nostra “piazza” centrale, per cui tutta la vita alla Biological Station girava attorno a questo luogo; qui abbiamo passato la maggior parte del tempo e qui ho avuto modo di conoscere gli altri studenti e gli assistenti. Alla fine quando abbiamo messo via gli steremicroscopi, spostato i tavoli e pulito tutto, ho pensato e mi sono resa conto che veramente tutto stava per finire.
Non saprei bene come concludere il mio racconto, so solo una cosa: che sono partita con una gran confusione in testa e sono tornata con le idee molto più chiare su quello che voglio fare e con la profonda volontà di farle al meglio.
Consiglio a tutti di cercare di fare esperienze come queste perchè aprono la mente e infondono grande energia.
Oltre ad aver approfondito le mie conoscenze, questa esperienza mi ha dato nuovi stimoli a continuare su questa strada spesso difficile, continuare a lavorare per la salvaguardia degli insetti e del loro habitat... ma soprattutto per le rispettabili, instancabili, determinate, intrepide (e perciò capaci di cose straordinarie)... formiche.

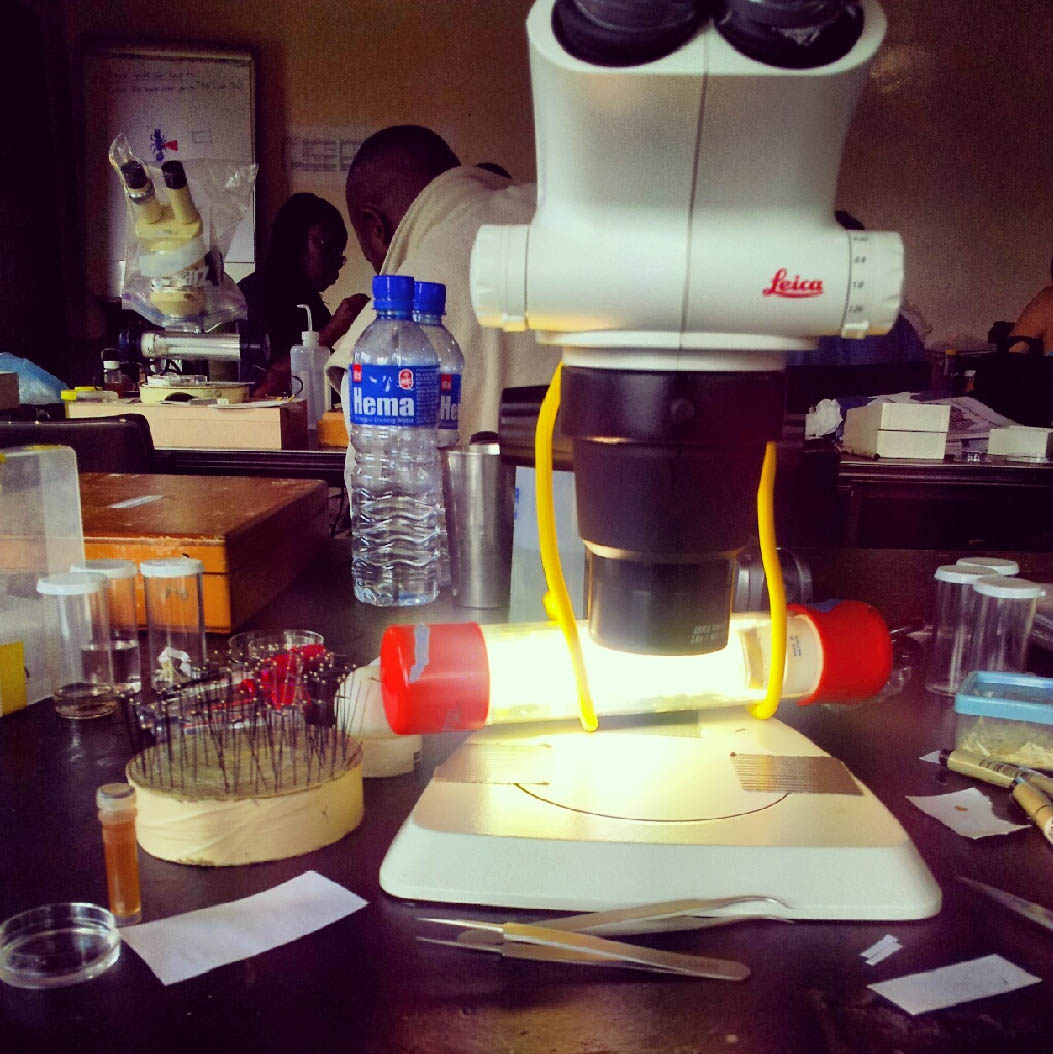

Il corso si è tenuto presso:
Makerere University Biological Station
P. O. Box 409,
Fort Portal, Uganda.
Si trova a 20 Km daFort Portal, ben attrezzata e gestita da personale preparato e cordiale, ospita ogni anno numerosi ricercatori da tutto il mondo.
Grazie a Giovanni Bertazzoli, Fabrizio Rigato, Sönke Hardersen, Brian Fisher con tutto lo staff e (come al solito) a mia madre e mio padre che mi hanno dato l’opportunità di vivere anche questo sogno.
Ilaria Toni
Laurea in Biologia Ecologica, Università degli Studi di Parma.
Attualmente lavoro come OTD presso il Centro Nazionale Biodiversità Forestale “Bosco Fontana” Verona
(Corpo Forestale dello Stato), per maggiori informazioni sulle nostre ricerche:
http://www.corpoforestale.it/cnbfverona
Per qualsiasi cosa potete contattarmi all’indirizzo:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Ultimo aggiornamento (Martedì 05 Marzo 2013 12:37)

Nome: Messor barbarus Sottofamiglia: Myrmicinae Genere: Messor Areale di distribuzione: In Italia è presente nella sola Liguria occidentale, mentre è comune in Spagna e sulle coste Mediterranee della Francia. Ginia: Monoginica Periodo di sciamatura: Da settembre a fine ottobre
. Stile di fondazione: Indipendente. Niente alimentazione. Deposizione e prime operaie alla primavera successiva. Regina: Dimensioni 15-16 mm. Massiccia, colore variabile con torace e gastro nero, e spesso col capo rosso scuro, tonalità che è possibile riscontrare a volte anche nel gastro; esistono rari casi di regine con tonalità interamente rossastra, ma si possono trovare regine interamente nere. Relativamente poco pelosa. Operaie: Dimensioni variabili da pochi millimetri a circa 14 mm per le major più grandi. Colore marrone scuro tendente al nero nelle operaie minori, mentre le operaie maggiori hanno spesso il capo rosso, da acceso a cupo, percettibilmente più tondeggiante che in Messor ibericus (ex structor). Sono presenti tutte le taglie intermedie. Longevità della regina: circa 15 anni Longevità delle operaie: circa 2 anni Alimentazione: Prevalentemente semi di diverse piante selvatiche e da coltivazione, cereali (anche semi da erba); sono molto graditi gli insetti e nelle colonie adulte è possibile fornire miele diluito, meglio se su supporti come cotone, o frutta (spesso però tendono a coprirlo e ignorarlo), gradiscono la frutta dolce. In allevamento la colonia con le prime operaie può essere alimentata con semi di tarassaco o semi da erba, che anche le operaie più piccole possono triturare. In realtà, una volta trasportati i semi nel nido, la regina stessa può contribuire a sbriciolare i semi che le operaie non riescono ancora a intaccare. Raccomandabili proteine animali costituite da insetti morbidi come farfalle, camole, grilli, ragni. Possono essere un'ottima base proteica alimenti comuni di altro genere come prosciutto cotto (schegge molto piccole), pollo e tonno. Frutta dolce molto matura, ma anche mele e zucchine. Nidi naturali: scavati nel suolo in profondità, molto estesi, con poche uscite concentrate. Nidi artificiali: Gesso e gasbeton sono i più usati e funzionali, ma fare particolare attenzione alla possibilità che scavino entrambi (il gesso solo se ammorbidito dall’umidità). Prevedere quindi un discreto spessore fra il perimetro delle gallerie e l’area coperta da vetrata. Tendono a scavare dove sentono umido, quindi nei bordi esterni in basso dei nidi verticali; evitare lì abbozzi di scavo che potrebbero essere invitate a seguire. Meglio arrotondare lo scavo. Temperatura di sviluppo ottimale: 25 - 35 ° C Umidità: Nido tendente al secco, l'umido eccessivo farebbe germogliare i semi accumulati. Le operaie portano volentieri i semi presso le fonti umide, sembra lo facciano per ammorbidirli. Prevedere sempre una zona dove la colonia può comunque trovare da bere, ma lasciare all’asciutto almeno il 70% del nido. Arena esterna: asciutta, prevedendo di poter pulire spesso il substrato. Queste formiche sporcano molto con gli scarti dei semi e tengono delle vere e proprie aree cimitero che sono solo colline dei rifiuti. Periodo d’ibernazione: Non obbligatorio, ma consigliato almeno per un breve periodo. Portare la colonia a 5-15 gradi per circa 2 mesi favorisce la deposizione primaverile e il riposo della regina. Tempi di sviluppo covata: Da uovo a larva: circa 9-18 giorni - da larva a pupa: circa 12-15 giorni - da pupa ad operaia: circa 10-15/20 giorni.
La crescita è influenzata sia dalla temperatura, che dallo sviluppo in minor o major dell’operaia. Particolarità: Allevamento semplice, colonie popolose necessitano spazio una volta sviluppate. Morso innocuo, veleno da contatto delle operaie, repellente e poco efficace. Timide e poco veloci, ma testarde quando iniziano a scavare. Producono grandi quantità di rifiuti che tendono ad accumulare in un angolo dell'arena, ma attenzione: se trovano spazio nel nido, possono accumularlo nelle stanze sporcandole e rendendole col tempo inservibili e impossibili da pulire. A questo proposito va previsto il cambio del nido almeno ogni uno-due anni. 
Ultimo aggiornamento (Mercoledì 17 Aprile 2019 20:59)
Spesso ci chiediamo quali siano i passi giusti da fare per portare la nostra piccola e solitaria regina a formare una colonia ben sviluppata.
Gli ostacoli contro cui ci dobbiamo scontrare, soprattutto all’inizio, sono numerosi.
La fine dell’acqua nel serbatoio, le fughe dalle operaie dalla provetta mentre somministriamo cibo e la formazione di muffe e colonie batteriche nella provetta costituiscono solo alcuni dei problemi riscontrati nelle prime fasi di sviluppo della colonia.
Le domande che più generalmente ci si pone, sono:
- Come faccio a riempire il serbatoio dell’acqua senza causare stress alla mini colonia?
- Come faccio a cambiare il cotone della provetta che è ammuffito?
- Come faccio a dare cibo alle poche operaie senza che mi escano dalla provetta?
- Quando devo iniziare a dare da mangiare?
- Quando posso spostare la colonia in un vero formicaio?
- Quanto deve essere grande?
In questo articolo descriverò le fasi e le procedure che seguo nell’accrescimento di una colonia sulla base dell’ esperienza maturata dall’allevamento di diverse decine di specie differenti. Non è il solo modo di far sviluppare una colonia di formiche…ma, a mio avviso, è quello più semplice e sicuro da seguire.
Tutto ha inizio con il ritrovamento della nostra regina. Come prima cosa la poniamo in una provetta, preparandola seguendo i passi descritti nell’articolo “fondazione di una colonia”.
In questa fase, per le regine che fondano in claustrale, non bisogna assolutamente dare cibo mentre alle regina che fondano in semiclaustrale potremo dare un insettino una volta ogni 2-3 giorni .
Dopo diverso tempo potremo già riscontrare i primi problemi, come la fine dell’acqua nel serbatoio o l’ammuffimento del cotone dello stesso (soprattutto se avremo dato qualcosa da mangiare alla regina e questa non lo avrà consumato).
In caso queste cose avvengano quando abbiamo solo la regina, la cosa migliore e unire alla vecchia provetta una nuova ripreparata correttamente. Posta la nuova provetta davanti la precedente (tenendole unite con poco nastro isolante) si può indurre il trasloco oscurando la nuova provetta e ponendo la vecchia sotto una lampada:




Se invece abbiamo una mini colonia di una decina di operaie (a cui avremo fino ad ora dato qualche gocciolina di miele di tanto in tanto all’interno della provetta), la cosa migliore è porre la provetta aperta in una piccola arena al cui interno avremo posto un serbatoio di acqua costituito da una boccettina con l’imboccatura tappata con del cotone o una eppendorf chiusa nello stesso modo.
Provetta appena aperta in arena:

Il vantaggio di questa soluzione sta nell’assenza di stress per la colonia (si evitano continui traslochi), nella possibilità di riempire il serbatoio dell’acqua senza andare attorno alla colonia e nella possibilità di alimentare le operaie senza rischiare fughe e/o stress (è già arrivata, infatti, l’ora di dare i primi insettini alla colonia). Inoltre le operaie avranno la possibilità di portarsi nella provetta il cibo per poi buttare fuori gli avanzi, evitando contaminazioni interne, sporco ecc…
Se si pone un lieve strato di terra nell’arena, questa verrà accumulata all’imboccatura della provetta come un tappo. Le operaie apriranno e chiuderanno l’ingresso a piacimento in funzione delle esigenze della colonia.
Quando la colonia avrà raggiunto le 50-100 operaie (e nella provetta non ci sarà più spazio), sarà possibile trasferirla in un primo formicaio di accrescimento.
Colonie quasi pronte al trasferimento in formicaio artificiale:


Quello più pratico e che preferisco è la “variante 2” (http://formicarium.it/index.php/costruire-un-formicaio/58-costruire-un-formicaio-in-gesso-variante-2 ) con al massimo 2 stanze per lato.
In caso di specie arboricole, al posto della "variante 2" in gesso, si può costruire un piccolo nido in legno con un paio di stanze...proprio come questo:

Per traslocare la colonia sarà sufficiente rovesciare la provetta nell’arena del formicaio…o semplicemente porre la provetta aperta nell’arena, lasciando poi alla colonia la decisione di quando spostarsi.
Regina e parte delle operaie appena inserite nel nuovo formicaio:

E’ molto importante ricordarsi che porre una colonia piccola in un formicaio grande può essere controproducente e costarci la colonia stessa. Spesso, infatti, poste in un ambiente esageratamente grande, la regina smette di deporre e la colonia lentamente regredisce. Le formiche, in natura, occupano ambiente angusti e vivono ammassate le une alle altre. Quindi meglio il sovraffollamento che non il troppo spazio libero.
Questo è un esempio di quanto fitte possono stare le formiche in una stanza:

Prima di spostare nuovamente la colonia dovrete avere tutte le stanze così piene.
Quando la colonia avrà raggiunto diverse centinaia di operaie (in base alla specie) e lo spazio vitale sarà ormai completamente occupato, si potrà spostare la colonia in un formicaio più grande (sempre una variante 2 o un altro tipo di formicaio). Solitamente, in funzione della specie, ci vuole quale anno per arrivare a questo stadio. Il trasloco può essere fatto semplicemente unendo due formicaio con un tubo e aspettando che la colonia vi si trasferisca (o forzandola lasciando asciutto o eccessivamente umido il vecchio formicaio e/o riscaldandolo).


Il gasbeton, detto anche ytong, calcestruzzo aerato autoclavato, gasbeton, o bitume cellulare (o nomi similari), è un materiale ormai diventato di uso comune presso tutti gli allevatori che scelgono la strada del nido artificiale a vista completa. Ytong è solo la marca francese di questo materiale, che in Italia è acquistabile con pochi euro al blocco presso i rivenditori di materiale edilizio.
 Il vantaggio di questi blocchi è la facilità di lavorazione. Si scava, si taglia e si fresa con strumenti alla portata di tutti. Basta un cacciavite, o un coltellino, o qualsiasi altro oggetto adatto per incidere una galleria. Certo è preferibile utilizzare uno strumento elettrico quando si devono mettere in opera nidi di una certa dimensione e con stanze ampie, ma con un normale trapano si scava un intero blocco (misura massima cm 60 x 25, x 8 cm di spessore) in maniera eccellente in poche ore di lavoro. Il vantaggio di questi blocchi è la facilità di lavorazione. Si scava, si taglia e si fresa con strumenti alla portata di tutti. Basta un cacciavite, o un coltellino, o qualsiasi altro oggetto adatto per incidere una galleria. Certo è preferibile utilizzare uno strumento elettrico quando si devono mettere in opera nidi di una certa dimensione e con stanze ampie, ma con un normale trapano si scava un intero blocco (misura massima cm 60 x 25, x 8 cm di spessore) in maniera eccellente in poche ore di lavoro.
A questo punto non mi soffermerei tanto su come eseguire il lavoro manuale in quanto tale. È ovvio che la fantasia della planimetria del nostro formicaio ideale è soggettiva, e possiamo decidere quante gallerie e stanze vorremo realizzare anche a seconda delle dimensioni del blocco che utilizzeremo. Ma prima di armarci di ruspe e di metterci a scavare, sarà bene tracciare a matita la pianta e tenere d’occhio alcune regole fondamentali che devono essere considerate nell’uso di questo materiale. Uno dei difetti dell'ytong è la tendenza, nel tempo, a trasudare sostanze bianche che non devono essere scambiate per muffe. Si tratta di sali minerali che si formano per le differenti condizioni interne del nido, come sbalzi di umidità e rapide asciugature. Di solito la colorazione della superficie limita queste essudazioni, ma alla lunga finiranno per apparire. Sembra che queste si formino comunque solo sulle superfici esposte all'aria, quasi mai all'interno. Per ovviare a questo problema si possono schermare le superfici con plexiglass, cosa che limita anche i rischi di fuga in caso di scavo. Il dubbio in questo caso è che il gasbeton non traspiri più come dovrebbe, ma diverse esperienze testimoniano che, sia la colorazione (anche interna delle stanze), che l'inserimento in una "scatola” di vetro, non creano problemi, a patto di lasciare almeno una superficie libera (di solito la parte superiore, dove può appoggiare l'arena, e la parte inferiore, appoggiata in una bacinella di umidificazione). Altra cosa molto importante: dopo qualsiasi operazione di scavo del nido, BISOGNA ASSOLUTAMENTE LAVARE BENE IL BLOCCO, anche più volte, per evitare la finissima polvere che si deposita durante il lavoro. Questa polverina invisibile e impalpabile può danneggiare seriamente gli abitanti, se l'operazione non viene eseguita a dovere: potrebbe soffocare le formiche chiudendo i pori respiratori in pochi giorni. Nei nidi verticali la capacità capillare di pompare l'acqua dal basso verso l'alto è notevole, consentendo alle formiche di poter accedere a tutte le possibili condizioni ideali, da molto umido ad asciutto, ma va tenuto presente che tutto dipenderà dalla superficie stessa del nido, dalla quantità di gasbeton immerso in acqua e dall'umidità stessa della stanza in cui lo teniamo. D'estate, come è intuibile, l'ytong asciuga più in fretta, più è grande la superficie scoperta del nido. Nei nidi a pianta orizzontale, l'irrigazione a vasca porterebbe l'umidità distribuita su tutta la superficie del nido, col rischio di bagnare le stanze se aumentiamo troppo l'apporto d'acqua; questo dipende anche dallo spessore del blocco: può anche essere sottile (8 cm), e 2 cm d'acqua con gallerie profonde 2 si potrebbero allagare, danneggiando la covata. Sarà in quel caso necessario studiare un sistema valido per far arrivare l'acqua in parti localizzate usando vasche-serbatoio o irrigazioni mirate, oppure usare spessori maggiori (in commercio ci sono blocchi spessi 8-10-12-20 cm) e fare le stanze meno profonde (massimo 1 cm), che con specie piccole andrebbero comunque bene. Trovo che il gasbeton si adatti bene a molti tipi di formica, mentre è menoo adatto a specie più piccole, come Tetramorium, Plagiolepis, Crematogaster (lo bucherebbero come burro) o Pheidole pallidula; queste, oltre che essere perfettamente in grado di minare il materiale, potrebbero rischiare di perdere parte della covata nei minuscoli forellini del gasbeton, e i loro eventuali tentativi di scavo sarebbero meno evidenti, prendendoci di sorpresa. Certo, con alcuni accorgimenti, il rischio delle fughe sarebbe evitato o limitato per lunghissimi periodi, come lasciare un ampio spazio fra il bordo estremo delle gallerie e il limite dell’area coperta dal vetro, che rallenterebbero gli scavi.
Molte formiche potrebbero benissimo vivere nell’ytong grazie alla propria adattabilità, ma ci sono formiche più selettive, come alcune specie del genere Camponotus, che pur potendo sopravvivere, non sarebbero mai completamente a loro agio.
Formiche che si adattano bene nel gasbeton sono ad esempio Messor, Formica (F. cinerea, F. fusca, F. rufibarbis, F. cunicularia, F. sanguinea…), Cataglyphis, Myrmica (per le quali è bene prevedere un dosaggio di umidità continua e abbondante), ma anche formiche del Genere Lasius, benché appartengano al novero di quelle un po’ piccole e il limite, a mio parere, resta lo stesso problema citato per le Tetramorium.
E' ideale per Camponotus terricole come C. piceus, C. nylanderi, C. barbaricus, C. cruentatus. Anche Camponotus vagus si adatta bene al gasbeton, essendo più elastica delle consorelle maggiori (ligniperda, herculeanus, per le quali è preferibile il legno).
Non possiamo fare una lista completa, anche perché alcuni allevatori magari si sono trovati ugualmente bene col gasbeton anche con specie normalmente ritenute refrattarie (ma è più un pregio dell'adattabilità delle colonie).
Alcune delle nostre formiche, anche se potenzialmente in grado di forare il materiale, non lo fanno mai (ad esempio Formica e Lasius), mentre Messor e Camponotus vagus lo faranno appena possibile. Dovremo quindi metterle nella condizione di avere spazi sufficienti per gestire la colonia, così non saranno stimolate a farlo da subito.
A tutti coloro che utilizzeranno grandi nidi per colonie mature di Messor, sappiate che il gasbeton verrà attaccato, anche se ci metteranno molto tempo, e naturalmente solo quando il nido non corrisponderà più alle loro esigenze (la velocità di scavo può essere di 2 cm forati in 4 mesi). Per mia esperienza diretta, le minatrici lavorano quasi SEMPRE nell'angolo estremo più basso della struttura (sinistra o destra non importa), probabilmente dove sentono più forte la presenza di umidità, se il sistema di umidificazione è a bacinella. Consiglio di prevedere anzitempo, durante la costruzione, questo difetto: basterà costruire le gallerie più basse a campana rovesciata, cioè evitando angoli morti sui bordi, oppure lasciando maggiore spessore protettivo di vetro libero, sui lati estremi, in basso. Si suppone che la colorazione interna delle stanze limiti i loro tentativi, ma non è che una teoria da comprovare. L'unico sistema davvero sicuro, come già scritto, rimane racchiudere il blocco in una scatola di plexiglas.
Bisogna tenere sempre presente che il gasbeton asciuga più rapidamente del gesso, anche se in condizioni normali in realtà, anche se noi non ce ne rendiamo conto, all'interno mantiene l'umido per alcuni giorni. Il sistema di umidificazione, salvo per il genere Messor, che è in grado di sopportare più a lungo periodi di siccità, deve essere efficiente. Il metodo più facile e comune è usare una bacinella su misura in cui tenere a bagno il nido, mantenendo sempre uno, due cm d’acqua.
Alcuni allevatori prevedono una vasca, o un foro (o più) che attraversano il blocco in punti strategici, e che permettono di raccogliere saltuariamente una razione di acqua. L'umidificazione in questo caso risulta limitata a poche stanze, cosa sufficiente con formiche particolarmente amanti dei nidi secchi.
Per migliorare la vista del blocco, si può dare una colorazione che renda questo materiale, di per sé un po' grigio e freddo, più simile a una sostanza naturale. Questa pratica, rende solo difficile capire quando il blocco ha assorbito acqua (che sarà più scuro nella parte bagnata), o sta asciugando troppo. I colori da usare devono essere il più possibile naturali (acrilici, tempere, spray) o a base di acqua. Abbiamo sperimentato gli spray della Duplicolor (acrilici) e l'unico accorgimento consigliato è di lasciar passare qualche tempo (almeno 24 ore, meglio un paio di giorni) prima di chiudere il nido e usarlo, giusto per far sparire l'odore persistente di vernice. 
A prescindere dalla marca, è consigliabile scegliere colori che contrastino con le formiche: evitare per le stanze interne colori troppo scuri. Ovviamente i colori scuri rendono più visibile la covata, e meno evidenti le operaie, e viceversa!
Come col gesso, anche l’ytong si presta a nidi a doppia facciata, che raddoppiano l’area abitabile; occorre mettere in guardia sull'insorgere di possibili controindicazioni, che però sarebbero comuni anche in nidi di gesso: formiche che raccolgono i semi come Messor, potrebbero avere dei problemi. Infatti una delle due facciate sarà più calda dell’altra (cosa normale) e il vetro tenderà a creare condensa, cosa che rischierà di far germogliare i semi accumulati, o di farli marcire. Valutate sempre questa possibilità e limitate i nidi a due facciate per colonie davvero popolose, in grado di tenere in movimento il raccolto e di espellere i semi danneggiati. Infatti se il nido è troppo vasto rispetto alle esigenze dalla colonia, le formiche si limiteranno ad abbandonare il raccolto perduto nelle stanze e tutto marcirà rendendo i vetri opachi e le stanze alla lunga inutilizzabili.
Un altro consiglio è necessario prima di iniziare i lavori: essendo il gasbeton un materiale venduto a poco prezzo in blocchi abbastanza grandi, un errore comune che si può fare se si è neofiti, è di progettare un grandioso nido con immense stanze, gallerie lunghe ed enormi, che spaziano su tutta la superficie. Attenzione! Le formiche creano colonie che istintivamente si trincerano in luoghi angusti e capaci di dare la sensazioni di essere protetti: è comune vedere la colonia accumulare detriti vari a mo’ di imbottitura in ogni fessura delle camere abitate; l’istinto a trincerarsi è innato, soprattutto nelle colonie incipienti. È perfettamente inutile costruire un nido di 60 cm x 25 che alle formiche occorreranno anni per colonizzare. Tagliate piuttosto una porzione del blocco, e usate la sezione più piccola per scavare, utilizzando vari formati man mano che la colonia crescerà. È suggerito in diversi diari il consiglio di prevedere dei blocchi di terra, o altro materiale scavabile dalle formiche, che faccia da barriera a diverse sezioni del nido: man mano che la colonia cresce, le formiche tenderanno a cercare di allargare gli spazi vivibili, andando ad intaccare le pareti più cedevoli ( i nostri “tappi”) che permetteranno loro di accedere alla nuova sezione. Tenete presente che con molte specie questo è superfluo o difficilmente applicabile; con Messor, Camponotus e Formica, ma anche con altre specie piccole, le esploratrici vanno a scavare in ogni caso per cui i tappi sono rimossi prima del tempo. Per contro, in nidi troppo grandi per la colonia, se le operaie hanno materiale adatto a disposizione, sono capaci di barricarsi da sole in poco spazio, rendendo superfluo il nostro suggerimento.
Nello scavo del nucleo del nido, è altresì importante concentrarsi sul tipo di formica che vorremo metterci, per regolarci con le dimensioni, la profondità delle stanze, e il diametro minimo delle gallerie di collegamento. Anche qui come in altri materiali, è bene prevedere almeno due uscite: una all’arena, l’altra per eventuali raccordi con altri ambienti, o per collegare una provetta con acqua, o provviste liquide. Le gallerie non dovranno essere eccessivamente profonde nel blocco: le formiche tenderanno a rintanarsi più lontano possibile dalla luce, e perderemmo parte della visibilità che rende questo tipo di nido ideale a fotografare situazioni o ad osservare semplicemente la colonia.
Inutile anche fare stanze lontane le une dalle altre: meglio sfruttare l’area scavabile nel modo migliore possibile, altrimenti tanto valeva usare il blocco da 60 cm facendo solo 3 o 4 stanze lontanissime. Ricordiamo che una volta installata la colonia, non sarà più possibile apportare correzioni.
Allego un paio di foto adatte a suggerire un modo ideale per sfruttare bene la superficie: alle formiche non interessa quanto sottili siano i diaframmi fra una galleria e l’altra. Lo spazio che perderemo, lasciando anche 3 cm di bordo antifuga oltre l’area abitabile, possiamo recuperarlo così, oppure creando ballatoi interni alle stanze, per aumentare i ripiani orizzontali vivibili. Questi ovviamente sono accorgimenti ideali per chi ha già una grossa colonia sviluppata, e debba gestire al meglio lo spazio-nido. Per chi progetta un nido di accrescimento per una piccola colonia incipiente, sarà sufficiente armarsi di un po’ di fantasia e cercare di fare un lavoro più funzionale possibile: si impara soprattutto dai propri errori…
Buon lavoro!
PS: Trovate la descrizione di costruzione di un nido in gasbeton a due facciate per colonie popolose su: http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=13&t=331&start=120
La vita di un nido di gasbeton dipenderà dal tipo di formica che ci vive e dalla quantità di formiche della colonia. Messor ad esempio sporca facilmente l'interno e tende a rovinarne la visibilità. Uno-due anni di utilizzo intenso rendono un blocco quasi inservibile. Ma questo permette di volta in volta miglioramenti nel disegno delle stanze e rettifiche di progetto. L'ideale è che il nido cresca insieme alla colonia che ci deve vivere. Per questo i nidi delle colonie giovani sono detti comunemente nidi di accrescimento.
In questo blocco di 62 cm x 25, ospito una colonia di alcune migliaia di Messor capitatus. La profondità delle stanze è al massimo di 3 cm. Se le stesse fossero anche con un soffitto basso, la visibilità sarebbe compromessa. Ho risolto creando piani intermedi all'interno delle stanze più grandi. Potete notare che non ci sono spazi sprecati nell'area dello scavo: l'abitabilità è massima, e nonostante questo ho un'area di sicurezza esterna di almeno 3 cm. 
Si può vedere il particolare delle "mensole” interne alle stanze, che permettono una buona vista anche sul fondo delle gallerie più profonde.
 Per fissare il vetro (consigliabile rispetto al plexiglas, perché non si riga e ingiallisce col tempo) ho utilizzato semplici tasselli angolari, fissati con viti nelle facciate laterali. 
cliccare sulle frecce a destra per scorrere la galleria di immagini.
Formica cinerea

Tassonomia: Tribù: Formicini; Sottofamiglia: Formica
Areale di distribuzione: In tutte le regioni, relativamente in zone di pianura, lungo l’argine di fiumi e preferibilmente in zone sabbiose
da larva a pupa: 8-10 giorni;
da bozzolo ad adulto, 10-16 giorni. Favorevole all’adozione di ausiliarie della stessa specie.
Ginia: poliginica, ma può fondare anche sola
Habitat: Legata ad ambienti fluviali. F. cinerea forma colonie molto popolose con depositi esterni bassi che si presentano estesi sul terreno e con evidenti tracce di scavo, costellati da numerose uscite.
E’ facile confonderla con le altre formiche del Genere, come Formica cunicularia (più tendente al marrone-rossiccio, che costruisce collinette singole più alte e localizzate, e con la crescita della colonia sviluppa individui di stazza più grande). F. cinerea è spiccatamente prolifica e crea colonie con popolazioni numerosissime. Queste colonie assumono caratteristiche dominanti sul territorio occupato, essendo le operaie molto più combattive di cunicularia, cosa che rende il loro territorio sempre più impermeabile alle intrusioni di specie concorrenti. Per questo su alcuni testi la si paragona a una sorta di Formica rufa di pianura. La presenza di molte regine può infatti favorire l’accoglienza di regine neosciamate e la conseguente “immortalità” delle colonie maggiori.
Regina: 8-9 mm, corpo nero opaco con riflessi tendenti al grigio.
Maschio: 5-6 mm, nero
Operaie: 4-6 mm, nero opaco omogeneo, anche se la colorazione non è sempre significativa per riconoscere la specie. Da varie osservazioni, questa formica non sviluppa individui più grandi man mano che la colonia cresce, mantenendo uno standard fisso.
Alimentazione: moderatamente onnivora, in natura si ciba di sostanze zuccherine raccolte dagli afidi, di nettare di fiori ed insetti. Alimentazione in allevamento: soluzioni di miele, o zucchero diluito in acqua, e insetti di tutti i tipi, come farfalle, grilli, camole della farina, blatte, mosche, bruchi; più selettiva di altre specie del Gruppo Formica nell’accettare alimenti insoliti come scarti da cucina, che invece sono sempre accettati da F. cunicularia.
Umidità: suggerisco che almeno la parte più profonda del nido sia mantenuta sempre umida.
Temperatura: consigliabile per lo sviluppo della covata, da 22 a 26° C.
Ibernazione: da ottobre a febbraio la regina smette di deporre e la colonia rallenta l’attività senza immobilizzarsi del tutto anche a basse temperature; può essere mantenuta fra i 5 e i 10° C. La colonia normalmente non sverna con covata latente.
Nidificazione: nidifica preferibilmente sulle sponde sabbiose dei grossi corsi d’acqua, a cui sembra legata particolarmente.
Nidi artificiali consigliati: gasbeton (ytong), gesso, nidi con terra mista a sabbia a lastre affiancate (ma con rischio crolli). E’ bene prevedere un’arena spaziosa e un modello di nido che accolga l'esplosione demografica dopo il secondo anno. Attenzione: non è facile ai traslochi, quindi bisogna trovare un modo sicuro per trasferirla da un nido di accrescimento all'altro; allagare il nido vecchio, nel suo caso è assolutamente inutile!
Periodo di sciamatura: piena estate, giugno/luglio.
Periodo di sviluppo approssimativo a temperatura ideale:
da uovo a larva 10-15 giorni;
Comportamento in allevamento: inizio abbastanza rapido anche con una sola regina (da poche operaie a una cinquantina nate la prima estate), anche più di 200 il secondo anno per poi esplodere al terzo anno con centinaia di operaie.
Rischi per l'uomo: Nessuno, morso debole. Dotata di acido formico. Particolarmente veloce e priva di paura anche nei nostri confronti.
Descrizione: Le operaie sono molto laboriose e agili, dimostrando una risposta molto rapida al reclutamento da parte delle compagne in caso di rinvenimento prede, che vengono rapidamente portate nel nido. Discrete cacciatrici, trasportano rapidamente le prede all’interno del nido.
Nota: tutt'ora non ci sono molti allevatori che abbiano colonie sviluppate di questa specie, quindi non si sono potuti tenere raffronti e scambio di esperienze oltre il periodo di fondazione. I dati raccolti quindi sono basati sulla sola esperienza diretta dall'autore della scheda, che si riserva di variare, integrare e correggere la stessa a fronte delle osservazioni di altri allevatori di Formica cinerea. 
Ultimo aggiornamento (Lunedì 05 Marzo 2018 19:17)

- 1 Funicolo
- 2 Stelo o scapo
- 3 Lobo frontale
- 4 Fossa antennale
- 5 Clipeo
- 6 Mandibole
- 7 Pronoto
- 8 Occipite
- 9 Occhio composto
- 10 Scutello
- 11 Mesonoto
- 12 Spiracolo mesotoracico
- 13 Anepisterno
- 14 Metanoto
- 15 Spiracolo mesotoracico
- 16 Propodeo
- 17 Spiracolo propodeo
- 18 Ghiandola metapleurale
- 18a. Bolla
- 18b. Orifizio
- 19 Peziolo
- 20 Postpeziolo
- 21 Tergite
- 22 Sternite
- 23 Pungiglione
- 24 Femore
- 25 Tibia
- 26 Artiglio tarsale
- 27 Sperone tibiale
- 28 Tarso
- 29 Catepisterno
- 30 Coxa
- 31 Trocantere
- 32 Processo ventrale
- 33 Capo
- 34 Mesosoma
- 35 Peziolo
- 36 Gastro
Postato da mayx nel seguente post: http://formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=37&p=42038#p42038 Ultimo aggiornamento (Domenica 15 Aprile 2012 15:17)
La dieta Bhatkar è una dieta artificiale per l'allevamento delle formiche.
La sua validità è stata scientificamente accertata nel 1970 presso l'università della Florida, testando l'efficacia della formulazione su 28 specie di formiche rappresentanti 4 diverse sottofamiglie di Formicidae.
Ecco la ricetta.
Ingredienti:
- 5 grammi di Agar-Agar; (*)
- 500 cc di acqua;
- 1 uovo di gallina intero;
- 62 cc di miele;
- 1 pastiglia di complesso vitaminico/minerale (es. Multicentrum).
Mettere l'agar a mollo in 250 cc di acqua e riscaldare fino alla bollitura. Spegnere la fiamma e permettere al liquido di tornare a temperatura ambiente.
Triturare finemente la pastiglia vitaminica, con un pestello o il fondo di un bicchiere.
Unire al composto di acqua e agar a temperatura ambiente la pastiglia vitaminica polverizzata, il miele, altri 250 cc di acqua e l'uovo intero, e frullare alla massima velocità per 3 minuti.
Versare il composto in capsule Petri (o altri recipienti, es. bicchierini per il caffè di plastica), porre i contenitori nel frigorifero e lasciare solidificare.
Conservare il composto in frigo o congelarlo nel freezer e offrirne alle formiche piccoli cubetti volta per volta.
(vedi discussioni: 1- come somministrare l'alimento alle formiche, 2- esempio di Bhatkar)
(*) : l'Agar-Agar è un gelificante. Si può comprare in erboristeria, nelle sezioni "prodotti naturali" di alcuni ipermercati molto forniti, o anche in diversi negozi online.
Scarica il documento pdf completo (in inglese)

Nome scientifico: Lasius (Dendrolasius) fuliginosus Famiglia: Formicidae
Sottofamiglia: Formicinae
Genere: Lasius
Sottogenere: Dendrolasius
Ginia: Monoginica.
Regina: dimensioni 5 - 6 mm; colore nero lucente.
Operaie: nero lucido, dimensioni 3-6 mm, con caratteristico capo a forma di cuore; non presenta caste distinte.
Areale di distribuzione: Diffusa in tutta Italia in ambienti diversi, dalla pianura dove è meno comune, ai 900-1000 m, anche sopra i 1500 metri nelle regioni più a sud. La sua presenza è dubbia in Sicilia.
Alimentazione naturale: Melata e piccoli artropodi.
Alimentazione artificiale: Miele o zucchero diluiti, insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi, meglio di tipo "morbido”, frutta dolce; sperimentato anche paté per gatti.
Umidità: Fornire un gradiente con parte asciutta e parte umida
Temperatura ideale di sviluppo: 20-27°C Ibernazione: Obbligatoria.
Formicai in natura: Nidifica preferibilmente negli alberi sia morti che vivi; occasionalmente è stata rinvenuta anche nel terreno, o nelle fessure di muri, probabilmente non per scelta ma per la difficoltà di trovare un ambiente a lei idoneo, dimostrando adattabilità; non è dato però sapere se in questi casi ha edificato i classici padiglioni di cartone masticato per cui è nota. Questa formica infatti predilige le parti interne degli alberi, costruendo nel tronco particolari strutture di legno masticato e mescolato con la sua saliva, che si sviluppano in un materiale “vivo” in quanto costituito in parte da un micelio simbionte, il Cladosporium myrmecophilum, che dà stabilità alla struttura e le cui spore vengono trasportate dalla regina fondatrice nella sacca infrabuccale, dalla quale un organo a filtro impedisce l'ingestione delle spore stesse”.
Formicai artificiali: Per questa specie il nido ideale è nel legno, quindi meglio dopo la fase di fondazione tentare di alloggiarla nel suo materiale preferito. Sarebbe interessante cercare di sviluppare un modello che permetta di osservare lo sviluppo del micelio e la tecnica di costruzione adoperata. Attualmente non si trovano informazioni in rete di allevatori che siano riusciti a far sviluppare la colonia come in natura!
In alternativa può essere mantenuta in nidi di gesso, gasbeton, sabbia e terra.
Difficoltà: Delicata in fase di fondazione, non indicata ai principianti.
Indole: Formica molto laboriosa, organizzatissima, prolifica e abbastanza combattiva.
Periodo di sciamatura: distribuito da maggio a Settembre, maggior concentrazione nei mesi più caldi.
Tipo di fondazione: Parassitaria. La specie preferita è Lasius (chthonolasius) umbratus, ma può fondare anche con tutti i Lasius (Chthonolasius) spp. Più regine possono fondare nella stessa colonia (pleometrosi), con possibili casi di poliginicità, anche se in cattività sopravvive solo una regina dopo che si è raggiunto un certo numero di operaie. Sono le stesse operaie di L. fuliginosus che le eliminano.
Sono state sperimentate anche altre specie ausiliarie (addirittura con Formica cunicularia), ma per ora i risultati non si sono dimostrati sempre positivi. La regina viene adottata, ma sembra che non ci sia un seguito alla crescita della colonia.
Se si utilizza come ausiliaria Lasius umbratus, la fondazione potrebbe aver difficoltà a causa del fatto che le operaie sono un pò delicate nelle prime fasi, essendo ipogee e nutrendosi soprattutto della melata di afidi radicicoli. Questo crea dei problemi, perché scegliendo Lasius umbratus si rischia di ritrovarsi in breve con una popolazione morente o fortemente debilitata.
Il metodo per ora migliore per creare una nuova colonia è quello di far adottare la regina da un piccolo manipolo di operaie con almeno una trentina di pupe, meglio un centinaio. Si può tentare anche con le stesse operaie di Lasius fuliginosus ma è meglio che provengano con certezza da un nido estraneo. Meglio ancora se accompagnate da pupe o larve.
Le operaie di Lasius, meglio se giovanissime, vanno tenute per qualche tempo in una provetta con tutte le pupe disponibili (altre pupe possono essere aggiunte anche in un secondo momento) in modo che si tranquillizzino e si sentano al sicuro rivolgendo tutta l'attenzione alla prole. Introdurre la regina quando è tranquilla, accoppiando le due provette.
In caso di abbinamento con operaie adulte è meglio immettere, tramite un tubetto chiudibile, una operaia per volta, quando non si verificano più atteggiamenti aggressivi aggiungere le altre.
La regina normalmente si nutre anche da sola, ma se le vengono fornite larve, potrebbe cercare di nutrirle e quindi affamarsi per cui conviene fornire pupe il più possibile pronte a schiudersi (leggi bozzoli). La regina stessa parteciperà attivamente all'apertura dei bozzoli. Se la provetta è abbastanza stretta, presto verrà accettata dalle operaie.
Dopo qualche giorno, aprire la provetta in arena e fornire zucchero di canna inumidito e acqua.
Se è regolarmente nutrita, quando verranno raggiunte almeno 30 operaie, inizierà a deporre. A quel punto lo farà in modo massiccio e quindi bisognerà cominciare a fornire anche proteine, meglio se sotto forma di insetti morbidi.
Questo dovrebbe accadere dopo 15/20 giorni. In questa fase è importante continuare a fornire una grande quantità di cibo proteico in modo da permettere un rapido sviluppo delle larve.
Verso ottobre la colonia va messa in un luogo freddo per affrontare l'inverno. Porre attenzione all'umidificazione che non deve essere eccessiva.
Al risveglio in primavera le attività diverranno frenetiche portando allo sviluppo contemporaneo delle larve in pupe e infine alle prime nascite.
Riprenderanno le deposizioni. Dopo qualche tempo nasceranno le prime operaie che verranno regolarmente bloccate e disturbate delle operaie di Lasius. Il fatto però di avere un gran numero di larvette che richiedono attenzioni, porta a distrarre molto le ausiliarie che permetteranno alla maggior parte di nuove nate di sopravvivere. Le nuove nate non si vedranno mai in arena per almeno i primi 10 giorni. Dopo di che inizieranno ad avventurarsi fuori in cerca di cibo spinte dalle necessità della colonia.
Se sono state fornite più di 100 operaie, alla fine del secondo anno la colonia sarà popolosissima; dal terzo anno si potrebbero avere già degli alati.
In cattività possono vivere in quasi tutti i materiali, ma si tratta di una specie piuttosto determinata, se decide di scavare c'è poco da fare; prevedere quindi sistemi di antifuga e contenimento. La soluzione migliore dovrebbe essere gasbeton con nido orizzontale e possibilmente colorato di chiaro per migliorare l'osservazione. Nella seguente immagine si può notare che l'organizzazione di queste formiche è ammirevole: esse dividono rigidamente i vari stadi di sviluppo della covata per età: uova, larve schiuse, larve in sviluppo, poi più grandi e infine la stanza di filatura dei bozzoli e quella di maturazione... 
Questa scheda è stata compilata raccogliendo le informazioni di chi per primo ha sperimentato con maggiore successo l’allevamento di Lasius fuliginosus, Angelo Cardillo, Luca Bertoni e Luca Bosetti. Inizialmente solo Angelo Cardillo era riuscito a sviluppare colonie per più anni con popolazioni stabili di sole operaie fuliginosus, ora che il sistema di fondazione è stato risolto con tecniche diverse di adozione, questa specie presenta incognite solo nella fase di sviluppo avanzata, in quanto le colonie più numerose andrebbero indotte a spostarsi in nidi misti con un nucleo in legno, in modo da sperimentare il "lato oscuro” di questa interessante formica.
Tutti sono invitati a partecipare al perfezionamento delle schede con le proprie esperienze. Scrivete a me (Giannibert) o ad altri moderatori se avete riscontrato imperfezioni o se avete la vostra esperienza da comunicare. Due immagini della notevole estroflessione del gastro della regina: le operaie la seguono assiduamente, circondandola di attenzioni. Nonostante l'addome pesante, la regina gode di una buona mobilità. 
Ultimo aggiornamento (Venerdì 20 Aprile 2018 18:49)
La costruzione di un formicaio in galle può essere una facile ed economica soluzione se si vuole ricreare un ambiente il più possibile naturale per alcune specie arboricole.
Le galle sono strutture legnose che si formano nelle piante a seguito di parassitosi varie e una volta che i giovani parassiti fuoriescono dalla loro “nursery”, possono essere usate come riparo da un grande numero di artropodi.
Durante la raccolta è possibile trovarvi all’interno regine in fondazione o colonie ad uno stato più o meno avanzato.
Galla di Andricus kollari
La mirmecofauna delle galle è abbastanza limitata: Temnothorax sp., Leptothorax sp, Camponotus truncatus, Camponotus lateralis, Camponotus fallax, Dolichoderus quadripunctatus, Crematogaster scutellaris.
L’utilizzo di un formicaio in galle è però altamente sconsigliato per alcune di queste specie, come Camponotus lateralis, Camponotus fallax e Crematogaster scutellaris, vista la loro prolificità che renderà necessario un aumento sconsiderato del numero di galle.
Trovare galle: i periodi ottimali per una buona ricerca sono l’autunno e l’inverno. Infatti sarà facile vedere le galle attaccate ai rami se quest’ultimi saranno spogli di foglie. Le galle migliori, sia per la costruzione che per il contenuto, sono quelle create da Andricus kollari e si possono trovare nelle querce. Facilmente reperibili sono anche le galle di pioppo, ma sono scarsamente utilizzabili per la costruzione.
ATTENZIONE: è bene limitare il prelievo il più possibile per non infierire troppo sulla mirmecofauna.
Aprire una galla: incidere leggermente la galla con un piccolo coltello e utilizzarlo come leva per aprire in due semisfere la galla.
In questo modo saremo sicuri che le formiche contenute non vengano ferite e sarà possibile usare la semisfera più integra per la costruzione del futuro formicaio.
Contenitore: Come prima cosa è bene cercare un contenitore trasparente che presenti le dimensioni giuste per la specie che vorremo inserire. Alcune infatti, come quelle del genere Temnothorax non richiedono grandi spazi.
Trattandosi di un formicaio per formiche arboricole è meglio utilizzare contenitori sviluppati in altezza. Ottimi sono quelli utilizzati per contenere la pasta.
Consiglio di versare una piccola quantità di gesso alla base, cosi da rendere il formicaio più pesante alla base ed esteticamente migliore.
 Galle: Le galle vanno divise a metà e svuotate il più possibile, nel caso rimanga una piccola parte di tessuto spugnoso probabilmente le nuove inquiline provvederanno a crearvi dei piccoli fori e il materiale potrebbe oscurare in parte il vetro. Galle: Le galle vanno divise a metà e svuotate il più possibile, nel caso rimanga una piccola parte di tessuto spugnoso probabilmente le nuove inquiline provvederanno a crearvi dei piccoli fori e il materiale potrebbe oscurare in parte il vetro.
Prima di attaccarle alle pareti va creato (nel caso non sia presente) un piccolo foro per permettere l’ingresso delle formiche. Deve essere molto piccolo (giusto per permettere l’ingresso della regina), così da non stressare le inquiline.
Per fissare le galle è possibile utilizzare colla a caldo oppure vinavil. La prima è più resistente, ma non permette titubanze ed errori una volta applicato. Con la seconda nel caso la galla venga fissata male è possibile rimuoverla subito e pulire il vetro con dell’acqua. Inoltre in futuro sarà possibile, anche se non semplice, togliere con l’acqua le galle per spostare la colonia velocemente.
Galla con Camponotus truncatus
Numero di galle: Come accennato prima dobbiamo valutare in base alla specie le dimensioni del contenitore e il numero delle galle da utilizzare.
Le formiche del genere Temnothorax necessitano del minor spazio, 3 galle possono essere più che sufficienti, mentre per le altre è necessario un numero superiore.
Può essere utile l’uso di una piccola galla così che venga utilizzata inizialmente dalla colonia ancora giovane (per favorire l’ingresso e tranquillizzare le inquiline durante i primi giorni è bene oscurare la galla con un foglio di carta scuro posizionandolo esternamente al contenitore).
Decorazioni: Terminata l’applicazione delle galle è consigliata l’aggiunta di piccoli legni così da migliorarne l’estetica e la superficie di movimento delle formiche.
E’ possibile anche inserire un piccolo supporto estraibile su cui riporre il cibo (Fig. 1). Come appoggio per il supporto in questo caso sono state utilizzate delle piccole V in legno (Fig. 2).
In questo modo è possibile accedere alla base del formicaio per ripulirla o per cambiare la provetta d’acqua.
 
Fig. 1 Fig. 2

Acqua: le formiche arboricole non necessitano di umidità interna al formicaio, ma è bene inserire una provetta che funga da abbeveratoio. Basterà preparare una provetta con le stesso metodo utilizzato per le provette da fondazione riempiendola solo d’acqua senza lasciare spazio per la colonia.
Qui di seguito alcune foto del formicaio che ora contiene la piccola colonia di Camponotus truncatus mostrata precedentemente:
 
Visione anteriore Visione posteriore
 
Vista dall’alto senza supporto Vista dall’alto con supporto
Ultimo aggiornamento (Venerdì 14 Marzo 2014 11:26)
Prima di scegliere questo tipo di formicaio, di cui esistono anche modelli in vendita, che possono tentare i principianti, è bene sapere che su formicarium sconsigliamo la scelta di questo modello per i motivi che sono riportati anche nelle istruzioni sotto, ma che sarà bene ribadire fin dall'inizio.
Questo genere di formicaio era in uso all'alba dell'osservazione scientifica delle formiche, perché non c'erano molte alternative; molti sono attratti da questa soluzione perché desiderano "vedere le formiche scavare”. Sarà bene ribadire subito che le formiche non scavano mai come ci aspettiamo da loro, e la possibilità di manipolare il materiale del nido permette loro di occultarsi facilmente, cos che scelgono di fare quasi sempre. Ridurre gli spazi fra le lastre creerà solo nuovi problemi di gestione dello spazio vitale, difficoltà di areazione, complicazioni con l'umidità, e la difficoltà di accedere all'interno per effettuare qualsiasi opera di manutenzione o prelievo di campioni. Inoltre è difficile traslocare le formiche in un secondo tempo.
Ribadisco quindi che il modello a lastre affiancate è qui inserito solo perché vogliamo dare una visione completa dei vari modelli di formicaio artificiale che sono stati sperimentati. Scegliete con cura il tipo di formicaio in base alla formica che ci metterete a vivere dentro, e non viceversa! E ricordate che è più importante avere una buona visibilità interna, con materiale traspirante, e che sia ben gestibile nel tempo.

(cliccare sull'immagine per ingrandirla)
Il formicaio artificiale verticale a lastre è uno dei primi modelli usati per l’osservazione sistematica delle formiche, ed è ancora oggi scelto da alcuni allevatori per semplicità di costruzione e scarso ingombro, oltre che per essere l'unico sistema per “vedere scavare le formiche” in modo naturale.
La variante originale di questo modello è il nido di Lubbock, che consisteva in due lastre parallele, distanziate di circa 1 cm, fissate ad una cornice di legno. Nella cornice erano praticati dei fori in cui erano introdotti i tubi che servivano da passaggio verso l’esterno per le formiche.
Oggi come cornice per questo tipo di formicaio si usano materiali come plastica, metallo o plexiglas, che evitano il problema di scollamento o deformazione causate dall’umidità interna del terreno del nido.
Di questo modello esistono in commercio nidi di tutte le misure, l’unica difficoltà per costruirselo a casa è data dalla scelta dei materiali che costituiscono la cornice e dalla saldatura delle parti di contenimento in modo che sia più ermetico possibile. Se si usano materiali come il plexiglas, che necessitano colle al silicone, è necessario lasciar passare una decina di giorni dall’asciugatura perché le formiche non siano infastidite dalle esalazioni.
La distanza di 1 cm potrebbe non essere sufficiente a permettere una corretta visione dell’interno, in quanto formiche molto piccole, come Tetramorium, Lasius o Pheidole, hanno la possibilità di nascondersi facilmente in tale spazio; inoltre, avendone la possibilità, tutte le formiche che hanno a disposizione della terra tendono a mascherare l’interno delle gallerie e a schermare il vetro. Proprio per questo devo sottolineare che adottando questo modello è molto facile che si possa perdere la visione ottimale di quello che avviene nella colonia! Se lo scopo è di tenere in casa una colonia e vedere le formiche attraverso il vetro, che scavano i loro cunicoli, è necessario giocare con distanze minime fra le lastre, e questo già pregiudica lo spazio-arena superiore, dove comunque le operaie porteranno il materiale avanzato. L'accesso all'arena quindi si fa difficile, la pulizia quasi impossibile e non sempre il finale è esteticamente quello che vi aspettavate! Se invece lo scopo è di poter osservare agevolmente la vita di questi insetti (la parte interessante di avere un formicaio in casa), o lo studio scientifico, consiglio di ripiegare su altri modelli di formicaio artificiale. Forniamo comunque le indicazioni necessarie alla sua realizzazione. Questo modello è utilizzabile per formiche terricole di taglia medio-grande, come Camponotus aetyops, C. cruentatus e C. piceus, le Formica, per il genere Myrmica e per Messor, anche se l'umidità del terreno, difficile da gestire, rischia di far germogliare i semi loro alimento, con conseguenze fastidiose. L'ideale sarebbe far condensare e compattare con l'umidità il terreno, poi lasciare che asciughi, in modo da avere un substrato ben coeso ed esente da crolli in caso di vibrazioni. tenete conto del fatto che il limite dello spazio circoscritto rende più difficile far asciugare il composto utilizzato. Sconsiglio il nido a lastre affiancate per formiche piccole come quelle del Genere Lasius, Tetramorium o Pheidole, che andrebbero a scomparire facilmente nel terreno.
Il materiale di base del nido scavabile è preferibilmente la sabbia argillosa a grana grossa, che è più compatta dell’humus e si presta meno a crolli. Si possono mescolare sabbie e humus, sabbia e argilla, miscelando anche ghiaia sottilissima con il materiale fine di base. Questo materiale deve assorbire bene l'acqua, senza però trattenerla troppo, per evitare il rischio di ristagni, la formazione di muffe e il marciume causato da prede portate nel nido. Alla base è consigliato mettere materiale grezzo assorbente come le palline di argilla espansa che si usano anche nei vasi di fiori per trattenere l'umidità. Qui servono a formare uno zoccolo che raccolga l'acqua sul lungo periodo, senza trasformarsi in fango liquido.
Lasciate sempre una certa distanza al di sopra del livello di terreno, che le formiche useranno per il riporto degli scavi; prevedete di conseguenza il punto ideale dove fare i fori di collegamento, che altrimenti verranno coperti dalle formiche e ignorati. Prestate attenzione particolare alle giunzioni della cornice di contenimento, come alla larghezza del piedistallo, che deve garantire l’equilibrio della struttura.
Si possono usare sia delle superfici larghe incollate, come 4 piedini angolari a “L”.
Il collegamento ad un’arena esterna è sempre raccomandabile tramite tubi flessibili abbastanza lunghi da permettere un’inclinazione ridotta, dato che l’altezza della struttura potrebbe rendere disagevole il rientro delle formiche attraverso un tubo troppo verticale, se il materiale è molto liscio.
Come abbiamo detto, la chiusura ermetica e la larghezza di questo nido rendono difficile accedere all’interno; possono esserci rischi di condensa eccessiva e prolungata se non si prevede la facilità di apertura della parte superiore, come la possibilità di poter umidificare il terreno quando troppo asciutto. Versare acqua dall'alto potrebbe causare crolli indesiderati, o allagare la covata, che in ambiente artificiale così castigato, non reagirebbe come in natura! Un tubo, o un foro apribile che permetta di umidificare la parte bassa del nido, dove avrete posato lo strato di argilla espansa, è consigliabile per ovviare questi problemi. E prima di mettere la vostra miscela di humus, sabbia, o argilla nel nido, fate una prova di come reagisce all'umido e all'asciutto! POI, ci metterete le formiche!
Ultimo aggiornamento (Lunedì 16 Aprile 2018 20:24)
Periodo di riposo invernale o IBERNAZIONE per le specie autoctone
Per tutte le specie autoctone, quale che sia il tipo di nido e il materiale in cui sono allevate, è bene prevedere nel periodo invernale una fase di riposo equivalente a quelle che si verificano in natura.
Ognuno prenda in considerazione regione, quota o latitudine di provenienza delle proprie formiche, oltre alla specie in questione.
A questo proposito dobbiamo considerare che alcune delle nostre formiche di origine subtropicale o africana come quelle del Gruppo Messor, le Pheidole o Cataglyphis, Lasius, Tetramorium, Linepithema humile o Tapinoma ma anche specie più grandi di origini africane, come Camponotus nylanderi, o C. barbaricus non hanno l’obbligo assoluto di ibernarsi, ma affrontano ugualmente un lungo periodo di stasi come le altre nelle regioni o negli anni in cui le condizioni invernali si manifestano in modo tale da sconsigliare lo svolgersi della normale vita della colonia.
Origine probabile della fase di letargo.
Il periodo invernale riduce la possibilità di una colonia di approvvigionarsi in modo sufficiente a mantenere attiva tutta la popolazione. Il calo delle temperature riduce anche la mobilità degli insetti in generale e le formiche non fanno eccezione se non nelle specie meglio adattate.
Per le formiche del sud e di pianura è possibile un semplice rallentamento dell’attività, il calo del metabolismo, e la cessazione delle deposizioni di uova da parte della regina, mentre nelle popolazioni più a nord o di montagna questo rallentamento è così marcato che si verifica il vero e proprio letargo invernale, con l’immobilizzazione di tutta la colonia che si ammassa nelle stanze più protette del nido, di solito attorno alla regina e alla covata, che può rimanere inattiva per tutto il periodo.
Anche il tipo di dieta potrebbe essere significativo: la possibilità di alimentare la colonia con qualsiasi cibo reperibile rende ad esempio Pheidole, in vicinanza di fonti di calore, attiva anche in pieno inverno. La formica rufa che si alimenta prevalentemente di insetti e melata, non potrebbe sopravvivere data l’assenza abbondante di queste fonti, anche in assenza di neve nei suoi boschi di montagna abituali.
In specie di montagna con metabolismo particolare come Camponotus herculeanus e C. ligniperda, ma anche in Camponotus vagus, formiche che spesso trascorrono l’inverno al riparo di materiali confortevoli e isolanti come il legno, questa fase viene definita anche "diapausa invernale”, ed è uno stato di rallentamento totale dell’attività anche se la colonia fosse forzatamente mantenuta a temperature accettabili, o anche calde.
Quale che sia la temperatura della stanza in cui terremo alcune delle nostre Camponotus, già a fine settembre potremmo notare la totale apatia della colonia, tanto che possiamo considerare ragionevolmente fino a 6-8 mesi il periodo in cui questa non si dedicherà alla cura della covata, né sembrerà che le operaie o la regina vogliano alimentarsi.
Consiglio di rimpinzare a dovere prima di questo periodo le nostre colonie e di mantenerle in stanze se non fredde o gelide, almeno a temperature che non salgano oltre i 10 gradi.
Infatti uno dei rischi di una colonia inattiva, ma tenuta a temperatura troppo calda, oltre a uno stress generale, è che potrebbe rendere il nido vulnerabile all’attacco di muffe, funghi o altre malattie che il ridotto metabolismo delle formiche non potrebbe contrastare come nel periodo estivo. Inoltre, se le formiche si immobilizzano, grazie al loro metabolismo possono resistere meglio e più a lungo che se indotte a muoversi o a restare abbastanza sveglie anche se inattive.
Fase PRIMA: colonie iniziali in provetta e regine fondatrici.
Quando fosse possibile, per le colonie alla fase iniziale con poche operaie, o anche per le sole regine che fonderanno la primavera successiva, la stabulazione in frigorifero è utile e consigliata; infatti la temperatura mantenuta stabile è una buona garanzia che regine e operaie non siano infastidite da repentini sbalzi di temperatura.
Prima di inserire le provette o qualsiasi mini-formicaio in frigorifero è consigliabile far sentire alle formiche il calo graduale della temperatura. A questo scopo sarebbe sufficiente esporre le colonie alla temperatura esterna in modo che percepiscano almeno per qualche giorno, o anche settimana, il calo di luce e temperatura.
In ogni caso all’abbassarsi della temperatura, le formiche, che non hanno recettori come i nostri, semplicemente rallentano e si fermano, senza traumi particolari avvertibili, ma potrebbero essere impreparate ad affrontare in quello stato un lunghissimo periodo.
Sappiamo che la luce non influenza particolarmente le nostre formiche. Alcune supposizioni sulle condizioni che inducono le formiche al letargo comprendono quella del magnetismo terrestre; in ogni caso le formiche sentono avvicinarsi il periodo invernale e questo le condiziona a rallentare l’attività.
Le provette, a seconda della specie contenuta, possono essere tenute in frigorifero, o all’esterno (in questo caso protette con polistirolo o altri materiali isolanti) per tutto il periodo tipico dell’inverno delle regioni di provenienza.
Fase AVANZATA: colonie sviluppate con operaie numerose o grandi nidi artificiali.
Probabilmente nessuno di noi ha a disposizione celle frigorifere in cui mantenere tranquille le proprie colonie per lunghi periodi.
Già colonie di un anno possono essere piuttosto ingombranti anche private dell’arena esterna, per non parlare di chi ha teche giganti in cui abbia inserito tutto il nido.
Le soluzioni sono molteplici, e chi ha idee nuove e originali è ringraziato in anticipo per la sua esperienza. Io ad esempio mi limito a gestire i nidi più grandi mettendo semplicemente due fogli di polistirolo sulle vetrate anteriore e posteriore, ben a contatto con la superficie, assicurate con un giro di scotch di carta, in modo da creare una barriera più diretta possibile al vetro esposto. Il polistirolo, più o meno spesso, è un ottimo isolante, è questo fa sì che il freddo non raggiunga direttamente l'interno. Il vetro trasmette immediatamente la temperatura esterna, quindi è vulnerabile agli sbalzi termici. Con il plexiglas invece si hanno trasmissioni termiche meno nette, ma questo non vuol dire che il sottile strato non faccia passare il freddo.
Spostare le colonie in garage non riscaldati, in cantine, metterli sul davanzale di una finestra o su un balcone (sempre, in questo caso, in certe regioni va ricreata una situazione di temperatura stabilmente rigida, quindi proteggere il nido da eventuali raggi di sole, come da gelate improvvise, mettendoli al coperto di contenitori studiati ad hoc), in verande, magazzini, sono le soluzioni più a buon mercato e attuabili.
Anche se la colonia non è proprio al gelo, ma al di sotto dei 10 gradi, spesso è sufficiente a ricreare le condizioni ideali per il suo letargo invernale, mentre nel caso di specie particolarmente ostiche (come Myrmica ruginodis, Manica rubida, Formica rufa, ad esempio) potrebbe essere necessario mantenere queste temperature intorno allo zero anche per lunghi periodi per indurre la colonia a immobilizzarsi. Questo rende tutto più difficile se avete preso le vostre colonie da regioni non di vostra appartenenza (un siciliano che si sia procurato una colonia di Myrmica ruginodis originaria del Trentino), quindi è sempre bene prevedere in anticipo i pericoli e le difficoltà di procurarsi e mantenere formiche che poi non potremo gestire correttamente.
Colonie in cui l’ibernazione non è obbligatoria.
Formiche di origine mediterranea (Messor, Pheidole pallidula, Aphaenogaster spinosa, Tapinoma, Catagliphys) ma anche specie molto elastiche come Lasius o Tetramorium, non hanno l’obbligo stretto di ibernarsi, anche se è sempre consigliabile favorire una fase di riposo soprattutto alla regine in colonie sviluppate che pruducano abbondanti covate estive.
Anche nelle regioni del nord è possibile vedere formiche del genere Tapinoma bottinare all’aperto in pieno inverno con 5-6 gradi, a patto che il terreno sia colpito da raggi di sole. Come ho già iscritto altrove, non abbiamo dati che ci dicano quelli siano le temperature reali di un nido (ad esempio di C. nylanderi) interrato in un prato esposto al sole, in Sicilia o Puglia; a quale profondità staranno le formiche? Si immobilizzeranno, o troveranno un ambiente di stasi in cui fermano la ovata e semplicemente passano il tempo? Non ci sono esperienze dirette, ma certo sotto un sasso, in un terreno spoglio, sotto il sole per molte ore, sviluppa una buona temperatura anche in pieno inverno: e se le formiche stessero semplicemente pochi centimetri sotto, riceverebbero tutti gli effetti di un solarium...
Le colonie di Messor, Formica cunicularia, F. cinerea, Tetramorium, Pheidole, possono trascorrere l’inverno in condizioni di semi-letargo, semplicemente rallentando l’attività, ma senza mai immobilizzarsi del tutto, anche al di sotto dei 10-12 gradi.
In questi casi si può decidere di far saltare direttamente l’ibernazione a tutta la colonia, o di limitarla ad un arco breve di pochi mesi (anche solo 2). Le formiche mantengono in stasi la covata per tutto l’inverno se le temperature non si alzano per un periodo che possa far loro intendere che il periodo difficile è terminato. Non è strettamente necessario fornire cibo alle colonie in questo periodo, mentre è bene controllare che l’umidità latente sia sempre accettabile all’interno del nido, o che le operaie possano accedere a una fonte di idratazione.
Uno dei rischi è quello di lasciar seccare l’aria del nido troppo a lungo e di far morire la colonia nel sonno; controllate sempre che ci sia una fonte d’umidità a portata delle formiche.
Sottoposte a forti e duraturi periodi di riscaldamento anche in pieno inverno, Messor, ma anche Pheidole o Tetramorium, iniziano a deporre le uova e a sviluppare la covata come in piena estate, non essendo influenzate come i Camponotus o Formica da altri fattori genetici. In questo caso l’alimentazione della colonia deve essere mantenuta normale come in piena estate.
Esperienze personali:
Le colonie di formiche autoctone possono sopportare temperature molto più basse, per brevi periodi, di quello che possiamo immaginare. La mia colonia di Messor capitatus ha superato alcuni inverni in garage non riscaldato anche per diversi giorni con temperature esterne al di sotto dei -5° fino a -7°, semplicemente ammassandosi e immobilizzandosi. La colonia non sembra averne mai avuto conseguenze negative, che si sono verificate invece in annate in cui la mantenevo a 8-15 gradi. Temperature che bastavano a rallentare il metabolismo, ma esponevano la colonia a rischi d’infezioni esterne, che con temperature prossime allo zero non si verificano.
Alle stesse condizioni la colonia di Formica cunicolaria, pur rimanendo inattiva in senso stretto, non si è nemmeno mai bloccata.
Myrmica rubra ha trascorso l’inverno in provetta (4 regine, circa 50 operaie) semplicemente dentro una scatola di Ferrero Rocher, senza protezioni, sul davanzale della finestra. Le formiche non si sono mai immobilizzate del tutto.
Ho mantenuto invece le Camponotus maggiori in frigorifero o, nel caso delle C. vagus, il nido all’esterno o all’interno di una finestra abbastanza riparata, ma con temperature che non salivano mai sopra i 10-15 gradi, e la colonia si è riattivata spontaneamente a fine febbraio, dopo una stasi che era iniziata già a fine settembre.
Lo stato della colonia di Camponotus vagusprima del risveglio dal letargo del 2011/2012.

Una nota particolare va aggiunta sulle fasi vitali di alcune specie di formiche per coloro che sono interessati a vedere lo sviluppo dei sessuati nelle proprie colonie mature:
Nel caso delle formiche del gruppo Myrmica, si sa che la nascita di regine primaverili avviene solo con uova schiuse in autunno che abbiano passato la fase invernale in ibernazione allo stato di larva. Questa è una condizione generalmente necessaria; serve l'assenza dei feromoni inibitori della regina a far sì che alcune di queste larve si sviluppino in altrettante regine, e questa cosa avviene durante il letargo invernale. Non abbiamo dati che possano far pensare che ciò possa influenzare anche altre specie. Myrmica è una delle più studiate in tal senso, ma è possibile che alcune specie autoctone seguano lo stesso iter.
Consiglio:
In caso di regine fondatrici che abbiano compiuto il volo nuziale autunnale, sarebbe bene rispettare la pausa invernale senza sfalsare i loro tempi di deposizione mantenendole a temperature elevate, cosa che è possibile favorire negli anni successivi in cui la popolazione la possa assistere. La regina da sola rischia maggiori stress ed è sempre al limite del suo equilibrio, mentre in presenza delle operaie può essere mantenuta sveglia e produttiva (sempre con riferimento a specie che non hanno la fase letargica obbligata).
L'uscita dal letargo invernale Quale che sia la durata del periodo di riposo invernale, le formiche percepiscono immediatamente il cambio di temperatura, e iniziano a muoversi per riprendere la normale attività per quelle immobilizzate, mentre quelle che non si sono mai bloccate hanno un'accelerazione rivolta alle pulizie del nido, al foraggiamento e all'esplorazione dell'ambiente. Possono essere necessari da poche ore ad alcuni giorni perché l'attività di tutta la colonia (colonie adulte o con più di 100 operaie) riprenda a comportarsi normalmente, ma per riattivare la deposizione della regina o lo sviluppo della covata latente è bene considerare che questa fase si attiva in presenza di un periodo di calore CONTINUO per più di una settimana, a volte anche per almeno 15 giorni. La regina depone se è sicura che la bella stagione è davvero tornata! Questa informazione le arriva tramite gli stimoli esterni delle figlie: proteine fresche, cibo in abbondanza e, appunto, il rialzarsi stabile delle temperature. Quanto al modo di rialzare le temperature, è ovvio che sia meglio un rialzo graduale che imiti la realtà naturale. Probabilmente un rialzo repentino non arrecherebbe danni alle formiche e alla covata, ma non abbiamo dati in proposito, per cui mi sembra più logico i procedimento di portare la colonia gradualmente in zone della casa sempre più calde. metteteci pure due giorni, una settimana, quindici giorni... giusto non fatele passare in un'ora dal frigo al termosifone! Va tenuto in considerazione anche l'alloggio della colonia: in provetta gli sbalzi termici vengono percepiti immediatamente, nel legno più velocemente che nel gasbeton, per ultimo metterei il gesso. La durata dell'ibernazione, anche nei confronti di specie non-obbligate, deve essere percepibile per loro e applicata con buon senso. E' vero ad esempio che si possono ingannare le formiche mettendole in frigo per breve tempo (anche pochi giorni) e fingere subito un rientro primaverile, ma non abbiamo prove che questa procedura non crei degli scompensi metabolici sulle regine. Quello che sappiamo è che le formiche sono molto robuste e adattabili, ma non abbiamo resoconti dettagliati su campioni significativi che questo trattamento sia indolore. Personalmente consiglio un minimo di due mesi, con le specie meglio adattabili (come le Formica) e suggerisco di rispettare la stagionalità della specie in questione. Con Camponotus herculeanus, e C. ligniperda, per prendere due specie estreme, non scenderei sotto i tre mesi, possibilmente rispettando il fotoperiodo dell'ambiente dove vivono abitualmente! L'apporto proteico, meglio se con insetti morbidi, è sempre gradito nelle colonie già sviluppate, ed è necessario in quelle con covata di larve latente, mentre bisogna attenersi alla regola "niente cibo fino alle prime operaie” per tutte le regine fondatrici di sciamatura autunnale. Queste regole non sono assolute. Ogni allevatore può, soprattutto in situazioni sperimentali, variare tempi e condizioni, ma raccomandiamo i neofiti di seguire attentamente la tipologia delle formiche che ha in cura. Ogni possibile sorpresa da parte delle formiche è una normale eccezione visto il genere di animale sociale che esaminiamo: le formiche sono VIVE! Non sono macchine! L'inverno e l'estate 2015/2016 e il conseguente autunno con le temperature anomale hanno fatto sballare periodi di sciamatura e comportamento di molte regioni, ma non dobbiamo considerare questo fatto come normale e archiviato, anche se dobbiamo tenerne conto!
Ultimo aggiornamento (Martedì 15 Novembre 2016 11:18)
Nome: Camponotus cruentatus Tassonomia: Tribù: Camponotini Genere:
Camponotus Sottogenere: Myrmosericus Areale di
distribuzione: In Italia nel Nord-Ovest della Liguria, ampiamente diffusa
nella Spagna continentale, zone costiere della
Francia meridionale. Ginia: monoginica Regina: 16-18 mm,
nera opaca con sfumatura arancione che si estende dal peziolo al primo tergite,
colorazione arancione più meno evidente anche del femore. Le operaie medie e major
hanno una colorazione di un tono più acceso. Maschio: 7.5 mm,
nero opaco uniforme. Operaie: 6-15 mm.
Sono presenti le tre caste minor, medie, major. Le minor sono tutte nere con
una leggera sfumatura cinerea sul gastro, le medie cominciano ad assumere la
sfumatura arancione caratteristica della specie, molto evidente e di colore più
acceso nelle major che presentano anche un capo di dimensione massicce e
possono essere considerati come soldati adibiti alla difesa. Alimentazione: in
natura sostanze zuccherine prodotte dagli afidi e insetti.
In allevamento: miele diluito in acqua, melone; camole della
farina, mosche, farfalle, drosophile, grilli, cavallette, blatte, tonno,
prosciutto cotto, pollo, paté di pollo per gatti … Umidità: arena
asciutta e nido per gran parte asciutto, leggermente più umido nella parte
inferiore per uova e larve. I bozzoli vengono portati principalmente nelle
camere superiori e meno umide. Temperatura
consigliata: per lo sviluppo della covata, da 27 a 32°C costanti. A
temperature di 23-24°C o inferiori si rischia di non vedere uno sviluppo
apprezzabile, specialmente nella crescita delle larve. Ibernazione: da
fine novembre a fine febbraio entra in diapausa, rallentando ogni attività,
mantiene le larve inattive fino al risveglio primaverile. Necessaria una
temperatura di 12-15°C, forse anche più bassa, ma non troppo (già a 15°C la
colonia è ferma e non si alimenta “quasi per niente”). In natura, con l’arrivo dell’autunno, l’attività esterna è
limitata alle ore centrali della giornata fino a cessare del tutto nel periodo
invernale (dalla fine di novembre alla fine di febbraio). Ai primi caldi di
marzo l’attività delle bottinatrici riprende sempre nelle ore più calde fino ad
arrivare alle 24h giornaliere da maggio a settembre. Nidificazione: prevalentemente
nella terra asciutta sotto grossi sassi assolati sotto i quali portano la
covata per approfittare del maggior calore. Nidi artificiali: gesso e gasbeton (ytong). Difficoltà: passate
le 50-60 operaie, se sottoposta ad elevate temperature costanti la regina
comincia a deporre grandi pacchi di uova che svilupperanno presto nuova forza
lavoro. Dopo il centinaio cominciano a nascere formiche di taglia superiore
quindi sono da prevedere ampi spazi, specialmente in arena, dato che amano
camminare a lungo. Da tenere conto anche la notevole lunghezza delle zampe e la
grande velocità/agilità delle operaie. Dal punto di vista alimentare, ad un certo punto ci si trova
ad avere centinaia di larve che necessitano di grandissime quantità di proteine
perché dalle 300-400 operaie la taglia media aumenta notevolmente e il rapporto
minor : medie : major pende molto verso le operaie maggiori. Le larve vengono
alimentate moltissimo e si cominciano a osservare formiche di 13-14 mm. Comportamento e
indole: specie molto aggressiva nella difesa del territorio e contro le
prede. Periodo di
sciamatura: in Italia, nella Liguria occidentale, dalla metà di giugno alla
fine di luglio. Sviluppo da regina
fondatrice: a buone temperature la regina in fondazione può arrivare a
20-30 operaie per poi aumentare notevolmente già l’anno successivo.
Consigliabile un riposo invernale per favorire una migliore partenza dal mese
di marzo; il secondo anno superano tranquillamente le 500 operaie. Tempi di sviluppo (a
temperatura ideale, circa 30°C): Uovo - larva: 16-20 giorni Larva - pupa: 10-20 giorni (molto influenzata da:
temperatura, umidità, numero di nutrici, disponibilità di fonti proteiche) Pupa - adulto: 15-23 giorni (a seconda della taglia delle
operaie: registrati 15-17 giorni per le minor, 17-20 giorni per le medie, 20-23
per le major). Ultimo aggiornamento (Domenica 16 Ottobre 2016 21:53)
Come dice il termine, un antifuga è un elemento/sostanza che serve ad evitare che le nostre formiche escano dalle loro arene e formicai…per disperdersi nell’ambiente circostante. Una delle maggiori preoccupazioni di un allevatore di formiche è, infatti, il ritrovarsi la casa invasa da questi simpatici insettini.
Gli antifuga si sono evoluti nel corso degli anni, passando dalle semplici reti e coperchi a sostanza chimiche repellenti di vario genere.
Va sottolineato che un antifuga ha validità soprattutto quando la colonia è tranquilla. Se le operaie sono agitate (perché spaventate, stressate, ecc…) possono anche, in un gesto di disperazione estremo, riuscire a superare qualunque tipo di antifuga.
Di seguito verrà fatta una carrellata dei principali e più diffusi sistemi di antifuga cercando, per ognuno, di elencare pro e contro.
Coperchio a rete:

E’ stato uno dei primi sistemi antifuga utilizzati. La rete può essere sia morbida (nylon, tela ecc…) che rigida (metallo, plastica ecc…). La rete può essere fissata sulla superficie dell’arena.
Esempio di realizzazione: Coperchio antifuga con rete metallica (link).
E’ un metodo poco usato, poiché ha diversi svantaggi. Anzitutto è di ostacolo per le normali procedure di manutenzione (alimentazione della colonia, pulizia arena, abbeveraggio ecc…) e, una volta rimossa la rete per accedere all’arena, c’è il rischio che una parte di operaie (soprattutto nelle specie veloci) escano e scappino. Alcune specie sono inoltre in grado di bucare le reti (soprattutto quelle morbide) o passare tra le maglia. Permette, tuttavia, di avere una buona areazione dell’arena, abbassando così le probabilità di marcescenze, condensa ecc…; oltre le fughe, evita anche gli ingressi indesiderati nel formicaio provenienti dall'esterno.
Coperchio rigido forato:
Sfrutta lo stesso principio del coperchio a rete. La differenza consiste nel fatto che, al posto della rete, si utilizza un coperchio precedentemente forato (con fori del diametro di uno spillo o anche di diversi cm). Nei coperchi in gomma il foro è semplice da fare. Basta usare un paio di forbici o una lama.
Per quelli di plastica rigida, invece, si può usare una lama scaldata in precedenza su una fiamma o un trapano.

Per quelli di metallo si usa il trapano, mentre i coperchi in vetro richiedono strumenti professionali (come le punte di diamante per trapano) e conoscenza di tecniche specifiche. Oltre agli svantaggi descritti in precedenza per i coperchi a rete, un coperchio rigido limita di molto la circolazione ed il ricambio di aria, generando un ambiente umido in cui è più facile la proliferazione di funghi e batteri. In particolari condizioni, ad esempio in caso la colonia resti incustodita per lungo tempo e si abbia la necessità di mantenere il nido più umido cos’ da evitare la disidratazione della colonia, il coperchio rigido offre un notevole vantaggio.
Fossato d’acqua:

Consiste nell’utilizzare l’acqua come vera e propria barriera invalicabile. Sfrutta il principio dei fossati dei castelli medioevali usati per isolare il castello dall’attacco di eventuali nemici. La tecnica consiste nel porre il formicaio e/o l’arena al centro di un contenitore pieno d’acqua. Per sollevare il formicaio/arena, si può usare un rialzo messo all’interno dell’acqua.
E’ un metodo il più delle volte sicuro. Sono infatti poche le specie in grado di attraversare fossati colmi di acqua e, perlopiù sono esotiche. Il rischio maggiore è di trovare spesso operaie annegate perché incautamente avvicinatesi, vengono “risucchiate” dalla tensione superficiale dell’acqua. Inoltre è una metodologia di antifuga molto ingombrante.
Strato di talco:
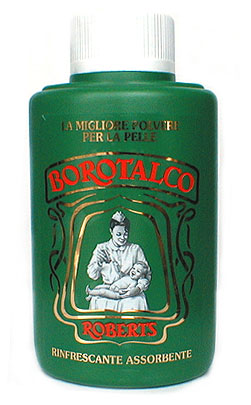
E’ un materiale che le formiche non apprezzano e da cui tendono a mantenere le distanze. Si può spargere sia sulle superfici verticali laterali dell’arena che su una bordatura costruita tagliando un enorme rettangolo centrale nel coperchio.
(dopo il taglio)

Si può solo spennellare il talco così com’è oppure si può unire un po’ di alcool per rendere il tutto un po’ liquido e successivamente spennellarlo sulle superfici. L’alcool evaporerà rapidamente, lasciando lo strato di talco. E’ un sistema di antifuga valido per molte delle specie di formiche. Semplice ed ecologico ha però lo svantaggio di perdere rapidamente di efficacia, soprattutto in ambienti umidi. Richiede quindi di essere rinnovato spesso.
Strato di olio:
E’ forse il metodo antifuga più usato. Consiste nello spargere con un pennello uno strato di olio sia sulle superfici verticali laterali dell’arena che sulla solita bordatura costruita tagliando un enorme rettangolo centrale nel coperchio (vedi foto sopra). Ha il vantaggio di costituire una barriera quasi invalicabile per le formiche, soprattutto se posta nella bordatura del coperchio (per una formica è impossibile camminare a testa in giù su una superficie oleata). Purtroppo ha lo svantaggio di tendere a colare (soprattutto con il caldo). Per ovviare a ciò, si può passare con un cotton fioc la superficie trattata così da togliere l’olio in eccesso…oppure si può unire del grasso di vaselina (acquistabile in ferramenta)

così da rendere più denso il composto (facendo attenzione che non sia troppo denso altrimenti le formiche riusciranno a camminarci sopra). Inoltre è facile che soprattutto le operaie delle specie più piccole restino invischiate nell’olio (soprattutto se si usa olio liquido). Esistono numerose ricette al riguardo. Si può usare del semplice olio di vaselina (acquistabile in farmacia) o fare dei mix di diversi oli (il più diffuso ed efficace è un mix in parti uguali di olio di vaselina e olio per macchine da cucire). Hanno una buona durata nel tempo (anche diversi mesi), soprattutto se si aggiunge del grasso di vaselina.
Antifuga venduti online:

Sono sostanze sintetiche di sconosciuta composizione che creano una barriera invalicabile. Si utilizzano come gli oli, senza tuttavia presentare lo svantaggio di colate. Hanno una buona durata nel tempo.
L’arena è l’ambiente esterno del nostro formicaio. Come per la costruzione del nido, il gusto personale e la scelta di diversi materiali fanno la differenza; più che per il nido, l’arena richiede la gestione oculata degli spazi, perché deve simulare il territorio dove le nostre formiche andranno a caccia e incontreranno eventuali prede.
Dico da subito che anche qui non c’è una regola precisa per realizzare l’arena. Ognuno si adatti allo stile che preferisce. Sono però utili delle precisazioni e dei consigli tecnici minimi, per cui cercherò di fare un quadro generale dei tipi di arena di cui abbiamo esperienza e le indicazioni su come realizzarle al meglio.
Un esempio è nel prevedere sempre in anticipo una eventuale seconda uscita nell'arena. Potrebbe essere utile per ampliare lo spazio vivibile, fare esperimenti, collegare un secondo nido. Operare nuovi fori a formicaio già collegato comporta notevole stress per le formiche, quindi, pensateci bene prima!
L’ACCESSO ALL'ARENA.
Dal nido propriamente detto all’ambiente esterno si possono avere diversi tipi di collegamento:
Accesso diretto: come nel caso dei nidi di gesso di tipo 2, che incorporano nido e arena nello stesso elemento
Accesso collegato tramite tubo diretto: dal blocco del nido, con arena a contatto, un tubo attraversa il materiale e sbuca lateralmente, o dal basso, affacciandosi direttamente nell’ambiente esterno
Accesso con tubo lungo che sviluppa un percorso: dal nido esce un tubo preferibilmente flessibile, che fa percorrere alle formiche un tratto di strada regolabile, permettendo alle operaie di camminare più a lungo.
Il tubo lungo può sviluppare un percorso, può avvolgersi a spirale per occupare meno spazio e consentire ugualmente un percorso lungo, può essere modulare, con raccordi che permettono di allungarlo o accorciarlo alla bisogna. E’ sempre meglio evitare di far fare a questi tubi tratti nettamente verticali; alcune formiche trasportano semi, i tubi possono essere inizialmente troppo lisci e troppo ripidi per loro, e rendono il ritorno al nido a volte impraticabile.

I tubi devo essere abbastanza grandi da far passare piccole prede, ma è sempre meglio che non superino troppo le dimensioni ideali della specie che dovrà sfruttarli: accessi troppo grandi rendono il nido indifendibile e le formiche tendono spesso a barricarsi; se il diametro del tubo è troppo grande, le barricate sono difficilmente realizzabili! Molte formiche hanno l’istinto di rinchiudersi in fase di invernamento, e gradiscono poterlo fare senza troppa fatica.
Usare tubi trasparenti, meglio se privi di odori e abbastanza sottili da poter essere piegati senza creare strozzature. Esistono in commercio (ferramenta, negozi casalinghi, bruco center) tubi appositi definiti “per alimenti” che non contengono sostanze tossiche nocive alle formiche. Chiedete espressamente quelli.

SICUREZZA ANTI-EVASIONE
Come è già stato spiegato nell'articolo sull'antifuga, diversi sistemi e prodotti possono essere applicati per contenere le nostre formiche. E' bene qui riassumerle per coloro che leggano per la prima volta questa scheda: L’arena è uno dei punti critici e più temuti dai profani per il contenimento delle formiche.
Ci sono anche qui diverse correnti di pensiero.
Coperchio sigillato: è certo che niente uscirà!
Controindicazioni: le formiche possono stazionare sotto il coperchio (che è meglio sia sempre trasparente!) e quando vorrete aprirlo avrete il problema che correranno ovunque.
Il coperchio chiuso, anche se praticate dei forellini, non lascerà mai circolare abbastanza l’aria nell’arena: il rischio di muffe, marciume, malattie e cattivi odori è elevato; l’umidità ristagna, i veleni eventuali delle formiche rendono l’arena a lungo andare una trappola.
Coperchio con retina: esistono in commercio retine metalliche finissime. Non sono sempre e ovunque reperibili, non sempre sono abbastanza traspiranti, e in ogni caso le formiche vi si possono arrampicare e stazionare in attesa che voi apriate.
Arene aperte: da tempo l’arena aperta è una realtà accettata e funzionale.
Utilizzando diversi sistemi repellenti possiamo permetterci di tenere aperto lo spazio esterno senza che le formiche possano uscire. I vantaggi sono un facile accesso all’ambiente dove vogliamo osservare e lavorare, e nessun problema di muffe e marciumi, che in ogni caso possono essere facilmente rimossi. Anche fornire nuovo cibo alle formiche non presenta problemi.
I sistemi repellenti sono già citati nell’apposita scheda ma vale la pena di ripetere quali siano i migliori.
Alcool e borotalco (il famoso talcool). Una mistura di talco e alcool viene spalmata sulla superficie alta dell’arena e l’alcool, evaporando, rende il talco abbastanza difficile da scalare e moderatamente repellente per molte formiche. Inconvenienti: a lungo andare lo strato si deteriora e va spalmato spesso, in rapporto alla qualità, alle superfici e al tipo di formica che tenterà di superarlo.
Repellenti chimici in vendita: non sempre reperibili e relativamente costosi, ma di sicuro funzionamento.
Repellente fatto in casa: il più classico e sperimentato con successo è il classico impasto “pasta di vaselina bianca e olio lubrificante”, quello per svitare, per oliare gli ingranaggi, quello minerale insomma! E’ stato scritto centinaia di volte in ogni articolo, diario, scheda, e ancora qualcuno ha il lampo di genio di usare olio d’oliva! Aggiungere anche un po’ d’aglio e peperoncino può dare risultati inaspettati: le formiche ringrazieranno!!! Non dimenticate di mescolarlo con della pasta ben al dente!
Questa mistura (50%+50%) applicata alle superfici ha una lunga durata, è efficace e decisamente economica. Applicata su una superficie di 2-3 cm almeno, non cola e trattiene le formiche all’interno.
Ma tutti questi repellenti richiedono una caratteristica di sicurezza ulteriore, per essere veramente sicuri: vanno applicati su superfici “a tetto”, cioè su un risvolto del coperchio, sul bordo della “finestra” superiore dell’arena. Spalmarlo sulle pareti verticali potrebbe non bastare e in condizioni di stress, o con formiche molto agili (quindi piccole e leggere) si possono riscontrare fughe che con un capace bordo a tetto si evitano. Più la superficie spalmata è ampia, migliore la sicurezza.
In ogni caso, rinnovare ogni mese la mistura non è male: spesso alcune formiche riescono a ricoprire la vaselina con detriti e a passarci su. Se l’olio è ben distribuito non lo fanno. E’ l’olio, non la vaselina, il repellente!
ARENA BASE per provette o nidi di accrescimento
Per colonie piccole, incipienti, per iniziare ad aprire la provetta in uno spazio vivibile e poter gestire l’alimentazione delle formiche altrimenti impossibile in una provetta affollata, non occorrono grandi spazi.
Una scatola di plastica da gelato, meglio ancora le classiche Ferrero Rocher, o qualsiasi contenitore (sempre meglio trasparenti) alimentare in vetro, o plastica, si adatta all’uso. Avere un coperchio che si possa forare e aprire a finestra, come abbiamo visto, è utile. Ogni altra possibilità, come costruirsi scatole in plexiglas, utilizzare piccoli acquari, o altre idee, sono possibili, ma fin troppo laboriose per il primo utilizzo.
Con formiche piccole come Plagiolepis, o Temnothorax, non occorrono grandi spazi. Meglio concentrarsi sul fatto che i collegamenti eventuali siano ben sigillati, che l’antifuga copra una buona fetta di parete, e trascurare substrati o terreni complessi dove le formiche potrebbero facilmente occultarsi. Lasciare il pavimento sgombro, o coprirlo con una sottile colata di gesso, magari colorata, che renda meno “freddo” l’ambiente.
Ricordate che salvo nel caso delle specie suddette, in alcuni mesi le vostre colonie cresceranno e magari dovrete cambiare nido ed arena, quindi l’arena-base va considerata un passaggio, come i nidi di accrescimento, quindi è controproducente spenderci troppe energie, perché presto non basteranno più allo scopo.
Chi voglia partire da subito con un arena molto grande non fa un gravissimo errore, solo punta troppo in alto! Il problema è che le formiche ci scompariranno, le giovani operaie non vanno troppo lontano e all’inizio per osservarle è superfluo, inoltre, molti allevatori gestiscono più colonie, e soprattutto in fase iniziale, avere grandi arene per piccole colonie è ideale per chi possieda ville californiane, e più stanze proprie in cui giocare a calcio o fare jogging, ma chi deve dividere la camera con fratelli, sorelle o fidanzate, capisce di cosa sto parlando.
NIDO CONTENUTO IN ARENA: Con formiche molto piccole e dalle limitate esigenze di spazio, si può considerare di inserire il nido direttamente in arena. E' il caso dell'esempio sotto, in cui Temnothorax può benissimo essere alloggiata in canne di bambù applicate al vetro dell'arena stessa in cui tutto sarà facilmente maneggiabile. Il substrato di ghiaia non crea problemi perché è basso, molto pesante per queste formiche, le quali comunque scelgono sempre di installarsi in dalle, bacche o rametti.
Dovendo inserire nidi più pesanti e complessi (come in gesso o gasbeton) bisogna considerare diversamente la tenuta del nido sul pavimento o sulla parete perimetrale, perché deve essere ben fissata, e potrebbe creare problemi in fase successiva, quando si volesse cambiare nido, cambiare arena o trasferire la colonia per altri motivi.

ARENA CON FONDO FISSO
Che sia una scatoletta di gelato, che sia un acquarium 2 m x 5, il “substrato”, la base su cui le vostre formiche correranno, è importante non solo per il loro piacere o per la vivibilità, ma anche per la visibilità delle stesse e per la gestione nel tempo dell’arena.
Anche qui possiamo sbizzarrirci: si possono semplicemente lasciare le formiche su un fondo anonimo, oppure plasmarlo colando del gesso che, solidificandosi, renderà la superficie esterna (finta), il pavimento su cui le formiche usciranno in cerca di cibo, e dove porteranno i rifiuti.
La colata di gesso è una delle scelte più comode: permette di avere una superficie rugosa o liscia, colorabile con tinte naturali. Può essere arricchita con sassolini, piante, rametti o altri elementi, che, se inseriti in fase di gesso fresco, asciugandosi verranno intrappolate e resteranno stabili nel tempo, rendendo l’ambiente relativamente “naturale”. Le possibilità sono molteplici e gli appassionati del bricolage hanno da insegnarci tutto sulla reperibilità di materiali più o meno adatti, su come scegliere elementi veri o fantastici (c’è chi ama il modellismo e tenterà di riprodurre ambienti naturali, ma anche antropici, come case, ferrovie e castelli!
Ognuno è libero di scegliere con la propria fantasia... tanto le formiche non vi capiranno!
Ricordate solo che poi questi ambienti vanno ripuliti, almeno di tanto in tanto, ma soprattutto se allevate formiche come Messor, verranno ridotti a vere e proprie discariche di rifiuti! Pensateci bene prima di lavorare troppo con la fantasia.
Alcune sostanze verranno rosicchiate, altre verranno sepolte dai rifiuti, altre ancora ignorate… Ricordate sempre che l’arena deve poter essere ripulita o sostituita! Dopo sei mesi potrebbe non piacervi più, potreste avere idee migliori, materiali più belli, formiche più numerose. L’arena non può essere eterna!

ARENA CON FONDO MOBILE
Le arene possono anche essere ambientate con materiali del tutto naturali, come terra, sabbia, argilla, sassi, ghiaia, o un misto di tutti questi elementi.
Anche questi materiali vanno ponderati con attenzione. Il primo problema è che le formiche tendono a utilizzarli: in pochi giorni potreste trovarvi le stanze interne di osservazione con i vetri ricoperti di humus, di sabbia incollata alle finestre, con ogni sorta di detrito che le formiche porteranno dentro cercando di tappare buchi, limitare spazi che a loro sembrano superflui, mentre voi li avevate scavati con cura e amore; oppure, semplicemente, si trasferiranno all’esterno SOTTO il vostro bellissimo substrato naturale!
Questo comporta che nel momento in cui decidete di ambientare l’arena con uno strato che le formiche possono elaborare, questo materiale deve essere meno spesso possibile, e se è anche pesante è meglio, così non lo appiccicheranno ai vetri, magari usandolo come ponte sull’antifuga per evadere!
Le formiche amano scavare, rivoltare il terreno, barricarsi. Porteranno tutto il possibile presso l’entrata principale, e se il vostro tubo di entrata è troppo piccolo lo ostruiranno.
Se è troppo grande riempiranno le stanze sottostanti cercando impilare all'entrata materiale che non è possibile resti coeso. Mettete sassi e sassolini presso l’entrata, cercheranno di spostare tutto da un’altra parte, liberando l’entrata perché loro vogliono più spazio… insomma, non ragionano mai come vorremmo noi.
I vantaggi di un fondo mobile e scavabile sono che le formiche potranno lavorare, potranno crearsi dei nascondigli senza nascondersi troppo, avranno sostanze a cui attingere per tappare spifferi e gallerie stimate inutili o pericolose. Un altro vantaggio è che rivolteranno continuamente il materiale, miscelando detriti con scarti dei pasti, morti della colonia e parti immangiabili delle loro prede.
Quando verrà il momento di fare pulizia basterà tappare l’entrata al formicaio e rimuovere pazientemente tutto il materiale depositato, che potrà essere buttato e sostituito con altro substrato pulito, oppure, se è materiale pregiato, potrà essere lavato e riutilizzato. A pulizie ultimate, potremo riaprire l’accesso del nido.
Con questo sistema è necessario recuperare le formiche rimaste all’aperto per poi reinserirle, oppure, se la colonia deve essere sfoltita, è l’occasione buona per eliminare queste operaie che nel 75% dei casi sono operaie anziane.
Usare un fondo mobile non è sempre la scelta migliore, ma con formiche molto grandi come Messor e Camponotus, si presta abbastanza bene e consente di tenere le formiche attive anche all’esterno del nido.

ARENA AMBIENTATA
Questa è il tipo di arena che tutti sognano: terreno vero o falso che sia, piante vere o finte, un bel terrario con rami e sassi è la ricostruzione fedele dell’ambiente in cui immaginiamo le nostre formiche possano essere felici. Io sconsiglio sempre di usare piante vere: le piante sono organismi viventi che necessitano di substrato vero, e questo non farà altro che attirare l’interesse delle formiche che lo scaveranno facendo morire le piante. I bravi modellisti sono in grado di ricostruire perfettamente una fetta di prato, di deserto, o di boscaglia, mescolando elementi reali con ricostruzioni del terreno in gesso, gasbeton o altro materiale artificiale. Incollare e montare i pezzi in un diorama che imiti la realtà è appannaggio dei costruttori più abili e fantasiosi. Lo spazio previsto va ben gestito, con punti appositi dove poter mettere le esche per dar da mangiare alle formiche, che potranno essere osservate quasi come in natura.
Questo tipo di arena, che esteticamente è la più bella, richiede spesso molto spazio, e non deve essere eccessivamente ricca. Anche qui, più elementi ci sono, più difficile sarà pulire, osservare le formiche, e recuperarle se decideranno di trasferirsi sotto qualche sasso o ramo, cosa che a loro piace tanto.
Sconsiglio quindi l’inserimento di muschio, strati di humus, pacciamatura, sia veri che artificiali, a meno che siano impenetrabili alle formiche. Un muschio artificiale si può incollare al fondo, ma non deve avere uno spessore eccessivo; formiche molto piccole vi si infiltreranno prima o poi, scomparendo alla vista.
Ricordo ancora una volta il motivo per cui cerchiamo di allevare le formiche, che va oltre il puro piacere di avere delle formiche in casa: noi le vogliamo vedere! Per questo l’uso di terrari naturalistici è da scartare per chi voglia davvero osservare, studiare, accudire una colonia di insetti: se si occultano completamente alla vista non potremo nemmeno sapere di che salute gode la colonia! Sono stati studiati e realizzati diversi sistemi per diminuire gli strati di terreno in cui le formiche possono occultarsi, come inserire spessori, blocchi che limitano lo spazio scavabile, ma la capacità delle formiche di nascondersi e andare a cercarsi un riparo che non sia quello da noi previsto è sempre da mettere in conto.
Quindi ponderate bene l'uso dei formicai nido-arena-tutto-compreso, anche se sono sicuramente belli (un esempio ben riuscito qui sotto), piccole giungle in miniatura, soprammobili pittoreschi, ma con possibili limiti oggettivi di gestione delle formiche sul lungo tempo.
Le soluzioni migliori se si vuole procedere in questo campo, sono le arene con ambientazione semi-desertica, con pavimenti moderatamente corrugati (le fessure si riempiono di detriti in breve), sassi, rami ben stagionati, ravvivando con piante artificiali che imitino il più possibile la realtà, ma badando di non eccedere con gli elementi. Per ottenere una base solida ma naturale, si possono mescolare sabbia e cemento, gesso con argilla, semplice gesso colorato…

Per quel che riguarda le tecniche e i materiali lasciamo ai modellisti il piacere di trovare i materiali più adatti: ognuno ha le proprie preferenze e sarà più competente di me nel dare consigli. A questo proposito invitiamo chi voglia completare questa scheda a fornirci indicazioni dettagliate che inseriremo per completarla in un secondo tempo.
Ultimo aggiornamento (Domenica 14 Gennaio 2018 12:12) Ultimo aggiornamento (Domenica 14 Gennaio 2018 12:13)

Nome scientifico: Lasius (Chthonolasius) meridionalis Famiglia: Formicidae Sottofamiglia: Formicinae Genere: Lasius Sottogenere: (Chthonolasius) Ginia: Monoginica. Regina: dimensioni 8 - 9 mm; color marrone più o meno chiaro. Operaie: colore giallo-arancione, dimensioni 3-5 mm - non presenti caste. Areale di distribuzione: Comune in utta l'Italia, meno frequente in pianura Alimentazione naturale: Melata e piccoli artropodi. Alimentazione artificiale: Miele o zucchero diluiti, camole, lepidotteri, frutta dolce, crocchette x gatti, insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi, meglio di tipo "morbido”. Umidità: Fornire un gradiente con parte asciutta e parte umida Temperatura ideale di sviluppo: 20-27°C Ibernazione: Consigliata, essendo specie di media-montagna. Formicai in natura: Preferibilmente nel terreno. Spesso sotto sassi e legni depositati sul suolo e riscaldati dal sole come incubatori per le pupe che richiedono calore asciutto e meno umidità. Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra. Difficoltà: Abbastanza semplice, delicata in fase di fondazione. Indole: Formica molto laboriosa e abbastanza combattiva. Periodo di sciamatura: di solito Agosto. Tipo di fondazione: Parassitaria. La specie preferita è Lasius emarginatus. Molte regine provano a fondare nella stessa colonia (pleometrosi), probabili casi di poliginicità.
Grazie alla predilezione per Lasius emarginatus la colonia cresce bene e viene alimentata senza problemi. Il metodo migliore per creare una nuova colonia è quello di far adottare la regina da un piccolo manipolo di operaie con almeno una trentina di pupe, meglio un centinaio.
Le operaie di Lasius emarginatus, meglio se giovanissime, vanno tenute per qualche tempo in una provetta con tutte le pupe disponibili (altre pupe possono essere aggiunte anche in un secondo momento) in modo che si tranquillizzino e si sentano al sicuro rivolgendo tutta l'attenzione alla prole. Introdurre la regina quando è tranquilla, accoppiando le due provette. La regina è in grado di sopravvivere pochi giorni senza essere nutrita per cui conviene fornire pupe pronte a schiudersi. Lei stessa parteciperà attivamente all'apertura dei bozzoli e alla cura di eventuali larve. Se la provetta è abbastanza stretta, presto la regina verrà accettata dalle operaie. Dopo qualche giorno, aprire la provetta in arena e fornire zucchero di canna inumidito e acqua.
Se la regina è regolarmente nutrita, quando verranno raggiunte almeno 30 operaie, inizierà a deporre. Lo farà in modo massiccio e quindi bisognerà cominciare a fornire anche proteine, meglio se sotto forma di insetti morbidi.
Questo dovrebbe accadere dopo 15/20 giorni. In questa fase è importante continuare a fornire una grande quantità di cibo proteico in modo da far sviluppare tutte le larvette.
Verso ottobre la colonia va messa in un luogo freddo per affrontare l'inverno. Porre attenzione all'umidificazione che non deve essere eccessiva.
Al risveglio in primavera le attività diverranno frenetiche portando allo sviluppo contemporaneo delle larve in pupe e infine alle prime nascite.
Riprenderanno le deposizioni. Dopo qualche tempo nasceranno le prime operaie che verranno regolarmente bloccate e disturbate delle operaie di L. emarginatus. Il fatto però di avere un gran numero di larvette che richiedono attenzioni, porta a distrarre molto le operaie di L. emarginatus che permetteranno alla maggior parte di nuove nate di sopravvivere. Le nuove nate non si vedranno mai in arena per almeno i primi 10 giorni. Dopo di che inizieranno ad avventurarsi fuori in cerca di cibo spinte dalle necessità della colonia. Mano a mano che il numero delle operaie di L. meridionalisaumenterà, le L. emarginatus tenderanno a raggrupparsi in zone specifiche del formicaio, rimanendo comunque le principali foraggiatrici. Con l'andare del tempo il numero delle operaie ausiliarie tenderà a diminuire anche se non ho mai assistito ad atti di aggressione.
Alla fine del secondo anno la colonia sarà popolosissima; dal terzo anno si potrebbero avere già degli alati. In cattività possono vivere in quasi tutti i materiali, ma si tratta di una specie piuttosto determinata, se decide di scavare c'è poco da fare; prevedere sistemi di antifuga e contenimento. La soluzione migliore dovrebbe essere gasbeton con nido orizzontale e possibilmente colorato di scuro. Curiosità:
- Le operaie di Lasius emarginatus sembrano rivolgere un'attenzione maggiore alla regina di L. meridionalis rispetto a quello che fanno con regine della stessa specie. - il secondo anno, una colonia di L. meridionalis confrontata con una di L. emarginatus della stessa età, risulta essere almeno 4 volte più numerosa. Osservazioni: Alle prime schiuse di operaie di L. meridionalis si assiste a una serie di atti di "bullismo" da parte delle operaie di L. emarginatus che tendono a bloccare e strattonare le nuove nate. Questo comportamento si interrompe nel momento in cui il numero di operaie di L. meridionalis supera quello delle L. emarginatus. Perché questi atti aggressivi non si manifestino è importante che la colonia nelle prime fasi venga nutrita adeguatamente in modo da far portare avanti tutte le uova della regina. - Altrettanto interessante è un'altra caratteristica che è stata osservata successivamente, cioè che Lasius meridionalis, quando la colonia è avviata e non ci sono più operaie ausiliarie, mostra scarsa (o nulla) aggressività verso operaie estranee della stessa specie. - Le operaie di L. meridionalis tendono a non scalare ostacoli verticali e un pò controvoglia risalgono eventuali tubi in plastica per raggiungere l'arena. Se possibile usare i tubi in plastica solo in orizzontale, quando si devono comunque usare in verticale potrebbe essere buona norma infilarci dentro un stelo d'erba secca un filo di spago sottile o qualcosa di simile. Tutte queste osservazioni sono da confrontare con le esperienze degli altri allevatori che si cimenteranno con la stessa specie, sappiamo ancora molto poco delle nostre formiche autoctone!!! Scheda redatta da: Angelo Cardillo 

Ultimo aggiornamento (Venerdì 14 Ottobre 2016 14:33)

Dopo circa un anno di sperimentazione di nidi artificiali, dei vari materiali da usare per costruirli, dei pro e contro di ogni materiale e delle diverse condizioni ambientali che si riscontrano in cattività rispetto alla vita in natura, ho voluto realizzare un nido innovativo che rappresentasse un connubio tra estetica (l’occhio vuole la sua parte), funzionalità e naturalità.
La cosa non è stata facile, poiché gli aspetti da tenere in considerazione sono molteplici, come la temperatura maggiore in un nido artificiale rispetto al suolo, la diversa tipologia di fornitura di acqua, la maggiore scavabilità di certi materiali, ecc…
Questo nido che vi propongo è sicuramente molto più elaborato e difficile nella sua realizzazione…ma è anche quello che, sui dati teorici, risulta essere il più adatto per l’allevamento di quasi tutte le specie di formiche (eccetto quelle prettamente arboricole).
Prima di descrivere le fasi di realizzazione del formicaio ibrido, bisogna fare un’introduzione generale.
Partiamo dal principio e, cioè, dall’analisi dei maggiori pro e contro di ogni materiale solitamente impiegato per la realizzazione di formicai artificiali.
I materiali più in voga sono: gesso, cemento e gasbeton.
Gesso:
Pro: ottima umidificazione e facilità di lavorazione che permette di giocare su forme e contenitori così da avere un nido “su misura”.
Contro: facilmente scavabile (soprattutto se bagnato) e facilmente attaccabile da patogeni (muffe, funghi e batteri).
Cemento:
Pro: maggiore resistenza allo scavo e all’attacco di patogeni e possibilità di modellarlo al contenitore che si vuole usare.
Contro: maggiore peso, pessima umidificazione, produzione di polvere bianca in seguito a migrazione di sali dall’interno all’esterno (quando si bagna il materiale) e formazione di crepare se umidificato eccessivamente.
Gesso + cemento:
Pro: maggiore resistenza allo scavo rispetto al solo uso di gesso, capacità di umidificazione maggiore rispetto al solo uso di cemento e maggiore resistenza a patogeni rispetto al solo gesso.
Contro: formazione di patina bianca in conseguenza della migrazione di sali, maggiore peso rispetto al solo gesso e rischio di crepatura quando si bagna il composto.
Gasbeton:
Pro: ottima umidificazione, facilità di scavo dei cunicoli, buona resistenza all’attacco di patogeni e leggerezza.
Contro: facilità di scavo, estetica artificiale tanto nei colori quanto nella forma (vengono venduti mattoni quasi bianchi che difficilmente si riesce a tagliare in modo preciso così da farli incastrare bene in contenitori chiusi e il colore chiaro fa vedere male uova e larve).
Le differenze tra natura e cattività sono enormi. Anzitutto pensiamo agli equilibri che si creano nella terra tra proliferazione di funghi, batteri, muffe e acidità della terra, organismi pascolatori ecc. Questo equilibrio è difficilmente riproducibile in cattività, se non con l’impiego di organismi pascolatori facilmente allevabili (come copepodi) e l’utilizzo di sostanze acide nella realizzazione e umidificazione dei formicai (ma l’effetto sulle formiche è ancora da accertare).
Inoltre temperatura ed umidità sono molto differenti.
In natura, quando fa molto caldo e la terra diventa secca, le formiche si spostano in profondità scavando tunnel in perpendicolare così da trovare terra umida e temperature più basse. In cattività questo solitamente non accade e la temperatura resta solitamente uguale a quella esterna in tutto il nido. Tali temperature portano ad una maggiore secchezza del nido artificiale che, spesso, sfocia in morie generali in conseguenza di una forte disidratazione delle formiche stesse.
Detto questo partiamo con la descrizione del nido “ibrido”. Lo definisco ibrido poiché è il frutto dell’unione dei 3 materiali principali (gesso, cemento e gasbeton)…cercando di sfruttare al meglio i pro di ognuno e isolare e limitare il più possibile i vari contro.
Il principio che ho seguito è stato quello di sfruttare la plasticità e la robustezza del composto gesso/cemento per creare un blocco formicaio e sfruttanre la capacità di umidificazione del gasbeton.
Come prima cosa ho realizzato il contenitore nel quale fare successivamente la colata del composto gesso/cemento. Ho quindi costruito una scatola in legno con le pareti apribili…così da non avere problemi nell’estrazione del blocco di gesso/cemento.
Nel valutare la dimensione ho tenuto la cassa di legno più grande di 0,5 cm rispetto al vetro di copertura del formicaio, così che quest’ultimo si incastrasse in una scalanatura creatasi in fase di gettata.


Per non rischiare di rovinare il vetro del formicaio, ho tagliato un pezzo di plexiglas delle precise dimensioni del vetro del formicaio. Come vetro, per maggiore facilità di reperimento ed economicità, ho usato un vetro “cornice a vista” di 25x35 cm venduto in qualunque supermercato (ci sono di molte misure). E’ un vetro sottile, quindi bisogna stare attenti.

A questo punto ho preparato la pasta al sale con cui ho realizzato camere e cumicoli di collegamento sopra alla lastra di plaxiglas. La ricetta che io uso è:
-Sale: 1 parte;
- Farina: 1 parte;
- Acqua: ½ parte;
In caso il composto venga troppo umido, si può aggiungere un po’ di farina. Successivamente ho posto il plexiglass all’’interno della cassa e chiuso i lati.



A questo punto ho realizzato dei parallelepipedi di gasbeton.

Successivamente ho verniciato tutti i lati eccetto uno dei lati lunghi. Questo serve a creare un’ impermeabilizzazione del gasbeton così da non cedere acqua al blocco di gesso/cemento.

Quindi ho creato un buco in uno dei lati più piccoli.

Per assecondare l’istinto naturale delle formiche di cercare l’umido in profondità, ho posto i parallelepipedi come base nell’ultima (o nelle ultime) stanze del formicaio. In questa maniera, per evaporazione, si creeranno anche gradienti di umidificazione diversa dell’aria lungo le stanze superiori. Nei fori realizzati ho inserito dei tubi di gomma da aeratore (li si trova nei negozi di acquari) ed ho fatto uscire il tubo principale da un foro realizzato nella cassa di legno.


A questo punto ho preparato il composto cemento/gesso (solitamente faccio 1 parte di gesso e 1 parte di cemento), colorando l’acqua della gettata con ossidi colorati (si trovano nei colorifici).

Una volta solidificato il blocco, i tubi di collegamento dei parallelepipedi di gasbeton restano all’interno del blocco (quindi invisibili), mentre i parallelepipedi stessi risultano completamente inseriti nel blocco e vanno a costituire la pavimentazione delle ultime stanze del formicaio. Per rendere questa pavimentazione più naturale, con un coltellino la si lavora…così da fargli perdere l’aspetto dritto e preciso che ha naturalmente la lastra di gasbeton.


Una volta ottenuta la placca formicaio e aver tolto la pasta al sale, ho verniciato le parti del formicaio non a contatto con le formiche. Questo per un fattore estetico e di maggiore protezione della placca dall’umidità ambientale. Come piede del formicaio ho usato un’ascia di legno scuro su cui ho fissato il formicaio mediante delle viti. Ho quindi posto l’arena sopra il formicaio attaccando anche questa con delle viti. L’arena è costituita semplicemente da una scatola di plastica trasparente.


Il tubo di umidificazione è stato fissato ad un serbatoio esterno collocato sul lato del formicaio (o dietro).
(in questo caso ho usato un tubo di maggiori dimensioni)


Per creare un effetto il più naturale possibile, ho rivestito la parte interna delle stanze con un sottilissimo strato di argilla (pura argilla modenese…praticamente la terra, da noi, è così) lasciata successivamente solidificare al sole (diventa dura come roccia). Successivamente ho inserito dei frammenti di muschio essiccato che tende a creare un effetto naturale molto bello e, anche se bagnato, non forma facilmente muffe.



Il vetro si incastra perfettamente nella placca. Per maggiore sicurezza ed evitare antiestetiche cerniere di metallo, ho fissato il vetro con pezzetti di un potente nastro adesivo successivamente verniciato del colore della placca…così da renderlo quasi invisibile.

Il principio di questo formicaio è quello di un blocco di gesso/cemento (facilmente lavorabile come uno vuole) protetto dall’umidificazione. Quest’ultima, infatti, sfrutta la capacità del gasbeton di umidificarsi. Le formiche avranno le stanze inferiori con un pavimento molto bagnato (e dal quale potranno bere e su cui potranno appoggiare uova e larve che richiedono maggiore umidità) e stanze superiori più secche in cui stazioneranno la maggior parte delle operaie, terranno il cibo e le pupe (che vogliono meno umidità). Il blocco, non bagnandosi direttamente, si conserva integro e più duro allo scavo. Se anche qualche specie riuscisse a bucare il gasbeton, comunque resterebbe all’interno del formicaio stesso…e la quantità di materiale scavabile è minima (semplicemente qualche cm dei parallelepipedi).
Ultimo aggiornamento (Sabato 16 Agosto 2014 14:41)
Ecco un piccolo, facile ed economico formicaio da usare per specie arboricole.
Questi formicai sono piccoli (12x8 cm e 19x10 cm) poichè li ho realizzati rispettivamente per l'accrescimento di una colonia di Camponotus truncatus e Temnothorax unifasciatus. Entrambe sono specie che creano colonie poco numerose, quindi formicai piccoli sono più che adatti.
La realizzazione di ogni formicaio ha richiesto non più di un'oretta di lavoro e con meno di 10 euro di spesa.
Il materiale occorrente è il seguente:
- 2 lastre di plexiglass (stessa larghezza ma una più lunga ed una più corta);
- Pezzo di sughero di 0,5 mm di spessore (per le specie più grosse è meglio usare quello da 1 cm) delle dimensioni della lastra più piccola di plexiglass;
- Vaschetta arena in plastica (più o meno delle dimensioni della differenza tra le due lastre di plexiglass);
- Tubo da areatore per acquari;
- 4 dadi e bulloni;
- Utensili vari (cacciavite, forbici, accendino e scalpello per legno);

Come prima cosa, prendere due piastre di plexiglass e tagliarle (io uso un taglierino ) in modo tale che abbiano la stessa larghezza ma una sia più lunga dell'altra. Quella più lunga andrà a costituire la base del formicaio (e porterà l'arena), mentre la più corta andrà a costituire la facciata superiore del formicaio (dal quale osserveremo le nostre formiche). Fare 4 buchi in ogni piastra (facendo in modo che, sovrapponendo le piastre, i buchi coincidano...questi serviranno per avvitare successivamente le due piastre). Per farli io uso un paio di forbici a cui scaldo con un accendino la punta...così che attraversi il plexiglass facilmente.


Scavare, usando uno scalpellino per legno o una forbice, il pezzo di sughero, così da creare stanze e corridoi di collegamento.


A questo punto unire la piastra più lunga e quella più corta mettendo al centro il pezzo di sughero. Usare un pezzettino di tubo da areatore come tubo di congiunzione tra il formicaio e l'arena. Usare quindi le viti per fissare il tutto.




Praticare un piccolo foro vicino la base dell'arena così da farci passare una parte del tubo per areatore inserito nel formicaio. Unire quindi l'arena incollandola sulla piastra di plexiglass più lunga o fissandola con dadi e bulloni.




Ecco uno dei formicai con la colonia di Camponotus truncatus.



Le specie arboricole vivono il più delle volte in ambienti molto secchi. Non necessitano, quindi, di umidificazione interna del formicaio (che rischierebbe di creare funghi e batteri sul sughero).
Basta quindi lasciare una buona riserva di acqua in arena.
Ultimo aggiornamento (Domenica 20 Luglio 2014 14:34)
 Specie: Aphaenogaster subterranea Specie: Aphaenogaster subterranea
Tassonomia: Famiglia: Formicidae - Sottofamiglia: Myrmicinae - Genere: Aphaenogaster Areale di distribuzione: Comune in tutta Italia, pianura o collina fino a 800-1000 m. Predilige ambienti umidi, sottobosco, facile trovare i nidi sotto le pietre. Taglia delle operaie: 3 - 5 mm
Taglia delle regine: 7 - 8 mm Taglia dei maschi: 5 - 6 mm Colore della regina e delle operaie: Marrone scuro-rossiccio, lucida, con zampe e antenne tendenti al giallo scuro.
Periodo di sciamatura: luglio-agosto. Colonie: monoginiche, relativamente popolose. Non si escludono rari casi di poliginia, ma da verificare. Indole della specie: Formica tranquilla, perfetta per chi non voglia problemi perché poco propensa a fughe rocambolesche. Poco aggressiva. Adattata a cacciare fra le foglie morte e l’erba alta. Nidi naturali: Scavati nel suolo, sotto le pietre. Anche in tronchi marcescenti sul terreno. Nidi artificiali consigliati: gesso, gasbeton, terriccio comune per i terrari e l’arena
. Nido mediamente umido. Temperatura ottimale: 18/25 °C Umidità ottimale: 50-60% Alimentazione naturale: Moderatamente onnivora, insetti, melata, piccoli semi.
Alimentazione artificiale: Non essendo in grado di fare trofallassi, queste formiche trasportano le sostanze alimentari come il miele sporcando detriti o legnetti e poi trasportandoli al nido. È quindi utile mettere a loro disposizione materiale naturale o sostanze assorbenti come supporto. Mentre avanzi da cucina (ossicini di pollo, uovo sodo, briciole di biscotti…) possono essere sminuzzati e trasportati normalmente. Particolarmente ghiotta di drosophile, mosche, farfalline, ragni morti. Le colonie numerose ampliano la gamma alimentare. Periodo d’ibernazione: Non indispensabile, queste formiche in condizioni favorevoli non ibernano o al massimo rallentano l’attività. Altrimenti: Temperatura di ibernazione: 10-15°C Sviluppo: La fondazione è claustrale (senza alimentazione). da uovo a operaia circa 30 giorni a 22/26 gradi da uovo a larva: circa 5 giorni da larva a pupa: circa 14 giorni da pupa ad operaia: circa 12 giorni.
Periodo attivo: tutto l’anno Difficoltà: inizio della fondazione non rapido; dopo che la colonia supera la fase iniziale la crescita accelera. Ultimo aggiornamento (Giovedì 29 Ottobre 2015 08:43)
La costruzione di un formicaio di legno esteticamente più bella, e più al sicuro dalle fughe, è quella realizzata scavando in un pannello di legno massiccio. Ancor più dei modelli in gasbeton e gesso, il legno si adatta a strutture verticali che, più sottili e leggere, richiedono però una base stabile per essere mantenute in equilibrio. Questo piedistallo può essere realizzato con lo stesso tipo di legno della struttura, o in qualsiasi altro materiale che si possa incollare, agganciare, o saldare al legno.
Sperimentare le tecniche, deciderne il disegno, e scontrarsi così con i primi rudimenti dello scavo di questi modelli è possibile già con materiali facili quali i fogli di sughero. Questo legno, così morbido, è lavorabile anche con attrezzi alla portata di tutti, come un Dremel armato di punte adatte. I nidi nel sughero sono adattissimi a specie arboricole come Camponotus lateralis, Colobopsis truncatus o formiche del Gruppo Temnothorax, che sono piccole e relativamente in grado di perforarne il supporto. E’ consigliabile anche se non indispensabile, procurarsi un foglio di sughero il più spesso possibile; fogli troppo sottili, o i fogli sottili incollati (anche a pressione) fra di loro, possono riservare problemi, in quanto certe formiche sono abili a sfruttare i punti deboli delle tavole, e in alcuni casi potrebbero approfittare di gradini o scollamenti per attaccarsi con le tenaglie e cominciare a minare lì la struttura.
Ma i grandi nidi per formiche carpentiere, scavati in legni più duri, richiederanno l’opera di un artigiano o di attrezzature non sempre alla portata di un normale utente. Il lavoro necessario a scavare grandi nidi per colonie popolose o formiche aggressive come Camponotus vagus, necessitano ore di lavoro, oppure l’intervento di frese professionali, o meglio ancora, l’uso di una fresa automatica guidata da un CAD.
La progettazione e la messa in opera di geometrie complesse in legno massiccio su vaste superfici richiede infatti un macchinario apposito o l’intervento di un professionista.
Qui è evidente la differenza di qualità fra le due diverse tecniche. Ma la parte più significativa investe il tempo necessario per lo scavo manuale.
Nido scavato a mano con Dremel e trapano da legno:
Nido scavato con mezzi di precisione, come una fresa guidata da un CAD:

Soprattutto nei modelli verticali a doppia facciata,, ma anche in quelli a facciata singola, invito tutti a non scavare mai stanze più alte di 1-1,5 cm. Le arboricole e le carpentiere in generale, non sono formiche che abbiano l’abitudine di accumulare riserve di cibo, e anche se la covata in alcuni casi può essere appesa a pareti di legno (le larve di Camponotus sono dotate di una fitta peluria uncinata che permette questa operazione), per le formiche è meglio poter disporre larve e bozzoli su ripiani orizzontali. Quindi è meglio favorire la presenza di superfici pianeggianti, o anche inclinate, ma con soffitti non troppo alti che le costringerebbero ad accumulare ammassi di bozzoli e larve accatastati l’uno sopra l’altro, più difficili da gestire. In questi casi si noterebbe il fenomeno di formiche isolate che sembrano schiacciate fra i bozzoli come si fossero addormentate lì, e fossero state ricoperte di bozzoli e larve dalle compagne.
Per evitare la struttura a stanze strette coi soffitti alti, è bene prevedere il disegno della pianta del formicaio verticale disegnandolo e ridisegnandolo bene prima, studiando come disporre numerose stanze basse a più piani, come in un palazzo, oppure prevedere stanze più alte ma intervallate da diaframmi sottili e adatti all’appoggio della covata inerte. Non è necessario che le stanze siano molto profonde, lo spessore del legno determinerà il loro possibile sviluppo, ma se vogliamo che le formiche restino ben visibili, è meglio non andare oltre i 2 cm di profondità. In caso di formicai in legno orizzontali, tutti questi accorgimenti sono superflui: la disposizione delle sale può anche essere ampia (in questo caso meglio che le stanze non siano troppo profonde!) con poche intersezioni separatorie, e anche le gallerie di accesso possono svilupparsi senza particolari geometrie.
Una possibilità che rende il nido più vivibile e più simile a un tronco d’albero forato in natura è quella d'incidere le stanze e le gallerie in modo che buchino tutta la superficie del legno, affacciandosi sul lato opposto della tavola. Questo vale per i formicai a modello verticale e, in questo caso il nido diventa a doppia facciata. Le stanze che lo attraversano tutto avranno così una doppia visibilità, e le abitanti potranno sfruttare tutto lo spessore del pannello. Consiglio di utilizzare tavole spesse al massimo 4-5 cm; uno spessore maggiore, fornisce alle formiche uno spazio eccessivamente favorevole all’occultamento: vedrete meno facilmente le condizioni della regina, e l’eventuale scavo di gallerie all’interno di un nido troppo spesso non sarà avvertibile, fornendo loro sempre più spazi per nascondersi. Io consiglierei di schermare almeno una delle facciate. Le formiche abituate alla luce sin dalla fondazione non sono normalmente infastidite dalla luce, e tutti noi alleviamo da anni formiche alla luce del giorno, ma offrire loro (e soprattutto alla regina) la sensazione di occultarsi alla vista altrui, in certi casi aiuta a mantenere più “tranquilla” la colonia. Nelle mie osservazioni dal vivo, ho notato che un formicaio interamente schermato fa sì che le formiche si distribuiscano sull’intera superficie abitabile, mentre una facciata scoperta può influenzarne la frequentazione che è determinata in gran parte dalla temperatura, e le formiche sposteranno la covata soprattutto verso una fonte calore, cosa che alla lunga può creare dei problemi, come vedremo in seguito. E’ quindi meglio gestire un ampio nido a doppia o singola facciata, lasciandolo coperto, scoprendolo solo quando si fanno delle osservazioni. La colonia abituata a visite frequenti non risente dell’esposizione alla luce occasionale, se si ha l’accortezza di mantenerla scoperta di tanto in tanto.
Geometria degli interni. Ognuno ha una propria idea di come le formiche scavano un nido. Di solito, le formiche ne hanno una diversa. Le carpentiere maggiori, che sfruttano i punti più deboli degli alberi in cui vivono, scavano gallerie nelle venature morte del legno, seguendo le sezioni degli anelli annuali di crescita. Si sviluppano così fondamentalmente strutture verticali concentriche, con collegamenti profondi metri. Ma nei tronchi caduti, gli stessi abissi verticali diventano pavimentazioni altrettanto vaste. Per le formiche adulte verticale o pianeggiante conta poco, ma i materiali di costruzione, i bozzoli inerti, la covata, sono trasportati qua e là e benché possano essere appesi, hanno bisogno di spazi ampi e di circolazione d’aria e calore. Nel caso di Lasius fuliginosus, bisognerà tenere conto che questa specie costruisce spontaneamente padiglioni in legno/cartone masticato, disposto in grattacieli interni ai tronchi d’albero, e in simbiosi con un micelio fungino; come sviluppare un nido di legno per ospitare queste formiche e dar loro la possibilità di riprodurre una simile struttura? Per un allevatore appassionato poter osservare un simile comportamento sarebbe paragonabile al veder crescere il fungo delle tagliafoglie brasiliane! Allora, come scavare il nostro formicaio? Per le mie esperienze, grandi colonie di carpentiere necessitano di abitazioni complesse e ricche di connessioni. Colonie piccole, con formiche medio-piccole, possono essere ospitate in sezioni di legno relativamente minuscole; una colonia di Colobopsis o di Temnothorax può stare in una tavoletta 10 x 10 ed essere disegnata seguendo una pianta di lunghe gallerie con stanze distanziate e di numero limitato. Per ovviare invece al bisogno di spazio che richiede una grande colonia, e la necessità di racchiudere tutto in un modello trasportabile agevolmente, io scelgo strutture geometricamente complesse, ricche di stanze separate da diaframmi il più possibile sottili, soprattutto nel nucleo centrale. La possibilità di bucare stanze su entrambe le facciate di una tavola spessa fa guadagnare ampie superfici, soprattutto associata a saloni che si affaccino su entrambi i lati, meglio se non sono simmetrici. La necessità di guadagnare spazio non deve cancellare lo svolgersi del naturale andamento delle gallerie, che deve essere meno possibile regolare, altrimenti si può tranquillamente restare al modello incassato fra cornici con i bastoncini da ghiacciolo come ripiani. Quindi bisogna alternare la costruzione di stanze su piani sovrapposti a una serie di passaggi o corridoi il più possibile irregolari. Grande spazio deve sempre essere dedicato alla cornice esterna che serve a contenere eventuali fughe. Le formiche bucheranno dove potranno, e tenteranno comunque di trovare un punto debole nella loro prigione. Meglio rendergli le cose più difficili possibile! Un minimo di 3-4 cm di legno massiccio sono da prendere in considerazione nella parte bassa della struttura, uno dei punti in cui le formiche sono più propense a scavare. Considerate che una colonia appena installata tende sempre a trincerarsi e a tappare tutti gli spifferi o fessure che tolgono loro sicurezza, ma col tempo andranno a sfruttare le stesse falle nella struttura per allargare i loro spazi!
Problemi con fonti dirette di calore. I nidi di legno sono sensibili all’umidità, sia interna che esterna. Di principio, non è bene far entrare in contatto l’acqua con il materiale della costruzione, quindi le formiche devo poter avere accesso a fonti di umidità indipendenti, come provette, abbeveratoi in arena o altri accorgimenti che compensino la mancanza di umidità della loro casa. In questo senso il sughero è più adatto come gestione, non soffre di queste limitazioni, perché non si deforma come gli altri legni. Il legno resta un materiale vivo: si gonfia con l’umidità, si piega, si “imbarca”, marcisce, asciugando può restringersi. Applicare una lastra di vetro a una tavola di legno può sembrare una operazione facile e priva di rischi per il nostro nido, ma come la fisseremo? Colle? Silicone? Tasselli o morsetti? Se il vetro è rigidamente fissato, la deformazione del legno potrebbe arrivare a scollarlo, scalzarlo, anche a romperlo (nel caso di un fissaggio rigido con angolari metallici). Un vetro rotto o incrinato mina la sicurezza del nido. Bisogna che il vetro sia fissato al legno in maniera dinamica perché un fissaggio che a prima prova sembra sicuro ed ermetico, nel giro di poche settimane potrebbe mostrare limiti inaspettati. Per quanto possa sembrare incredibile, i problemi più grandi possono venire dal riscaldamento del nido, perché sono proprio gli sbalzi di umidità associati a quelli di temperatura che fanno variare maggiormente entrambe le superfici. Un legno che si imbarca, anche se il vetro è ben saldato e regge alla prova sui bordi, crea fessure verso l’esterno (se si gonfia al centro si scoprono spazi sul perimetro) o al centro; le formiche sentono subito che ci sono spiragli, e corrono immediatamente a tapparli, infilando negli spazi ogni sorta di materiale, dai detriti, ai resti di insetti, alla segatura. Questa operazione innesta un meccanismo perverso, che le operaie perseguiranno a oltranza: la fessura si allarga, e altro materiale vi verrà infilato. Il risultato sarà di creare un allargamento dello spazio fra il legno e il vetro. E la catastrofe è annunciata. Un nido che asciuga dopo essere stato “inquinato” da un eccesso di umidità, in pochi giorni può variare le sue dimensioni in termini di millimetri, che, parlando di formiche, sono decisivi. La scelta di usare lastre di plexiglas, cosa che evita il rischio di rotture, a tutta prima sembrerebbe una soluzione ideale, ma il plexi è ancora più soggetto a deformarsi, così non sarà il legno a spingere in fuori il vetro, ma il plexiglass ad allontanarsi dalla superficie di legno. L’unica risoluzione, ma è il vantaggio che il plexiglas offre, è che può agevolmente essere bucato e fissato in tutti i punti a rischio. Prevedete quindi in fase di progetto di scavo delle superfici a contatto più larghe in cui sia possibile bucare e applicare un ancoraggio. Pensate molto in anticipo tutti i punti in cui potrebbe deformarsi e allontanarsi dal legno, e fissatelo con viti anche piccole, ma che garantiscano l’aderenza delle due superfici. Le viti non devono essere messe solamente a presidiare il perimetro sterno, ma anche a mantenere la lastra aderente all'interno del nido (e una sola nel mezzo può non bastare!).
In realtà è impossibile che il legno non subisca gli effetti dell’umidità. A lungo andare, la popolazione stessa rilascia una grande quantità di liquidi che vanno a sporcare, far ammuffire, e danneggiare la loro casa. Le superfici più frequentate, anche solo per il rilascio delle feci, il deposito delle prede, il trasudare estivo della popolazione, la massa viva agglomerata in luoghi angusti d’inverno, rendono pavimenti e gallerie inizialmente lisce e linde, in pochi mesi nere e porose. Una colonia di più di 1000 operaie di Camponotus necessita di almeno una provetta d’acqua da 20 cm ogni 3-4 giorni in piena estate, e quest’acqua da qualche parte va a finire! Ultimo aggiornamento (Venerdì 12 Gennaio 2018 19:02)
Cataglyphis italica

Nome: Cataglyphis italica (Emery, 1906)
Tassonomia: Sottofamiglia: Formicinae - Tribù: Formicini - Genere: Cataglyphis - Specie: Cataglyphis italica
Areale di distribuzione: Specie endemica, probabile relitto dell'ultima glaciazione, distribuita in sud Italia (Puglia e Basilicata), zone assolate ed aride.
Organizzazione sociale: poliginica
Stile di fondazione: Sconosciuto. Si suppone una sorta di gemmazione, o che le regine si allontanino dal nido originale per intrufolarsi in nidi vicini per accoppiarsi.
Comportamento: specie diurna. Dotate di un'ottima vista, queste formiche sono cacciatrici velocissime e solitarie. Sfuttano la loro rapidità per trovare le prede prima delle altre specie e portarle velocemente nel nido. Solo nei suoi pressi, operaie incontrate per lo più casualmente, possono cooperare nel trasporto della preda dentro il nido.
Si orientano grazie alla luce del sole e raramente escono a foraggiare senza di esso. Al tramonto sigillano l'ingresso del nido chiudendosi al suo interno e quasi mai vi fuoriescono nei giorni umidi nuvolosi e senza sole.
Regina: 6-9 mm completamente scura, talvolta con capo rossiccio e torace bruno.
Maschio: 6,5 mm nero-bruno, talvolta con zampe, gastro e genitali rossicci.
Operaie: marrone scuro, talvolta picee, 5-7 mm, dimensioni variabili date dall'alimentazione, non caste distinte; colonie poco popolose.
Alimentazione naturale: carcasse di piccoli insetti, sementi, nettare, sostanze zuccherine.
Alimentazione artificiale: soluzione di zucchero di canna, dieta Bhatkar ( meglio se "allungata" con soluzione di zucchero di canna per renderla più appetibile), camole della farina, zanzare, piccoli insetti non corazzati, semi oleosi e frutta dolce,(forse) pezzetti di carne, frutta.
In assenza di larve necessitano quasi esclusivamente zuccheri che proteine, ma in presenza di larve la loro alimentazione cambia drasticamente e le proteine diventano indispensabili.
Umidità richiesta: è sufficiente una semplice provetta o un beverino per uccelli con un tappo di ovatta nell'area di foraggiamento, è importante invece mantenere una zona del nido costantemente umida
Temperatura: temperatura ambiente nel nido, temperature anche molto maggiori in alcune zone del nido e dell'arena (meglio se esposte alla luce diretta del sole). Queste zone verranno utilizzate come "solarium" per le pupe nei periodi più caldi e di maggior attività della colonia.
Ibernazione: Non necessita una vera e propria ibernazione. Durante L'inverno la colonia sigilla l'entrata del nido rifugiandosi nella zona più profonda ma è sempre presente un minimo di attività. Le formiche non conservano scorte di cibo per l'inverno, ma le operaie immagazzinano sostanze nutritive nei loro gastri riuscendo a sostenere la colonia per lungo tempo
Nidi naturali: spesso dotati di una entrata singola, sempre con gallerie scavate nel suolo in profondità. Nello strato superficiale, una galleria verticale intervallata da piccole stanze ogni 10-15 cm, presidiate da operaie.
E' possibile trovare regine anche negli strati superficiali
Nidi artificiali consigliati: il gasbeton si adatta alla perfezione; scavano con facilità altri materiali più morbidi sopratutto se umidi (mia supposizione in base all'esperienza con il tufo); è consigliabile un nido ampio con una zona più fresca ed umida ed una zona molto secca e calda ed una grande arena, lunghezza ideale 80 cm per scoraggiare tentativi di fuga frequenti con piccole arene ma assenti con arene grandi
Difficoltà: Difficili. Richiedono altissime temperature d'estate ed ampie arene, possibilmente esposte alla luce diretta del sole. Il loro comportamento è molto diverso in ambienti chiusi e con luci artificiali
Indole: Poco aggressive, evitano i confronti diretti con altre specie grazie alla loro velocità, ma non esitano a difendersi usando le loro mandibole se minacciate.
Periodo di sciamatura: probabile piena estate
Curiosità: sembrano possedere discrete difese chimiche contro le altre specie di formiche. Le operaie di C.italica, nel loro frenetico entrare ed uscire dal nido, lasciano spesso l'ingresso incustodito, ma le operaie di altre specie che arrivano al suo ingresso fuggono istantaneamente anche senza aver trovato nessun antagonista.
Si orientano grazie alla luce del sole: si muovono a scatti in maniera "random" facendo il punto della situazione osservando il sole alla fine di ogni scatto, finchè non incontrano una preda. Da quel momento, la loro elevata capacità di calcolo consente di elaborare la traiettoria più breve (quindi in linea retta), verso l'entrara del nido. Per seguire il diario di allevamento, le esperienze, gli errori, le scoperte di questa specie endemica:http://formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=3534
per approfondimenti:
http://www.youtube.com/watch?v=w9KDM4C1kVg

Ultimo aggiornamento (Domenica 16 Novembre 2014 20:54)
L’arena è l’ambiente esterno del nostro formicaio. Come per la costruzione del nido, il gusto personale e la scelta di diversi materiali fanno la differenza; più che per il nido, l’arena richiede la gestione oculata degli spazi, perché deve simulare il territorio dove le nostre formiche andranno a caccia e incontreranno eventuali prede.
Dico da subito che anche qui non c’è una regola precisa per realizzare l’arena. Ognuno si adatti allo stile che preferisce. Sono però utili delle precisazioni e dei consigli tecnici minimi, per cui cercherò di fare un quadro generale dei tipi di arena di cui abbiamo esperienza e le indicazioni su come realizzarle al meglio.
Un esempio è nel prevedere sempre in anticipo una eventuale seconda uscita nell'arena. Potrebbe essere utile per ampliare lo spazio vivibile, fare esperimenti, collegare un secondo nido. Operare nuovi fori a formicaio già collegato comporta notevole stress per le formiche, quindi, pensateci bene prima!
L’ACCESSO ALL'ARENA.
Dal nido propriamente detto all’ambiente esterno si possono avere diversi tipi di collegamento:
Accesso diretto: come nel caso dei nidi di gesso di tipo 2, che incorporano nido e arena nello stesso elemento
Accesso collegato tramite tubo diretto: dal blocco del nido, con arena a contatto, un tubo attraversa il materiale e sbuca lateralmente, o dal basso, affacciandosi direttamente nell’ambiente esterno
Accesso con tubo lungo che sviluppa un percorso: dal nido esce un tubo preferibilmente flessibile, che fa percorrere alle formiche un tratto di strada regolabile, permettendo alle operaie di camminare più a lungo.
Il tubo lungo può sviluppare un percorso, può avvolgersi a spirale per occupare meno spazio e consentire ugualmente un percorso lungo, può essere modulare, con raccordi che permettono di allungarlo o accorciarlo alla bisogna. E’ sempre meglio evitare di far fare a questi tubi tratti nettamente verticali; alcune formiche trasportano semi, i tubi possono essere inizialmente troppo lisci e troppo ripidi per loro, e rendono il ritorno al nido a volte impraticabile.

I tubi devo essere abbastanza grandi da far passare piccole prede, ma è sempre meglio che non superino troppo le dimensioni ideali della specie che dovrà sfruttarli: accessi troppo grandi rendono il nido indifendibile e le formiche tendono spesso a barricarsi; se il diametro del tubo è troppo grande, le barricate sono difficilmente realizzabili! Molte formiche hanno l’istinto di rinchiudersi in fase di invernamento, e gradiscono poterlo fare senza troppa fatica.
Usare tubi trasparenti, meglio se privi di odori e abbastanza sottili da poter essere piegati senza creare strozzature. Esistono in commercio (ferramenta, negozi casalinghi, bruco center) tubi appositi definiti “per alimenti” che non contengono sostanze tossiche nocive alle formiche. Chiedete espressamente quelli.

SICUREZZA ANTI-EVASIONE
Come è già stato spiegato nell'articolo sull'antifuga, diversi sistemi e prodotti possono essere applicati per contenere le nostre formiche. E' bene qui riassumerle per coloro che leggano per la prima volta questa scheda: L’arena è uno dei punti critici e più temuti dai profani per il contenimento delle formiche.
Ci sono anche qui diverse correnti di pensiero.
Coperchio sigillato: è certo che niente uscirà!
Controindicazioni: le formiche possono stazionare sotto il coperchio (che è meglio sia sempre trasparente!) e quando vorrete aprirlo avrete il problema che correranno ovunque.
Il coperchio chiuso, anche se praticate dei forellini, non lascerà mai circolare abbastanza l’aria nell’arena: il rischio di muffe, marciume, malattie e cattivi odori è elevato; l’umidità ristagna, i veleni eventuali delle formiche rendono l’arena a lungo andare una trappola.
Coperchio con retina: esistono in commercio retine metalliche finissime. Non sono sempre e ovunque reperibili, non sempre sono abbastanza traspiranti, e in ogni caso le formiche vi si possono arrampicare e stazionare in attesa che voi apriate.
Arene aperte: da tempo l’arena aperta è una realtà accettata e funzionale.
Utilizzando diversi sistemi repellenti possiamo permetterci di tenere aperto lo spazio esterno senza che le formiche possano uscire. I vantaggi sono un facile accesso all’ambiente dove vogliamo osservare e lavorare, e nessun problema di muffe e marciumi, che in ogni caso possono essere facilmente rimossi. Anche fornire nuovo cibo alle formiche non presenta problemi.
I sistemi repellenti sono già citati nell’apposita scheda ma vale la pena di ripetere quali siano i migliori.
Alcool e borotalco (il famoso talcool). Una mistura di talco e alcool viene spalmata sulla superficie alta dell’arena e l’alcool, evaporando, rende il talco abbastanza difficile da scalare e moderatamente repellente per molte formiche. Inconvenienti: a lungo andare lo strato si deteriora e va spalmato spesso, in rapporto alla qualità, alle superfici e al tipo di formica che tenterà di superarlo.
Repellenti chimici in vendita: non sempre reperibili e relativamente costosi, ma di sicuro funzionamento.
Repellente fatto in casa: il più classico e sperimentato con successo è il classico impasto “pasta di vaselina bianca e olio lubrificante”, quello per svitare, per oliare gli ingranaggi, quello minerale insomma! E’ stato scritto centinaia di volte in ogni articolo, diario, scheda, e ancora qualcuno ha il lampo di genio di usare olio d’oliva! Aggiungere anche un po’ d’aglio e peperoncino può dare risultati inaspettati: le formiche ringrazieranno!!! Non dimenticate di mescolarlo con della pasta ben al dente!
Questa mistura (50%+50%) applicata alle superfici ha una lunga durata, è efficace e decisamente economica. Applicata su una superficie di 2-3 cm almeno, non cola e trattiene le formiche all’interno.
Ma tutti questi repellenti richiedono una caratteristica di sicurezza ulteriore, per essere veramente sicuri: vanno applicati su superfici “a tetto”, cioè su un risvolto del coperchio, sul bordo della “finestra” superiore dell’arena. Spalmarlo sulle pareti verticali potrebbe non bastare e in condizioni di stress, o con formiche molto agili (quindi piccole e leggere) si possono riscontrare fughe che con un capace bordo a tetto si evitano. Più la superficie spalmata è ampia, migliore la sicurezza.
In ogni caso, rinnovare ogni mese la mistura non è male: spesso alcune formiche riescono a ricoprire la vaselina con detriti e a passarci su. Se l’olio è ben distribuito non lo fanno. E’ l’olio, non la vaselina, il repellente!
ARENA BASE per provette o nidi di accrescimento
Per colonie piccole, incipienti, per iniziare ad aprire la provetta in uno spazio vivibile e poter gestire l’alimentazione delle formiche altrimenti impossibile in una provetta affollata, non occorrono grandi spazi.
Una scatola di plastica da gelato, meglio ancora le classiche Ferrero Rocher, o qualsiasi contenitore (sempre meglio trasparenti) alimentare in vetro, o plastica, si adatta all’uso. Avere un coperchio che si possa forare e aprire a finestra, come abbiamo visto, è utile. Ogni altra possibilità, come costruirsi scatole in plexiglas, utilizzare piccoli acquari, o altre idee, sono possibili, ma fin troppo laboriose per il primo utilizzo.
Con formiche piccole come Plagiolepis, o Temnothorax, non occorrono grandi spazi. Meglio concentrarsi sul fatto che i collegamenti eventuali siano ben sigillati, che l’antifuga copra una buona fetta di parete, e trascurare substrati o terreni complessi dove le formiche potrebbero facilmente occultarsi. Lasciare il pavimento sgombro, o coprirlo con una sottile colata di gesso, magari colorata, che renda meno “freddo” l’ambiente.
Ricordate che salvo nel caso delle specie suddette, in alcuni mesi le vostre colonie cresceranno e magari dovrete cambiare nido ed arena, quindi l’arena-base va considerata un passaggio, come i nidi di accrescimento, quindi è controproducente spenderci troppe energie, perché presto non basteranno più allo scopo.
Chi voglia partire da subito con un arena molto grande non fa un gravissimo errore, solo punta troppo in alto! Il problema è che le formiche ci scompariranno, le giovani operaie non vanno troppo lontano e all’inizio per osservarle è superfluo, inoltre, molti allevatori gestiscono più colonie, e soprattutto in fase iniziale, avere grandi arene per piccole colonie è ideale per chi possieda ville californiane, e più stanze proprie in cui giocare a calcio o fare jogging, ma chi deve dividere la camera con fratelli, sorelle o fidanzate, capisce di cosa sto parlando.
NIDO CONTENUTO IN ARENA: Con formiche molto piccole e dalle limitate esigenze di spazio, si può considerare di inserire il nido direttamente in arena. E' il caso dell'esempio sotto, in cui Temnothorax può benissimo essere alloggiata in canne di bambù applicate al vetro dell'arena stessa in cui tutto sarà facilmente maneggiabile. Il substrato di ghiaia non crea problemi perché è basso, molto pesante per queste formiche, le quali comunque scelgono sempre di installarsi in dalle, bacche o rametti.
Dovendo inserire nidi più pesanti e complessi (come in gesso o gasbeton) bisogna considerare diversamente la tenuta del nido sul pavimento o sulla parete perimetrale, perché deve essere ben fissata, e potrebbe creare problemi in fase successiva, quando si volesse cambiare nido, cambiare arena o trasferire la colonia per altri motivi.

ARENA CON FONDO FISSO
Che sia una scatoletta di gelato, che sia un acquarium 2 m x 5, il “substrato”, la base su cui le vostre formiche correranno, è importante non solo per il loro piacere o per la vivibilità, ma anche per la visibilità delle stesse e per la gestione nel tempo dell’arena.
Anche qui possiamo sbizzarrirci: si possono semplicemente lasciare le formiche su un fondo anonimo, oppure plasmarlo colando del gesso che, solidificandosi, renderà la superficie esterna (finta), il pavimento su cui le formiche usciranno in cerca di cibo, e dove porteranno i rifiuti.
La colata di gesso è una delle scelte più comode: permette di avere una superficie rugosa o liscia, colorabile con tinte naturali. Può essere arricchita con sassolini, piante, rametti o altri elementi, che, se inseriti in fase di gesso fresco, asciugandosi verranno intrappolate e resteranno stabili nel tempo, rendendo l’ambiente relativamente “naturale”. Le possibilità sono molteplici e gli appassionati del bricolage hanno da insegnarci tutto sulla reperibilità di materiali più o meno adatti, su come scegliere elementi veri o fantastici (c’è chi ama il modellismo e tenterà di riprodurre ambienti naturali, ma anche antropici, come case, ferrovie e castelli!
Ognuno è libero di scegliere con la propria fantasia... tanto le formiche non vi capiranno!
Ricordate solo che poi questi ambienti vanno ripuliti, almeno di tanto in tanto, ma soprattutto se allevate formiche come Messor, verranno ridotti a vere e proprie discariche di rifiuti! Pensateci bene prima di lavorare troppo con la fantasia.
Alcune sostanze verranno rosicchiate, altre verranno sepolte dai rifiuti, altre ancora ignorate… Ricordate sempre che l’arena deve poter essere ripulita o sostituita! Dopo sei mesi potrebbe non piacervi più, potreste avere idee migliori, materiali più belli, formiche più numerose. L’arena non può essere eterna!

ARENA CON FONDO MOBILE
Le arene possono anche essere ambientate con materiali del tutto naturali, come terra, sabbia, argilla, sassi, ghiaia, o un misto di tutti questi elementi.
Anche questi materiali vanno ponderati con attenzione. Il primo problema è che le formiche tendono a utilizzarli: in pochi giorni potreste trovarvi le stanze interne di osservazione con i vetri ricoperti di humus, di sabbia incollata alle finestre, con ogni sorta di detrito che le formiche porteranno dentro cercando di tappare buchi, limitare spazi che a loro sembrano superflui, mentre voi li avevate scavati con cura e amore; oppure, semplicemente, si trasferiranno all’esterno SOTTO il vostro bellissimo substrato naturale!
Questo comporta che nel momento in cui decidete di ambientare l’arena con uno strato che le formiche possono elaborare, questo materiale deve essere meno spesso possibile, e se è anche pesante è meglio, così non lo appiccicheranno ai vetri, magari usandolo come ponte sull’antifuga per evadere!
Le formiche amano scavare, rivoltare il terreno, barricarsi. Porteranno tutto il possibile presso l’entrata principale, e se il vostro tubo di entrata è troppo piccolo lo ostruiranno.
Se è troppo grande riempiranno le stanze sottostanti cercando impilare all'entrata materiale che non è possibile resti coeso. Mettete sassi e sassolini presso l’entrata, cercheranno di spostare tutto da un’altra parte, liberando l’entrata perché loro vogliono più spazio… insomma, non ragionano mai come vorremmo noi.
I vantaggi di un fondo mobile e scavabile sono che le formiche potranno lavorare, potranno crearsi dei nascondigli senza nascondersi troppo, avranno sostanze a cui attingere per tappare spifferi e gallerie stimate inutili o pericolose. Un altro vantaggio è che rivolteranno continuamente il materiale, miscelando detriti con scarti dei pasti, morti della colonia e parti immangiabili delle loro prede.
Quando verrà il momento di fare pulizia basterà tappare l’entrata al formicaio e rimuovere pazientemente tutto il materiale depositato, che potrà essere buttato e sostituito con altro substrato pulito, oppure, se è materiale pregiato, potrà essere lavato e riutilizzato. A pulizie ultimate, potremo riaprire l’accesso del nido.
Con questo sistema è necessario recuperare le formiche rimaste all’aperto per poi reinserirle, oppure, se la colonia deve essere sfoltita, è l’occasione buona per eliminare queste operaie che nel 75% dei casi sono operaie anziane.
Usare un fondo mobile non è sempre la scelta migliore, ma con formiche molto grandi come Messor e Camponotus, si presta abbastanza bene e consente di tenere le formiche attive anche all’esterno del nido.

ARENA AMBIENTATA
Questa è il tipo di arena che tutti sognano: terreno vero o falso che sia, piante vere o finte, un bel terrario con rami e sassi è la ricostruzione fedele dell’ambiente in cui immaginiamo le nostre formiche possano essere felici. Io sconsiglio sempre di usare piante vere: le piante sono organismi viventi che necessitano di substrato vero, e questo non farà altro che attirare l’interesse delle formiche che lo scaveranno facendo morire le piante. I bravi modellisti sono in grado di ricostruire perfettamente una fetta di prato, di deserto, o di boscaglia, mescolando elementi reali con ricostruzioni del terreno in gesso, gasbeton o altro materiale artificiale. Incollare e montare i pezzi in un diorama che imiti la realtà è appannaggio dei costruttori più abili e fantasiosi. Lo spazio previsto va ben gestito, con punti appositi dove poter mettere le esche per dar da mangiare alle formiche, che potranno essere osservate quasi come in natura.
Questo tipo di arena, che esteticamente è la più bella, richiede spesso molto spazio, e non deve essere eccessivamente ricca. Anche qui, più elementi ci sono, più difficile sarà pulire, osservare le formiche, e recuperarle se decideranno di trasferirsi sotto qualche sasso o ramo, cosa che a loro piace tanto.
Sconsiglio quindi l’inserimento di muschio, strati di humus, pacciamatura, sia veri che artificiali, a meno che siano impenetrabili alle formiche. Un muschio artificiale si può incollare al fondo, ma non deve avere uno spessore eccessivo; formiche molto piccole vi si infiltreranno prima o poi, scomparendo alla vista.
Ricordo ancora una volta il motivo per cui cerchiamo di allevare le formiche, che va oltre il puro piacere di avere delle formiche in casa: noi le vogliamo vedere! Per questo l’uso di terrari naturalistici è da scartare per chi voglia davvero osservare, studiare, accudire una colonia di insetti: se si occultano completamente alla vista non potremo nemmeno sapere di che salute gode la colonia! Sono stati studiati e realizzati diversi sistemi per diminuire gli strati di terreno in cui le formiche possono occultarsi, come inserire spessori, blocchi che limitano lo spazio scavabile, ma la capacità delle formiche di nascondersi e andare a cercarsi un riparo che non sia quello da noi previsto è sempre da mettere in conto.
Quindi ponderate bene l'uso dei formicai nido-arena-tutto-compreso, anche se sono sicuramente belli (un esempio ben riuscito qui sotto), piccole giungle in miniatura, soprammobili pittoreschi, ma con possibili limiti oggettivi di gestione delle formiche sul lungo tempo.
Le soluzioni migliori se si vuole procedere in questo campo, sono le arene con ambientazione semi-desertica, con pavimenti moderatamente corrugati (le fessure si riempiono di detriti in breve), sassi, rami ben stagionati, ravvivando con piante artificiali che imitino il più possibile la realtà, ma badando di non eccedere con gli elementi. Per ottenere una base solida ma naturale, si possono mescolare sabbia e cemento, gesso con argilla, semplice gesso colorato…

Per quel che riguarda le tecniche e i materiali lasciamo ai modellisti il piacere di trovare i materiali più adatti: ognuno ha le proprie preferenze e sarà più competente di me nel dare consigli. A questo proposito invitiamo chi voglia completare questa scheda a fornirci indicazioni dettagliate che inseriremo per completarla in un secondo tempo.
Ultimo aggiornamento (Domenica 14 Gennaio 2018 12:12)
Nido di legno a listelliPer ospitare formiche del genere Camponotus, soprattutto parlando di vagus, herculeanus e ligniperda, ma anche Colobopsis truncatus, Crematogaster o Temnothorax, è consigliabile adottare un nido artificiale in legno, che ricalca e favorisce l’iter abitativo di queste specie.
Sul sito sono presenti diversi modelli che sfruttano ogni possibile sfrenata fantasia messa in atto dagli allevatori: per le formiche più piccole si usano con successo mezzi gusci di noce o sezioni di canne di bambù, o ramoscelli tagliati su misura. Nella scheda sul nido orizzontale di sughero si contempla lo scavo manuale delle stanze, ma chi possa procurarsi un Dremel con punte da legno specifiche, potrà realizzare una pianta geometrica più pulita e articolata di quanto si possa fare a mano.
Scavare tavolette di legno massiccio invece diventa un lavoro (e un'arte) che richiedono attrezzi adatti, capacità manuali e soprattutto una grande quantità di tempo. Nell'articolo di seguito troverete una scheda in cui diamo tutti i consigli possibili per costruire nidi scavati sulla pianta dei vari prototipi già realizzati dai nostri soci più ingegnosi e capaci, ma per chi non abbia tecnica e attrezzi adatti, una soluzione pratica per realizzare un grande nido per formiche aggressive come Camponotus vagus è il sistema a cornice, con stanze e corridoi distribuiti a listelli incollati.
Usando materiali facilmente reperibili e un po' di impegno, si può realizzare una costruzione solida, e al tempo stesso funzionale, con grandi capacità abitative, che può reggere l'assalto di mandibole potenti per un discreto periodo di tempo. Vi ricordo sempre che una colonia di formiche è volubile, sempre in cerca di vie d'uscita, ed è un organismo vivente! Non è facile contenere a lungo centinaia di formiche grandi, aggressive, e tutte determinate a evadere!

Resta valida la regola che il nido debba crescere insieme alla colonia, anche per motivi di usura nel tempo del materiale e la possibilità che i vetri siano sporchi e rendano mal visibili le formiche. Il nido di accrescimento può essere più semplice, con poche stanze, e può essere realizzato agevolmente in orizzontale, cosa che rende nei primi tempi anche una più facile visione della famiglia ospitata. Per le mie colonie di carpentiere nei primi anni di allevamento ho scelto di usare legno d’abete stagionato, in tavolette di varia misura, e per delimitare le stanze listelli di legno più morbido, acquistabili presso qualsiasi rivenditore di materiale fai da te. L'utilizzo di semplici leggenti da ghiacciolo fornisce altro materiale di facile reperibilità e di buon impiego. Chi ha letto la storia delle mie colonie sa che ho dovuto correre ai ripari proprio per tamponare l'evasione di una colonia di 3000 vagus, che nel terzo anno di vita cominciano a manifestare un insopprimibile bisogno di scavare il legno! Queste formiche hanno l'abitudine di bere e bagnare il legno per ammorbidirlo, scavandolo così più facilmente e rapidamente. Non ci sono soluzioni per impedirlo, se non ospitandole in nidi di materiale diverso, o inglobando il nido stesso in una teca. Chi però è nella necessità di dover spostare spesso la colonia, non può legare la stessa a un acquario di dimensioni ideali, quindi torniamo all'uso del legno e vediamo come possiamo risolvere il problema.
Ci sono sicuramente altri materiali per alloggiare le formiche carpentiere (gasbeton, gesso, ugualmente cedevoli alla lunga), ma il legno è quello che preferisco per estetica, e per la migliore visione interna (l'abete stagionato è un legno chiaro). Inoltre è gradito particolarmente da tutte le formiche carpentiere maggiori, e non particolarmente soggetto a marcire o a deformarsi.
Le colonie incipienti gradiscono gli spazi ristretti e protetti, quindi è possibile alloggiare la regina e le prime operaie in stanze di pochi centimetri, ma quando la famiglia raggiunge il centinaio di unità inizia a crescere a ritmi maggiori, quindi il nido successivo può essere costruito in previsione di una rapida crescita della colonia, in modo che possa servire egregiamente almeno per almeno uno-due anni. Piazzare barriere per dividere in sezioni un nido grande, in modo da renderlo gradualmente abitabile, è possibile, ma le formiche sono ottime esploratrici, e tendono a sfondare rapidamente tappi di segatura pressata, o sughero. Tenetene conto. Nei nidi a due facciate si può facilmente impedire l'accesso delle formiche alla seconda facciata, con tappi di cotone pressato. Le alternative sono un tubo esterno che colleghi le due facciate, oppure fori interni che in questo caso devono rimanere accessibili per la rimozione.
Per rendersi conto di come Camponotus vagus utilizza gli spazi vivibili, basta dare un'occhiata al modo di stipare la covata.

La scelta di costruire un nido in verticale, è una scelta soprattutto di spazio, ma queste formiche vivono abitualmente l'interno di alberi, e lo sviluppo verticale è ideale alle loro necessità. Scartando la possibilità di scavare spesse tavole di legno in modo da realizzare un nido armonico e naturale come fosse fatto da loro, la scelta più facile è di utilizzare una tavola come sfondo, e incollare su questa una cornice e tutti i ripiani atti a ricostruire stanze, corridoi e percorsi che rendano il nido spazioso e funzionale. Per fare questo ho scelto una tavola base di 1,5 cm, 25 x 45, alla quale ho applicato una cornice di 2 cm di spessore, sempre in abete bianco. Ho acquistato poi dei listelli di legno più morbido (va sezionato in molti pezzi, quindi deve essere facile tagliarlo, inoltre le formiche non avranno necessità di scavarli, quindi a che serve usare legno robusto?), di 2 mm di spessore e 2 cm di sezione, che vadano in pari con le cornici esterne.
Ho scelto il plexiglas come vetrina, perché le Camponotus non tendono a sporcarlo, cosa che fanno invece altre formiche come Messor, e la plasticità del plexiglas consente di modellarsi a eventuali "imbarcamenti” del legno, che altrimenti rischierebbe di rompere un materiale come il vetro. Il plexiglas consente anche un più facile taglio in sezioni, che saranno necessarie a foderare esternamente le altre superfici del nido. Infatti non c'è modo di impedire la foratura di quest'ultimo, ed è bene premunirsi per tempo, in modo che la colonia non trovi falle attraverso cui uscire. Al centro del nido ho posizionato due tavolette di spessore maggiore (2 cm x 4) che fungano da basi per fissare la vetrata, in modo da non avere punti deboli di adesione fra il vetro e lo spessore delle stanze.
Per incollare cornici e listelli, va bene il normale Vinavil, colla da legno molto resistente e a base d'acqua, che non arreca danno alla popolazione. Dopo aver posizionato le cornici e aver forato almeno due punti di accesso (calcolare bene i fori usando già i tubi che si vorranno adattare, in modo che non siano né troppo stretti, né troppo larghi), si comincia a deporre i listelli in modo da formare una serie di ripiani che si adattino alle dimensioni delle stanze in cui le formiche accudiranno la covata; l'architettura e il disegno della pianta sono soggettivi: ognuno potrà disporli come meglio crede. E' importante però ricordare che le formiche, benché molto grandi e numerose, amano sentirsi protette, quindi evitate stanze troppo piccole e quindi male utilizzabili, ma nemmeno troppo grandi, perché la continua esposizione alla luce le rende meno sicure di un nido oscurato. A questo scopo ho interrotto qua e là il susseguirsi di ripiani troppo larghi con listelli verticali, e inframmezzato le pareti troppo alte con ripiani più sottili (1 cm, per 1 mm di sezione), in modo che servano da mensole, o che interrompano la "sensazione di continuità” dei corridoi.
Non servono travi robuste per sostenere centinaia di formiche, l'equilibrio fra materiale usato e spazio interno va sempre tenuto presente.

A questo scopo sono adattissimi i normali legnetti da "ghiacciolo”, che tagliati facilmente, reggono benissimo il peso delle formiche, ma non appesantiscono la vivibilità della struttura. I punti deboli rimangono i punti di incastro della cornice esterna, e le vie d'accesso, dove è bene che le formiche non siano tentate di scavare, e che devono permettere la rimozione dei tubi almeno una volta l'anno, perché le vagus sono in grado di sgranocchiarli alle estremità, e quindi potrebbe rendersi necessario sostituirli. A questo scopo ho posizionato all'interno del nido, tagliate su misura, delle placche di plexiglas, in cui far passare i tubi, che faranno da scudo alle entrate. E' preferibile fissare queste sezioni con viti, legno incollato o colla a caldo: devono reggere l'estrazione e l'inserimento di eventuali nuovi tubi, senza essere da ostacolo. Forate bene le placche, il tubo deve passare senza sforzare troppo!
Le placche di plexiglas protettive, sono solo un palliativo: le formiche bucheranno comunque da qualche altra parte, quando lo vorranno.

Esternamente il nido verrà ricoperto su tutte le altre 4 facce con lastre di plexiglas tagliate su misura. Le lastre devono combaciare il più possibile; è difficile che le formiche scavino proprio negli angoli, più probabile che forino qua e là, ma non si sa mai. A lavoro ultimato, passare un filo di colla a caldo sui punti di connessione fra le lastre non sarebbe male. Chiudete e fissate in più punti possibile la vostra protezione antifuga: non ci devono essere punti in cui il plexiglas balli o non aderisca perfettamente; a colonia installata sarà difficile fare interventi ulteriori.
Spessori e spazi differenti possono servire a rendere la struttura del nido meno "meccanica” e fredda, certo non sarà mai esteticamente bello come un nido scavato da un artigiano nel legno vivo, ma questo modello è alla portata di chiunque voglia cimentarsi un po' nel bricolage... Con una spesa minima e qualche ora di lavoro si ottiene un nido leggero, versatile e spazioso.

Ho scelto di dividere il nido in una facciata esterna e una interna: il nido interno sarà totalmente visibile, l'uscita sarà posteriore a questo, e la facciata si presenterà come una parete di legno da cui le formiche escono come in natura, verso l'arena. Il nido potrebbe anche avere due facciate interamente abitabili; si potrebbe fare uscire lateralmente all'arena il tubo esterno... Io ho fatto delle scelte che mi permettono una gestione del nido "fronte-retro” per questioni di utilizzo. Dovendo portarlo in giro in fiere o nelle scuole, dovevo optare per la soluzione a me preferita. Ho visto che se divido in due la parte abitabile, l'osservazione diventa più complicata. In questo modello, se le formiche scavano, le gallerie sono a vista, in vetrina, sul retro; per me è già un buon compromesso. Altri di voi possono sviluppare le mie idee a loro piacere, introducendo tutte le varianti del caso; ricordate solo che le colonie di C. vagus iniziano a scavare dopo il secondo anno di vita, quando la colonia si moltiplica a dismisura e il carattere di questa specie si manifesta in maniera decisa e inarrestabile. Pensateci bene, e prendete le necessarie precauzioni.
Decorare il retro è solo un modo per rendere un po' meno “freddo” un nido altrimenti poco naturale, ma funzionale.

Per fugare eventuali dubbi, vi anticipo che per i nidi di legno non è prevista l'umidificazione interna; Camponotus vagus sembra perfettamente a suo agio in nidi caldi e asciutti. Il rischio di far marcire il legno è sempre presente, e le formiche da sole ci penseranno per tempo. E' sempre possibile collegare una provetta con acqua a una delle uscite alternative, o mettere un beverino in arena: ci penseranno loro a rifornire di umidità la covata e la popolazione interne; un lavoro in più per non facilitare loro il compito di "minare” le pareti del nido. Curate soprattutto il contatto fra "vetro” e legno. Le formiche tendono a sigillare ogni fessura, anche minima, con materiale di vario tipo: rifiuti, segatura, detriti. Questi materiali inizialmente fanno da sigillante, ma con le variazioni di umidità e temperatura, possono infiltrarsi ed espandere il vetro, spingendo le formiche a insistere ripetendo l'operazione, finché il tutto non farà da cuneo, favorendo il passaggio delle operaie curiose, e... il gioco è fatto! La colonia è pronta per una evasione di massa! I detriti vanno sempre a minare le parti basse del nido, o i punti di contatto verso il basso. Tenetene conto, e cercate di far sì che il contatto fra vetrina e legno sia sempre omogeneo!
La struttura di un formicaio di legno esteticamente più bella, e più al sicuro dalle evasioni, è quella realizzata scavando direttamente in un pannello di legno massiccio. Ancor più dei modelli in gasbeton e gesso, il legno si adatta a strutture verticali che, più sottili e leggere, richiedono però una base stabile per essere mantenute in equilibrio. Questo piedistallo può essere realizzato con lo stesso tipo di legno della struttura, o in qualsiasi altro materiale che si possa incollare, agganciare, o saldare al legno.
Sperimentare le tecniche, deciderne il disegno, e scontrarsi così con i primi rudimenti dello scavo di questi modelli è possibile già con materiali facili quali i fogli di sughero. Questo legno, così morbido, è lavorabile anche con attrezzi alla portata di tutti, come un Dremel armato di punte adatte.
I nidi nel sughero sono adattissimi a specie arboricole come Camponotus lateralis, Colobopsis truncatus o formiche del Gruppo Temnothorax, che sono piccole e relativamente in grado di perforarne il supporto.
E’ consigliabile anche se non indispensabile, procurarsi un foglio di sughero il più spesso possibile; fogli troppo sottili, o i fogli sottili incollati (anche a pressione) fra di loro, possono riservare problemi, in quanto certe formiche sono abili a sfruttare i punti deboli delle tavole, e in alcuni casi potrebbero approfittare di gradini o scollamenti per attaccarsi con le tenaglie e cominciare a minare lì la struttura.  Ma i grandi nidi per formiche carpentiere, scavati in legni più duri, richiederanno l’opera di un artigiano o di attrezzature non sempre alla portata di un normale utente. Il lavoro necessario a scavare grandi nidi per colonie popolose o formiche aggressive come Camponotus vagus, necessitano ore di lavoro, oppure l’intervento di frese professionali, o meglio ancora, l’uso di una fresa automatica guidata da un CAD. La progettazione e la messa in opera di geometrie complesse in legno massiccio su vaste superfici richiede un macchinario apposito o l'intervento di un professionista falegname. Qui sotto è evidente la differente qualità e il risultato fra le due diverse tecniche. Ma la parte più significativa è il rilevante tempo necessario allo scavo manuale. Nido scavato a mano con Dremel e trapano da legno: 
Nido scavato con fresa di precisione su disegno realizzato in CAD. 
Soprattutto nei modelli verticali a doppia facciata, ma anche in quelli a facciata singola, invito tutti a non scavare mai stanze più alte di 1-1,5 cm. Le arboricole e le carpentiere in generale, non sono formiche che abbiano l’abitudine di accumulare riserve di cibo, e anche se la covata in alcuni casi può essere appesa a pareti di legno (le larve di Camponotus sono dotate di una fitta peluria uncinata che permette questa operazione), per le formiche è meglio poter disporre larve e bozzoli su ripiani orizzontali. Quindi è meglio favorire la presenza di superfici pianeggianti, o anche inclinate, ma con soffitti non troppo alti che le costringerebbero ad accumulare ammassi di bozzoli e larve accatastati l’uno sopra l’altro, più difficili da gestire. In questi casi si noterebbe il fenomeno di formiche isolate che sembrano schiacciate fra i bozzoli come si fossero addormentate lì, e fossero state ricoperte di bozzoli e larve dalle compagne.
Per evitare la struttura a stanze strette coi soffitti alti, è bene prevedere il disegno della pianta del formicaio verticale disegnandolo e ridisegnandolo bene prima, studiando come disporre numerose stanze basse a più piani, come in un palazzo, oppure prevedere stanze più alte ma intervallate da diaframmi sottili e adatti all’appoggio della covata inerte. Non è necessario che le stanze siano molto profonde, lo spessore del legno determinerà il loro possibile sviluppo, ma se vogliamo che le formiche restino ben visibili, è meglio non andare oltre i 2 cm di profondità.
In caso di formicai in legno orizzontali, tutti questi accorgimenti sono superflui: la disposizione delle sale può anche essere ampia (in questo caso meglio che le stanze non siano troppo profonde!) con poche intersezioni separatorie, e anche le gallerie di accesso possono svilupparsi senza particolari geometrie. Una possibilità che rende il nido più vivibile e più simile a un tronco d’albero forato in natura è quella d'incidere le stanze e le gallerie in modo che buchino tutta la superficie del legno, affacciandosi sul lato opposto della tavola. Questo vale per i formicai a modello verticale e, in questo caso il nido diventa a doppia facciata. Le stanze che lo attraversano tutto avranno così una doppia visibilità, e le abitanti potranno sfruttare tutto lo spessore del pannello. Consiglio di utilizzare tavole spesse al massimo 4-5 cm; uno spessore maggiore, fornisce alle formiche uno spazio eccessivamente favorevole all’occultamento: vedrete meno facilmente le condizioni della regina, e l’eventuale scavo di gallerie all’interno di un nido troppo spesso non sarà avvertibile, fornendo loro sempre più spazi per nascondersi.
Io consiglierei di schermare almeno una delle facciate. Le formiche abituate alla luce sin dalla fondazione non sono normalmente infastidite dalla luce, e tutti noi alleviamo da anni formiche alla luce del giorno, ma offrire loro (e soprattutto alla regina) la sensazione di occultarsi alla vista altrui, in certi casi aiuta a mantenere più “tranquilla” la colonia.
Nelle mie osservazioni dal vivo, ho notato che un formicaio interamente schermato fa sì che le formiche si distribuiscano sull’intera superficie abitabile, mentre una facciata scoperta può influenzarne la frequentazione che è determinata in gran parte dalla temperatura, e le formiche sposteranno la covata soprattutto verso una fonte calore, cosa che alla lunga può creare dei problemi, come vedremo in seguito.
E’ quindi meglio gestire un ampio nido a doppia o singola facciata, lasciandolo coperto, scoprendolo solo quando si fanno delle osservazioni.
La colonia abituata a visite frequenti non risente dell’esposizione alla luce occasionale, se si ha l’accortezza di mantenerla scoperta di tanto in tanto. Geometria degli interni.
Ognuno ha una propria idea di come le formiche scavano un nido. Di solito, le formiche ne hanno una diversa.
Le carpentiere maggiori, che sfruttano i punti più deboli degli alberi in cui vivono, scavano gallerie nelle venature morte del legno, seguendo le sezioni degli anelli annuali di crescita. Si sviluppano così fondamentalmente strutture verticali concentriche, con collegamenti profondi metri. Ma nei tronchi caduti, gli stessi abissi verticali diventano pavimentazioni altrettanto vaste. Per le formiche adulte verticale o pianeggiante conta poco, ma i materiali di costruzione, i bozzoli inerti, la covata, sono trasportati qua e là e benché possano essere appesi, hanno bisogno di spazi ampi e di circolazione d’aria e calore.
Nel caso di Lasius fuliginosus, bisognerà tenere conto che questa specie costruisce spontaneamente padiglioni in legno/cartone masticato, disposto in grattacieli interni ai tronchi d’albero, e in simbiosi con un micelio fungino; come sviluppare un nido di legno per ospitare queste formiche e dar loro la possibilità di riprodurre una simile struttura? Per un allevatore appassionato poter osservare un simile comportamento sarebbe paragonabile al veder crescere il fungo delle tagliafoglie brasiliane!
Allora, come scavare il nostro formicaio?
Per le mie esperienze, grandi colonie di carpentiere necessitano di abitazioni complesse e ricche di connessioni. Colonie piccole, con formiche medio-piccole, possono essere ospitate in sezioni di legno relativamente minuscole; una colonia di Colobopsis o di Temnothorax può stare in una tavoletta 10 x 10 ed essere disegnata seguendo una pianta di lunghe gallerie con stanze distanziate e di numero limitato. Per ovviare invece al bisogno di spazio che richiede una grande colonia, e la necessità di racchiudere tutto in un modello trasportabile agevolmente, io scelgo strutture geometricamente complesse, ricche di stanze separate da diaframmi il più possibile sottili, soprattutto nel nucleo centrale. La possibilità di bucare stanze su entrambe le facciate di una tavola spessa fa guadagnare ampie superfici, soprattutto associata a saloni che si affaccino su entrambi i lati, meglio se non sono simmetrici. La necessità di guadagnare spazio non deve cancellare lo svolgersi del naturale andamento delle gallerie, che deve essere meno possibile regolare, altrimenti si può tranquillamente restare al modello incassato fra cornici con i bastoncini da ghiacciolo come ripiani. Quindi bisogna alternare la costruzione di stanze su piani sovrapposti a una serie di passaggi o corridoi il più possibile irregolari.
Grande spazio deve sempre essere dedicato alla cornice esterna che serve a contenere eventuali fughe. Le formiche bucheranno dove potranno, e tenteranno comunque di trovare un punto debole nella loro prigione. Meglio rendergli le cose più difficili possibile! Un minimo di 3-4 cm di legno massiccio sono da prendere in considerazione nella parte bassa della struttura, uno dei punti in cui le formiche sono più propense a scavare.
Considerate che una colonia appena installata tende sempre a trincerarsi e a tappare tutti gli spifferi o fessure che tolgono loro sicurezza, ma col tempo andranno a sfruttare le stesse falle nella struttura per allargare i loro spazi! Problemi con fonti dirette di calore.
I nidi di legno sono sensibili all’umidità, sia interna che esterna.
Di principio, non è bene far entrare in contatto l’acqua con il materiale della costruzione, quindi le formiche devo poter avere accesso a fonti di umidità indipendenti, come provette, abbeveratoi in arena o altri accorgimenti che compensino la mancanza di umidità della loro casa. In questo senso il sughero è più adatto come gestione, non soffre di queste limitazioni, perché non si deforma come gli altri legni. Il legno è un materiale vivo: si gonfia con l’umidità, si piega, si “imbarca”, marcisce, asciugando può restringersi. Applicare una lastra di vetro a una tavola di legno può sembrare una operazione facile e priva di rischi per il nostro nido, ma come la fisseremo? Colle? Silicone? Tasselli o morsetti? Se il vetro è rigidamente fissato, la deformazione del legno potrebbe arrivare a scollarlo, scalzarlo, anche a romperlo (nel caso di un fissaggio rigido con angolari metallici). Un vetro rotto o incrinato mina la sicurezza del nido. Bisogna che il vetro sia fissato al legno in maniera dinamica perché un fissaggio che a prima prova sembra sicuro ed ermetico, nel giro di poche settimane potrebbe mostrare limiti inaspettati.
Per quanto possa sembrare incredibile, i problemi più grandi possono venire dal riscaldamento del nido, perché sono proprio gli sbalzi di umidità associati a quelli di temperatura che fanno variare maggiormente entrambe le superfici. Un legno che si imbarca, anche se il vetro è ben saldato e regge alla prova sui bordi, crea fessure verso l’esterno (se si gonfia al centro si scoprono spazi sul perimetro) o al centro; le formiche sentono subito che ci sono spiragli, e corrono immediatamente a tapparli, infilando negli spazi ogni sorta di materiale, dai detriti, ai resti di insetti, alla segatura. Questa operazione innesta un meccanismo perverso, che le operaie perseguiranno a oltranza: la fessura si allarga, e altro materiale vi verrà infilato. Il risultato sarà di creare un allargamento dello spazio fra il legno e il vetro. E la catastrofe è annunciata.
Un nido che asciuga dopo essere stato “inquinato” da un eccesso di umidità, in pochi giorni può variare le sue dimensioni in termini di millimetri, che, parlando di formiche, sono decisivi. La scelta di usare lastre di plexiglas, cosa che evita il rischio di rotture, a tutta prima sembrerebbe una soluzione ideale, ma il plexi è ancora più soggetto a deformarsi, così non sarà il legno a spingere in fuori il vetro, ma il plexiglass ad allontanarsi dalla superficie di legno.
L’unica risoluzione, ma è il vantaggio che il plexiglas offre, è che può agevolmente essere bucato e fissato in tutti i punti a rischio. Prevedete quindi in fase di progetto di scavo delle superfici a contatto più larghe in cui sia possibile bucare e applicare un ancoraggio. Pensate molto in anticipo tutti i punti in cui potrebbe deformarsi e allontanarsi dal legno, e fissatelo con viti anche piccole, ma che garantiscano l’aderenza delle due superfici. Le viti non devono essere messe solamente a presidiare il perimetro sterno, ma anche a mantenere la lastra aderente all'interno del nido (e una sola nel mezzo può non bastare!).
In realtà è impossibile che il legno non subisca gli effetti dell’umidità. A lungo andare, la popolazione stessa rilascia una grande quantità di liquidi che vanno a sporcare, far ammuffire, e danneggiare la loro casa. Le superfici più frequentate, anche solo per il rilascio delle feci, il deposito delle prede, il trasudare estivo della popolazione, la massa viva agglomerata in luoghi angusti d’inverno, rendono pavimenti e gallerie inizialmente lisce e linde, in pochi mesi nere e porose.
Una colonia di più di 1000 operaie di Camponotus necessita di almeno una provetta d’acqua da 20 cm ogni 3-4 giorni in piena estate, e quest’acqua da qualche parte va a finire! Ultimo aggiornamento (Venerdì 12 Gennaio 2018 19:02) Ultimo aggiornamento (Venerdì 19 Gennaio 2018 13:26)

Nome:Â Camponotus herculeanus. Tassonomia:Â Sottofamiglia:Â Formicinae; Genere:Â Camponotus Ginia:Â monoginica
Areale di distribuzione: diffusa sugli Alpi e negli Appennini settentrionali, raramente al di sotto degli 800-1000 metri di quota. Non presente nelle regioni del sud. Regina: 16-18 mm, nero lucido con sfumature rosso-cupo nelle zampe Maschio: 8-12 mm, nero, sottile; Operaie: maggiori e minori, 6-14 mm; nero lucido, rosso-cupo solo sul torace, cosa che permette di distinguerla facilmente da C. ligniperda, la quale ha un estensione di colore anche sul primo tergete del gastro. Quando la colonia cresce, nascono operaie maggiori che possono essere considerati “soldati” adibiti alla difesa, riconoscibili dalla taglia e dalle proporzioni massicce del capo. Alimentazione naturale: sostanze zuccherine, nettare, insetti (vivi e morti). Alimentazione artificiale: miele diluito per gli adulti, insetti (vivi e morti) preferibilmente dal corpo molle (farfalle, bruchi, camole, mosche, grilli). Per le loro dimensioni, le larve hanno bisogno di molte proteine. Umidità: 30-50 % Temperatura: 18-25 ° C Ibernazione: Necessaria, da ottobre alla fine di marzo a 5-8 °C. Queste formiche tipiche delle zone di montagna in natura seguono una diapausa invernale che le rallenta da settembre ad aprile, periodo in cui generalmente restano inattive e non allevano la covata, pur potendola mantere nel nido; sono quindi molto lente soprattutto nello sviluppo iniziale della colonia. Nidificazione: preferibilmente nel legno degli alberi Nido artificiale: preferibilmente progettare nidi in sughero o legno non trattato, prevedendo protezioni, in quanto, alla lunga, possono bucare le pareti Difficoltà: semplice ma con tempi lunghi di crescita. Nonostante sia una formica bellissima, è sconsigliabile a un principiante, o a chi desidera vedere la propria colonia crescere in modo apprezzabile. Indole: morso potente in grado di tagliare in due altre specie di formiche più piccole; abbondante acido formico. Ciò nonostante non è una formica particolarmente aggressiva, anzi, è piuttosto schiva e timida quando foraggia solitaria. Sembra che ciò possa essere imputabile al fatto di condividere l'areale di distribuzione con la più aggressiva Formica rufa. Periodo di sciamatura: da maggio a giugno, a seconda del clima delle zone di montagna in cui vive. Fondazione della colonia: Claustrale solitario. Da uovo a larva: circa 10-16 giorni Da larva a pupa: circa 10-14 giorni Pupa - adulto: circa 10-24 giorni). L’attività delle operaie è limitato ai pochi mesi estivi tipici dell'ambiente alpino, cosa che la rende lentissima nei primi anni di sviluppo della colonia, rendendola adatta ad allevatori molto pazienti. 
Ultimo aggiornamento (Lunedì 28 Settembre 2020 19:31)

Nome: Camponotus nylanderi;
Tassonomia: Sottofamiglia Formicinae; Tribù
Camponotini; Sottogenere: Tanaemyrmex
Origine:Â Sud Italia (segnalata in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, Sicilia)
Casta: monoginica;
Regina: 16-18 mm, corpo nero, screziato
bruno-giallastro nella parte anteriore del gastro, zampe marrone-rossastro (insomma... guardate la foto)
Maschio: 8-12 mm, nero
Operaie: 6-12 mm, polimorfiche, con major dal capo
robusto;Â testa marrone scuro, torace marrone leggermente più chiaro e
gastro giallo o marrone scuro come la testa, zampe arancio-marrone scuro. Una certa
variabilità di colorazione e screziatura nelle operaie di dimensioni diverse nella stessa colonia è
comune.
Alimentazione: in natura sostanze zuccherine, nettare, frutta matura e insetti, meglio piccoli e morbidi, soprattutto nelle fasi iniziali della colonia
Alimentazione in allevamento: soprattutto soluzione di miele diluito in acqua, zuccheri. Insetti teneri come farfalle, drosofile, blatte, grilli, bruchi; frutta molto
matura.
Umidità: ambiente relativamente asciutto, mai
troppo umido, anche nel nido.
Temperatura: consigliabile, per lo sviluppo della
covata, da 26 a 32° C.
Ibernazione:Â non obbligatoria; volendo effettuare pausa invernale da fine novembre a febbraio mantenere la
colonia fra i 12 e i 16° C. Una nota curiosa da verificare ma da prendere in considerazione: secondo Rigato, C. nylanderi, localizzata nel sud Italia, potrebbe appartenere a un gruppo di Camponotus eterogeneo che popola il Nord-Africa (deserto del Magreb). Andrebbe condotto un raffronto approfondito che al momento non è possibile. Molte delle specie tipicamente africane presenti in Italia del sud fanno risalire la propria presenza al periodo della Roma antica in cui i commerci con le coste oltremare erano fiorenti. Bisogna considerare il comportamento di C. nylanderi equiparabile a quello dei Messor o di Pheidole, che possono vivere la fase invernale in rallentamento, ma anche in piena attività nelle regioni più calde. Mantenendo la colonia riscaldata durante l'inverno, lo sviluppo prosegue senza rallentamenti, cosa non possibile ad esempio, con Camponotus vagus.
Nidificazione:Â nel terreno,
sotto pietre, alla radice di alberi in zone aperte. Nidi artificiali consigliati: gasbeton, ma è possibile usare anche il gesso.
Difficoltà:Â Sviluppo lento; seguendo i ritmi naturali si protraggono i tempi in
fase di fondazione. Se non opportunamente riscaldate a primavera le prime operaie si possono avere anche 6-8 mesi dopo la
sciamatura.
Comportamento: formiche notturne, schive, come tutte le Camponotus maggiori, con
l’aumento delle operaie acquistano coraggio e diventano più attive. Forte tendenza ad accumulare cibo nel gastro.
Periodo di sciamatura: autunno.
Fondazione: claustrale solitaria.
Periodo di sviluppo approssimativo covata a temperatura
alta:Â da uovo a larva 12-20 giorni;Â da larva a
bozzolo: 10-20 giorni;Â da pupa ad adulto, 20-30 giorni). Ma le temperature del nido influiscono notevolmente sullo sviluppo, così come l'umidità relativa. Sappiamo che uova e larve necessitano di una certa umidità, mentre i bozzoli di solito vengono portati in stanze più asciutte; il combinarsi di tutte queste condizioni assieme può rallentare o accelerare in modo indefinibile la crescita dell'individuo.
Attiva all'esterno da febbraio a fine novembre. Prevedere cavetto o
tappetino riscaldante in regioni a clima più freddo.
La scheda può essere integrata e arricchita per le poche
informazioni dirette dovute ai relativamente pochi allevatori che stanno
ottenendo successi. Chiunque abbia dati e informazioni da aggiungere contatti i moderatori.
 Diari di riferimento: http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=9&t=6494
http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=9&t=8562&start=45
http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=9&t=4179
http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=9&t=8562 
Ultimo aggiornamento (Lunedì 28 Settembre 2020 19:36)

Nome: Formica (Raptiformica) sanguinea
Tassonomia:Â Tribù:Â Formicini; Genere:Â Formica; Sottogenere: Sanguinea-group
Ditribuzione: Ampiamente diffusa, mancano segnalazioni per la Sardegna.
Una delle più famose formiche schiaviste autoctone (è bene ricordare il termine tecnico: dulosi) e una delle formiche più battagliere delle nostre regioni. Ciò nonostante, non è una schiavista obbligata come Polyergus rufescens, e si può mantenere la colonia anche in assenza di ausiliarie.
Ginia: fondazione anche poliginica.
Regina: 9-10 mm, capo e torace rosso/arancio con sfumatura nerastra sulla sommità del capo, torace robusto ma non massiccio, sul quale sono ben visibili le cicatrici alari; addome nero. In questa specie torace e addome non sono così marcatamente pronunciati come in altre, anche perché le regine di F. sanguinea fondano in maniera assistita e non devono affrontare lunghi periodi d’autonomia. Zampe rosso-arancio.
Maschio: 5-6 mm, nero
Operaie: 6-9 mm, agili e robuste, addome nero, capo e torace rosso-arancio, con capo leggermente più scuro nella parte superiore. Leggero dimorfismo. Zampe rosso-arancio. F. sanguinea non spruzza acido formico a distanza, ma morde e cosparge veleno (abbondante) sulle ferite.
Alimentazione: in natura sostanze zuccherine e insetti, frutta matura; moderatamente onnivora.
In allevamento: soluzione di miele diluito in acqua, insetti di tutti i tipi, come farfalle, grilli, camole della farina, mosche, bruchi. Queste formiche riescono a uccidere rapidamente anche insetti corazzati e a fare a pezzi le loro difese, anche se il valore nutritivo di un coleottero adulto si riduce in proporzione alla quantità di chitina difensiva posseduta: le elitre, le teste e il torace sembrano le uniche parti che anche le larve di sanguinea scartano, mentre la chitina delle larve di camola viene digerita interamente. Anche la frutta matura è molto gradita, soprattutto piccole scaglie di mela; sperimentati occasionalmente semi (orzo, farro, riso cotto), briciole di pane, uovo, tonno, crocchette per gatti, tutti accettati.
Umidità: nido relativamente umido e fresco, arena anche asciutta.
Temperatura: consigliabile, per lo sviluppo della covata, da 20 a 26° C.
Ibernazione: da ottobre ad aprile necessaria ibernazione fra i 4 e i 10° C.
Nidificazione: in natura preferisce terreni aperti, a ridosso di siepi o alberi, scegliendo anche pietre assolate. A vista i nidi sono poco evidenti rialzi del terreno frutto dello scavo, con diverse aperture ma circoscritti. Spesso questo rispecchia le abitudini della specie schiavizzata. Le colonie sono facilmente riconoscibili per la presenza della popolazione mista.
Nidi artificiali consigliati: il gasbeton è ideale, non lo scavano; oppure gesso. E’ bene prevedere un’arena spaziosa.
Periodo di sciamatura: estate, giugno/luglio, ma spesso le regine fecondate si spostano con la truppa sia in spedizione di guerra, che per fondare per gemmazione.
Fondazione: in natura ricerca operaie della propria specie, o ausiliarie del Genere Formica con preferenze per F. fusca, F. rufibarbis, F. cunicularia, F. clara; può anche isolarsi da sola con bozzoli rubati di queste specie. Può fondare per usurpazione penetrando nei nidi uccidendo la regina madre, o mostrandosi amichevole e facendosi adottare per uccidere la regina in seguito. Unirsi ad altre regine e fondare comunitariamente. In cattività quindi è bene mettere a disposizione della regina una buona scorta di bozzoli prelevati da queste specie.
Periodo di sviluppo approssimativo a temperatura ideale:
da uovo a larva 10-15 giorni;
da larva a pupa: 8-10 giorni;
da bozzolo ad adulto, 10-18 giorni).
Difficoltà: abitante l’ambiente tipicamente collinare, si adatta meno bene a climi troppo caldi, vanno quindi compensate la temperatura e l’umidificazione del nido. Colonie popolose in pochi anni.
Predazione: per quanto possibile e didatticamente interessante, ricreare in cattività la condizione di scorreria di F. sanguinea su colonie ausiliarie non è facile e sconsigliato per utenti inesperti. L’aggressività di questa specie va tenuta sotto controllo, perché non degeneri nella distruzione delle colonie bersaglio. E’ bene prevedere un’arena molto ampia di disimpegno, e la possibilità di interrompere i collegamenti fra le due colonie in qualsiasi momento. Non è possibile intervenire all’interno di uno o dell’altro nido, quindi bisogna essere presenti durante la scorreria, pronti a manovre che interrompano l’accesso di una o dell’altra popolazione all’arena.
Sanguinea non opera come Polyergus in ranghi serrati ma compie spedizioni in drappelli o gruppi isolati, sfrutta la forza fisica e la grande quantità di acido formico di cui è dotata. Si legge che usi anche armi chimiche come l'amazzone.
Se si desidera quindi foraggiare di ausiliarie la colonia nella fase di fondazione, è meglio fornire semplicemente bozzoli estratti da altre colonie artificiali o in natura, ed evitare esperimenti rischiosi. In caso contrario, le colonie bersaglio devono essere almeno in teoria in grado di gestire un minimo di resistenza (rapporto formiche 10 > 1, dove 1 sta per F. sanguinea), altrimenti ci si potrebbe trovare con la colonia di ausiliarie perduta, soprattutto a causa dell'enorme quantità di acido formico che può accumularsi negli spazi esigui dei formicai artificiali, troppo ermetici. Le specie consigliate a cui attingere per i bozzoli come detto sono appartenenti alle Gruppo di Serviformica: F. cunicolaria e F. fusca, F. rufibarbis, F. clara. Anche F. cinerea si può prestare all’uso, ma con controindicazioni; evitare formiche del Genere Camponotus, o del gruppo Formica rufa. Non utilizzare assolutamente Myrmicine.
Descrizione: Le operaie di questa specie sono molto combattive, e sono fisicamente molto resistenti all’acido formico e agli attacchi delle altre formiche. In natura le colonie mature possono essere composte interamente da formiche della stessa specie e le ausiliarie non sembrano più necessarie. Catturano una grande quantità di insetti e amano la melata degli afidi, che allevano e proteggono.


In questa e nella prima fotografia si distingue abbastanza chiaramente una regina di questa specie.

Note di comportamento di questa formica particolare.
Vale la pena di aggiungere qualche aneddoto riportato da uno dei nostri moderatori più esperti, convalidato anche da alcuni stralci presi dal libro di A. Raignier “Le formiche, vita e costumi” che sembrano rendere queste formiche ancora più interessanti in quanto testimonianza di un “carattere” assolutamente particolare.
Ruben ci racconta di aver assistito negli anni in cui aveva sotto osservazione alcune colonie di F. sanguinea sul proprio territorio, a veri e propri atti di pirateria fuori dagli schemi, in quanto non rivolti alla acquisizione di bozzoli da trasformare in operaie ausiliarie. Ha avuto modo di vederle in molte occasioni aggredire e assediare altre colonie non appartenenti alle specie schiavizzabili, come Messor, Lasius e Camponotus, protraendo per giorni (anche 2 settimane) questi assedi... spesso inutili ai suoi occhi.
In Campania, a 800 m di altezza, assediavano un nido di Messor structor, con una trentina di operaie che costringevano le mietitrici a difendere le entrate del nido; ogni tanto un'operaia piccola o media veniva tirata fuori e uccisa, ma tutto restò cosi per almeno 10 giorni...; la stessa cosa si è ripetuta a distanza di un anno, sempre in agosto.
La stessa colonia autrice dell’assedio attaccò e distrusse nello stesso periodo un grosso nido di Lasius niger, predando alati in quantità e bozzoli (supponiamo a scopo alimentare).
Ruben si è domandato se queste guerre fossero dovute a una "carestia" dovuta alla siccità estiva del periodo (ma di insetti ce ne erano in abbondanza) o più semplicemente a una sorta di "ripiego" dell'istinto dulotico; la zona infatti era all'interno del giardino di una villa delimitata da muri e una strada asfaltata, e le colonie di F. fusca probabilmente si erano ormai estinte, mentre ce n’erano ben 3 di F. sanguinea.
Stessa cosa è stata osservata in zona Abetone, pur ricca di specie schiavizzabili; in quel caso una colonia di F. sanguinea assediò inutilmente per una settimana un nido di Camponotus herculeanus, con perdite da entrambe le parti. In questo caso è più facile supporre una contesa territoriale, per impedire a Camponotus di accedere alle colonie di afidi sulle piante vicine.
E’ possibile che F. sanguinea sia guidata in queste campagne militari da un carattere spiccatamente aggressivo e che sia selettiva territorialmente, come altre specie di formiche dominanti tipo C. vagus o F. rufa (alla cui specie assomiglia anche morfologicamente), o Linephitema humile. Lo stesso comportamento distruttivo verso altre specie non direttamente competitive per lo stile di alimentazione (Messor ad esempio non preda insetti e non alleva afidi, quindi non compete direttamente con sanguinea) si è potuto osservare appunto anche con le formiche già citate. Riporto alcuni brani del libro di Raignier, che possono farci capire ancor meglio il “carattere” di F. sanguinea.
1) Riguardo alla fondazione: la Regina sanguinea, dapprima può dare inizio alla sua nuova colonia usando operaie della sua stessa specie, e provenienti dallo stesso nido; oppure provenienti da un nido differente; può introdursi in un nido di schiave senza regina e farsi adottare; se trova una regina schiava giovane nella propria camera di fondazione, può allearsi ad essa fino alla schiusa delle prime operaie per poi uccidere l’alleata e rimanere sola padrona della covata. Può partecipare a una spedizione schiavistica e impadronirsi di un ammasso di bozzoli abbandonati per isolarsi; un certo numero di regine può associarsi; può entrare in un nido giovane, espellere o uccidere i suoi abitanti impadronendosi della covata. Può anche accadere che parecchie sanguinea si riuniscano per compiere l’impresa…
2) Riguardo alla plasticità di istinto: “scoperto un nido bersaglio, sotto la guida della scopritrice, si marcia direttamente al nido da saccheggiare. La distanza fra i due nidi, che può essere anche di 80 metri, è percorsa in ordine sparso con velocità di circa 1 m al minuto. Arrivati alla meta, le razziatrici accerchiano completamente il nido e vi penetrano dalle aperture. Sorprese alla sprovvista, le fusca oppongono solo una debole resistenza. Le conquistatrici si affrettano a frugare le gallerie e risalgono dopo qualche minuto portando precipitosamente il bottino al nido. E’ stato osservato che sanguinea in “terreno difficile” (?), impiegava una tattica sconosciuta fino ad oggi (primi anni ‘50), dimostrazione della plasticità di questi insetti. Il bottino non era trasportato immediatamente al nido ma raggruppato tutto assieme in un deposito appositamente stabilito a questo scopo. Durante tutta la durata della campagna (8 giorni consecutivi) l’armata di sanguinea è rimasta sul piede di guerra. La manovra si è ripetuta due volte in due anni non successivi. Altra nota:Formica sanguinea può essere parassitata dalle larve dei coleotteri del genere Atemeles. Si tratta del coleottero della specie Lomechusa strumosa che si introduce nei formicai e si fa "adottare” dalle operaie dopo averle drogate con una secrezione prodotta dall'addome e dalle ghiandole distribuite sul corpo della larva. Inizialmente questi coleotteri si presentano nel formicaio, e vengono attaccati, ma i coleotteri rispondono volgendo l'addome contro le formiche e producendo le famose secrezioni. Le formiche rimangono sopraffatte da queste e dopo un po' accettano la presenza del coleottero, imboccandolo in cambio delle sue secrezioni irresistibili. Così dedicano sempre più tempo alla suzione della secrezione rilasciata da Lomechusa e appaiono totalmente disinteressate alla loro covata. Il coleottero a questo punto è libero di deporre le proprie uova e le larve nate si comporteranno come l'adulto, in più nutrendosi della covata delle ospiti. A questo punto, in presenza di numerosi parassiti, può verificarsi la nascita di elementi deformi (pseudogini), incapaci di svolgere le normali funzioni di operaie. Tutto ciò porta in breve tempo al calo delle normali attività e al declino dell’intera colonia, che può arrivare al punto di estinguersi!
ATTENZIONE: L'allevamento di questa specie comporta la presa di coscienza che nel giro 3-4 anni ci si possa trovare di fronte al problema di dover "potare” la popolazione sopprimendo una parte delle operaie che escono in arena. Con alcune centinaia, poi 1000 o migliaia di operaie, la colonia necessita di spazi, alimentazione e cure da non sottovalutare. Le formiche cercano nuovi spazi e diventano particolarmente aggressive e intraprendenti. Ci si potrebbe trovare inoltre di fronte alla possibilità di dover sopprimere la colonia nel caso in cui non possa essere liberata in natura nel luogo di origine della cattura (cosa comunque sconsigliabile: potremmo alterare delicati equilibri vitali liberandole).
Consigliamo in questo caso di rivolgersi a musei, laboratori, oasi naturalistiche con personale competente, o contattare personalmente i moderatori per suggerimenti su misura.
Ultimo aggiornamento (Sabato 11 Aprile 2020 14:54)

Nome: Camponotus lateralis
Tassonomia: Formicinae; Genere: Camponotus; Sottogenere: Myrmentoma
Diffusione: Ampiamente diffusa, arboricola, di climi relativamente caldi
Casta: fondamentalmente monoginica, ma non si escludono situazioni occasionali date dalle condizioni di adattabilità delle colonie, che possono abitare vani diversi sparsi su una superficie più estesa e ospitare regine diverse.
Regina: 10 mm nera con capo rosso
Maschio: 6-8 mm, nero
Operaie: 5-9 mm, nere, con capo rosso, che può estendere la sua sfumatura a parte del pronoto. Esiste una rara variante interamente nera.
Alimentazione: in natura sostanze zuccherine e insetti morti
Ideale in allevamento: particolarmente gradita la solita soluzione di miele diluito in acqua, ma in presenza di alrve fornire anche insetti come farfalle, piccoli grilli e ragni.
Umidità: comune nelle zone mediterranee, ma anche in collina, ha preferenze per l’asciutto.
Temperatura: consigliabile, per lo sviluppo della covata, da 20 a 26° C.
Ibernazione: da novembre a febbraio va tenuta in luoghi freschi, fra i 5 e i 10° C.
Nidificazione: per quanto sia segnalata anche sotto pietre e nelle spaccature dei muri, è una formica che predilige il legno; si sono trovate piccole colonie sparse nelle galle delle querce, sotto cortecce, in vecchie legnaie.
Nidi artificiali consigliati: sughero o altre varietà di legno più solido, non particolarmente dotata come scavatrice di legno stagionato. Si sono ottenuti buoni risultati stabulando la regina in provetta con base in fogli di sughero arrotolato come pavimento. Potrebbe essere usato con successo il gasbeton.
Difficoltà: facile: non crea colonie popolose. Timida e opportunista, si adatta ai principianti che vogliano sperimentare un tipo di Camponotus minore e a sviluppo più rapido di C. herculeanus e C. ligniperdus.
Descrizione: Dotata di un discreto polimorfismo; con operaie minori e maggiori che oltre allo sviluppo, presentano un capo più robusto delle minor. Le major vengono spesso adibite al ruolo di “replete”. Formica esteticamente graziosa che in natura è nota per la sua particolarità di infiltrare operaie solitarie nelle file di Crematogaster scutellaris, allo scopo di approfittare delle eventuali provviste lasciate per strada da quest’ultima. Questa frequentazione è ben tollerata da Crematogaster, inoltre essando più agile, C. lateralis si mette sempre al sicuro da eventuali ritorsioni.
Periodo di sciamatura: ai primi caldi, dall'inizio d’aprile, ma anche nei mesi successivi. Come altre formiche che sciamano in primavera molto presto, i sessuati sono generati prima dell’autunno e trascorrono l’inverno con la colonia, spesso fungendo da “replete”.
Fondazione: claustrale solitaria.
Sviluppo approssimativo a temperatura ideale:
da uovo a larva 10-12 giorni;
da larva a pupa: 7-15 giorni;
da pupa ad adulto, 10-20 giorni).
Attiva da marzo/aprile ad ottobre, inizia una fase di stasi a fine settembre, mantiene la covata inattiva.

Ultimo aggiornamento (Sabato 01 Novembre 2014 00:08)
Nome: Messor structor
Sottofamiglia: Myrmicinae
Genere: Messor

Areale di distribuzione: Tutta Italia: essenzialmente di pianura, più comune nelle zone mediterranee, è la specie che si spinge più a nord.
Ginia: Poliginica
Stile di fondazione: E’ l’unica specie di Messor autoctona che non compie una vera sciamatura. Maschi e regine nascono all’interno del nido e possono anche accoppiarsi in cattività. In natura le colonie si propagano per gemmazione (o scissione); mentre i maschi si allontanano dalla colonia madre per fecondare le regine delle colonie vicine, le regine alate si portano in superficie in attesa dei maschi di altre colonie e in seguito, dealate, rientrano nel nido o migrano accompagnate da una parte di operaie della colonia originale.
Grazie alla struttura poliginica e al sistema di fondazione che sfrutta la propagazione via terra, structor può occupare più nidi interconnessi formando colonie molto popolose.
Regina: Dimensioni 10-12 mm. Meno massiccia che M. barbarus o M. capitatus, all’apparenza non più grande di una major della stessa specie; Colore: nero o marrone, marrone rossiccio; relativamente pelosa.
Operaie: Dimensioni variabili da 4 mm le minor a circa 12 mm le major. Colore abbastanza variabile, da marrone scuro a marrone con sfumature castano. Capo meno robusto, e percettibilmente più squadrato che Messor capitatus. Sviluppa operaie piccole, intermedie e maggiori, non adibite a funzioni tipiche dei soldati, ma al trituramento di semi.
Longevità della regina: circa 15 anni
Longevità delle operaie: circa 2 anni
Alimentazione: si nutre prevalentemente di semi di diverse piante selvatiche e da coltivazione, cereali (anche erba); sono graditi insetti come mosche, grilli, farfalle, camole; una certa predilezione per la frutta dolce.
In allevamento la colonia con le prime operaie può essere alimentata con semi di tarassaco o semi da erba, che anche le operaie più piccole possono triturare. In realtà, una volta trasportati i semi nel nido, la regina stessa contribuisce a sbriciolare i semi che le operaie non riescono ancora ad intaccare. Gradiscono proteine attraverso cibi comuni come il prosciutto cotto, il pollo e il tonno. Insetti morbidi come farfalle, camole, grilli, ragni. Come quasi tutte le Messor è meno attratta di altre formiche dalle sostanze zuccherine come il miele.
Nidi naturali: scavati nel suolo in profondità, molto estesi, con poche uscite sparse.
Nidi artificiali: Gesso e gasbeton, anche se può giungere a scavare entrambi (il gesso se ammorbidito dall’umidità). Prevedere quindi un discreto spessore fra il perimetro delle gallerie e l’area coperta da vetrata. Tende a scavare dove sente umido, quindi nei bordi esterni in basso dei nidi verticali; evitare lì abbozzi di scavo che potrebbe essere invitata a seguire. Meglio arrotondare lo scavo. Nei nidi a lastre affiancate con argilla o terra comune con 1,5 – 2 cm di spessore; non usare semplice sabbia per evitare crolli. Utile un substrato alla base d’argilla espansa, se ospitate in questo tipo di nido.
Temperatura di sviluppo ottimale: 22 - 28 °C
Umidità: Nido tendente all’asciutto, ma più favorevole di altre specie all’umido; il problema di eccesso di umidità è legato al rischio di veder germogliare i semi accumulati, che le operaie poi espellerebbero. Prevedere anche in caso di nido asciutto una zona dove la colonia possa trovare da bere.
Arena esterna: asciutta, meglio con ghiaietto sottile o terriccio, che le formiche rivolteranno e sporcheranno facilmente, in quanto una colonia matura produce molti rifiuti, che le operaie tendono ad accumulare in punti precisi.
Periodo d’ibernazione: Non obbligato, ma consigliato almeno per breve periodo. Portare la colonia a 5-15 gradi per circa 2 mesi favorisce la deposizione primaverile e il riposo della regina.
Tempi di sviluppo covata: da uovo a larva: circa 9-15 giorni - da larva a pupa: circa 12-15 giorni - da pupa ad operaia: circa 10-15/20 giorni.? La crescita è influenzata sia dalla temperatura, che dalle necessità di sviluppo in minor o major dell’operaia.
Particolarità: Allevamento semplice, colonie con più regine necessitano la previsione di spazi ampi a causa della crescita più veloce. Morso innocuo, veleno da contatto delle operaie, repellente, poco efficace.

Ultimo aggiornamento (Martedì 05 Maggio 2015 02:25)

Regina di Aphaenogaster spinosa. Foto di Stefano Manetti
Nome: Aphaenogaster spinosa (Emery1878) Tassonomia: Famiglia: Formicidae - Sottofamiglia: Myrmicinae - Genere: Aphaenogaster
Tassonomia: Myrmicinae
(sub species: Aphaenogaster spinosa spinosa, Aphaenogaster spinosa etrusca)
Areale di distribuzione: Italia centrale, tirrenica e Sardegna.
Comportamento: specie diurna, molto reattiva, le operaie escono in pattugliamento a gruppi. In natura le colonie raggiungono raramente piu di 1000-1500 operaie.
Secondo molte fonti di appassionati allevatori, somministrando un maggiore apporto proteico la colonia può raggiungere le 2000-3000 unità.
Ginia: monoginica
Regina: 9-10 mm circa, nera, con setae diffuse in tutto il corpo specie nel gastro e nelle gene. Pare che viva fino a 13 anni. La produzione di nuove regine avviene (secondo Ichinose) solo quando una colonia rimane orfana dopo la scissione della stessa con la migrazione della vecchia regina.
Maschio: 6 mm nero, sottile
Operaie: 7\8 mm, nere, con setae diffuse. Presenta una corporatura tipica, molto snella.
Sono state rilevate raramente operaie minime 4 mm, e operaie “giganti” sui 7,7-8 mm,
Possibili intercaste.
Taglia media piu comune sui 6,5 mm
Alimentazione naturale: insetti vivi e morti, carcasse, sostanze zuccherine, talvolta consumano semi oleosi (pinoli, girasole,etc..)
Alimentazione artificiale: insetti, miele diluito, dieta Baktar, semi oleosi
Umidità richiesta: 30\40% circa; nell’arena di foraggiamento anche molto bassa (10%)
Temperatura: 20-26 gradi, in arena anche 30
Ibernazione: non necessaria
Nidi naturali: nel terreno, sotto sassi e legni.
Nidi artificiali consigliati: gasbeton, gesso.
Difficoltà: bassa. Specie che si presta molto per l’allevamento, cresce rapidamente e non si stressa in modo eccessivo.
Indole: Aphaenogaster spinosa ha un particolare sistema di reclutamento molto efficace che le consente di essere molto reattiva di fronte ad un attacco al nido, forte anche di un "veleno da contatto” che sprigiona un odore aromatico caratteristico.
Se troppo stressate da altre colonie non esitano a trasferirsi.
La loro capacità di veloce reclutamento si ripercuote anche sull'approvvigionamento, infatti sono formiche molto opportuniste che riescono a portare via il cibo trovato prima che arrivino altre specie.
Un curioso comportamento si nota quando incontrano del cibo liquido, perché lo avvolgono con terra o piccoli sassi.
Questo comportamento non è stato del tutto chiarito: se usano infatti la terra come veicolo per le sostanze, o le coprono per evitare di rimanere invischiate e in secondo momento si rendono conto dell'appetibilità della terra imbibita.
Secondo alcuni studi, pare che avendo la specie un piccolo stomaco sociale e quindi una bassa capacità di realizzare la trofallassi, il metodo di imbibire la terra di liquidi zuccherini gli fa sopperire a questa mancanza.
Periodo di sciamatura: Aphaenogaster spinosa non sciama; i maschi lasciano la colonia in cerca di colonie conspecifiche e fecondano le regine vergini alate presenti, oppure in colonie grandi le eventuali, rare, operaie supermaggiori
La colonia superata una certa soglia numerica si divide in due, la regina migra con parte della prole e delle operaie, e quelle che restano nel vecchio nido crescono nuove regine dalle uova rimaste.
Le larve di regina non si alimentano sulle carcasse delle prede ma solo con uova trofiche e rigurgito delle operaie (le uova trofiche sono deposte dalle operaie e sono di aspetto piu tondeggiante e flaccide). 

Ultimo aggiornamento (Giovedì 29 Ottobre 2015 11:56)
Areale di distribuzione: Tutta l' Italia.
Nome scientifico: Solenopsis fugax
Famiglia: Formicidae
Sottofamiglia: Myrmicinae
Ginia: Monoginica. Colonie molto grandi possono essere poliginiche.Regina: 4-5 mm
Operaie: 1-2 mm - non presenta caste
Colore regina: Nero con la possibile presenza di bande più chiare sull’addome.
Colore operaie: Giallo - marrone.
Alimentazione naturale: E’ una formica che parassita diverse specie più grandi di lei (es: Formica cunicularia). Crea cunicoli paralleli a quelli della specie bersaglio attraverso cui entra nel formicaio nutrendosi di avanzi di cibo e larve. Ha un ormone molto potente che allontana anche soldati e operaie molto più grandi. E’ una formica che, nonostante le ridotte dimensioni, presenta una spiccata aggressività e, in caso sia costretta, attacca in gruppo uccidendo rapidamente soldati ed operaie.
Alimentazione artificiale: Principalmente piccoli artropodi e insetti molli (zanzare, moscerini, ecc…). Acqua e miele solo su cotone (a causa delle ridotte dimensioni rischia facilmente di annegare).
Umidità: 40-60%
Temperatura: 20-27°C
Ibernazione: Consigliata ma non necessaria. In regioni calde non va in ibernazione mentre in regioni fredde si.
Formicai in natura Creano formicai nella terra all’interno di formicai di specie più grandi (specie bersaglio). Possono trovarsi anche sotto pietre, foglie e tronchi sul suolo.
Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra. Consigliato un formicaio completamente chiuso all'interno di vasche di plastica o vetro per scongiurare il rischio di fughe da micro aperture.
Difficoltà: Difficile farla fondare inc attività a causa del bisogno di terra e/o argilla. Oltre questo, le ridotte dimensioni delle operaie rendono questa specie difficile da mantenere in cattività a causa delle facili fughe dai nidi artificiali.
Indole: Aggressive in caso di pericolo, solitamente non hanno bisogno di confrontarsi poichè il loro ormone fa fuggire le operaie della specie bersaglio.
Periodo di sciamatura: Dalla metà di settembre fino a ottobre.
Tipo di fondazione: Claustrale.
(Regina di Solenopsis fugax – foto dell’utente Rhebir94)

Nella seconda immagine si vede bene il gastro notevolmente ingrossato della regina pronta a deporre.

(operaia di Solenopsis fugax)

(Colonia di Solenopsis fugax)

(Regina con uova in provetta preparata con tappeto di argilla)
Consigli per facilitare la fondazione in cattività: Ottimi risultati li si ottiene con il "metodo zambon" (chiamato così perchè il nostro moderatore zambon è stato il primo ad adoperarlo e ad osservarne l'efficacia). Il metodo è molto semplice e si basa sull' evidentemente bisogno che questa specie ha di alti tassi di umidità per fondare e portare avanti gli stadi giovanili. Consiste nel chiudere la provetta con un tappo di plastica sul quale si pratica qualche piccolo forellino con uno spillo (al riguardo consiglio di usare le provette di plastica che vendono in farmacia per le analisi delle urine, poichè hanno già correlati i relativi tappi ad incastro). Consiglio comunque di mettere dietro al tappo un piccolo strato di cotone, così che le operaie che sono piccolissime non possano uscire dai micro fori.
Questo metodo da ottimi risultati anche senza l'aggiunta di terra (così da tenera la provetta pulita e la visibilità al massimo).


(Visuale anteriore e posteriore del tappo della provetta con strato di cotone dietro al tappo)

(Risultato positivo di fondazione a distanza di 3 mesi dalla sciamatura della regina)
Ultimo aggiornamento (Domenica 26 Maggio 2013 22:23)
Areale di distribuzione: Tutta l' Italia ed Europa in genere.
Nome scientifico: Lasius flavus
Famiglia: Formicidae
Sottofamiglia: Formicinae
Ginia: Monoginica. Può a volte fondare per pleometrosi (più regine che fondano insieme ma di cui poi resterà solo una poichè la colonia stessa ucciderà tutte le altre).
Regina: 8 - 9 mm
Operaie: 3-5 mm - non presenti caste.
Colore regina: Marrone più o meno chiaro tendente, in alcuni punti, al giallo. Molto simile alla regina di Lasius emarginatus, dalla quale è difficile distinguerla.
Colore operaie: Giallo chiaro.
Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni.
Alimentazione artificiale: Miele e piccoli insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.
Umidità: fornire un gradiente con parte asciutta (30-40%) e parte umida (min. 65%)
Temperatura: 20-27°C
Ibernazione: Consigliata ma non necessaria.
Formicai in natura Creano formicai quasi esclusivamente in terra.
Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra.
Difficoltà: Semplice. Adatta a chi è alle prime esperienze. Meno prolifica rispetto a Lasius niger e Lasius emarginatus.
Indole: Sebbene sia una Lasius è una formica decisamente timida e schiva.
Periodo di sciamatura: Da fine Giugno a fine Settembre.
Tipo di fondazione: Claustrale.
Lasius flavus è una specie molto diffusa sul nostro territorio e, per la sua facilità di allevamento e grande adattabilità, è perfetta per chi è alle prime esperienze nell'allevamento delle formiche. Crea colonie molto rapidamente e in meno di un annno si riescono ad avere centinaia di individui.
In cattività possono vivere in quasi tutti i materiali eccetto il legno. Quindi vanno bene formicai in gesso, gasbeton, ytong, terra e sabbia.
La sua indole pacifica e timida la rende una formica schiva e non molto visibile. Vive in formicai scavati nel suolo, dai quali raramente si allontana.
Curiosità:
(Regina con operaie)

Ultimo aggiornamento (Martedì 15 Maggio 2012 23:10)
Areale di distribuzione: Tutta l'Italia ed Europa in genere.
Nome scientifico: Lasius emarginatus
Famiglia: Formicidae
Sottofamiglia: Formicinae
Ginia: Monoginica. Può a volte fondare per pleometrosi (più regine che fondano insieme ma di cui poi resterà solo una poichè la colonia stessa ucciderà tutte le altre).
Regina: 8 - 9 mm
Operaie: 3-5 mm - non presenti caste.
Colore regina: Marrone, spesso con torace più rossiccio.
Colore operaie: Testa e addome neri, torace marrone/rossiccio.
Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni.
Alimentazione artificiale: Miele e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.
Umidità: fornire un gradiente con parte asciutta (30-40%) e parte umida (min. 65%)
Temperatura: 20-27°C
Ibernazione: Consigliata ma non necessaria.
Formicai in natura Creano formicai preferibilmente nella terra. Spesso usano sassi e legni depositati sul suolo e riscaldati dal sole per tenervi sotto le pupe che richiedono più calore e umidità minore.
Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra.
Difficoltà: Molto semplice. Adatta a chi è alle prime esperienze.
Indole: Tra le più combattive e territoriali tra le nostre Lasius, si difendono valorosamente anche contro le specie più grandi puntando ad un vantaggio numerico.
Periodo di sciamatura: Da Giugno fino agli inizi di Settembre.
Tipo di fondazione: Claustrale. Può a volte fondare per pleometrosi, cioè più regine fondano insieme. Quando poi la colonia crescerà, le operaie uccideranno tutte le regine eccetto una.
Lasius emarginatus è una specie molto diffusa sul nostro territorio e, per la sua facilità di allevamento e grande adattabilità, è perfetta per chi è alle prime esperienze nell'allevamento delle formiche. Crea colonie molto rapidamente e in meno di un anno si riescono ad avere centinaia di individui.
In cattività possono vivere in quasi tutti i materiali eccetto il legno. Quindi vanno bene formicai in gesso, gasbeton, ytong, terra e sabbia.
Curiosità:
Per approfondimenti sull'allevamento, vedi:
- http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=12&t=103
(colonia di Lasius emarginatus con regina)

Ultimo aggiornamento (Sabato 27 Giugno 2015 12:09)
Diffusione: Arboricola. Comune e diffusa in pianura e collina
Nome: Colobopsis truncata
Tassonomia: Tribù: Camponotini; Genere: Camponotus; Sottogenere: Colobopsis
Sottofamiglia: Formicinae
Ginia: Monoginica. In caso usino galle di quercia come formicai, su un albero possono essere presenti più regine.
Regina: 6 - 7 mm
Operaie minor: 3 - 4 mm.
Operaie major: 5 - 6 mm
Colore: Addome nero con banda più chiara vicino all'attaccatura del peziolo. Testa rosso/marrone. Torace appena più chiaro dell'addome.
Alimentazione naturale: Insetti e aracnidi di piccole dimensioni viventi solitamente sul legno.
Alimentazione artificiale: Miele e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e non corazzati.
Umidità: 30-40%
Temperatura: 20-27°C
Ibernazione: Indispensabile.
Formicai in natura Prettamente arboricole, creano formicai piccoli sotto le cortecce degli alberi, in piccoli buchi scavati nel tronco o nelle galle. Spesso creano formicai satellite. Nelle galle è spesso possibile trovare "depandance" e vere e proprie città di galle (vedi: http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=50&t=718 )
Formicai artificiali: Preferibilmente formicai in legno, ma vivono bene anche nel gesso.
Difficoltà: Facile.
Indole: Molto pacifiche e timide. Raramente si scontrano con altre specie.
Periodo di sciamatura: Da metà Giugno a metà Agosto.
Tipo di fondazione: Claustrale. Le regine cercano una galla o un buco nel tronco per infilarsi e fondare all'interno. In caso di pericolo, come fanno i soldati major, sono in grado di incastrare la testa nell'entrata come un tappo.
Colobopsis truncata è una specie curiosa e molto bella. Formano colonie di al massimo qualche centinaio di individui e presentano caste con uno spiccato dimorfismo morfologico. I soldati e la regina presentano la classica testa quadrata che usano come "porta" per bloccare l'accesso al formicaio in caso di pericolo. Per tale motivo sono anche volgarmente chiamate "formiche portinaie". Timide e schive di natura, evitano gli scontri e sopportano pacificamente altre specie, purché non aggressive (come Dolichoderus quadripunctatus). Le operaie minor sono molto veloci.
Curiosità:
particolarità del modo di "fare da tappo" di operaie major e regina

operaia major e minor:

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 17 Aprile 2019 20:33)
Sottofamiglia: Formicinae
Areale di distribuzione: Europa
Ginia: Monoginica
Regina: 8 mm
Maschio: 5-6 mm
Operaie: 5-7 mm
Colore: Marrone - rossiccio.
Alimentazione: Completamente dipendente dalle ausiliarie per alimentarsi; le operaie possono lappare cibo liquido occasionalmente, ma non sono in grado di sostentarsi a lungo abbandonate a se stesse..
Umidità: Vive sia in zone secche che umide. Sembra prediligere comunque un buon grado di umidità.
Temperatura: consigliabile per lo sviluppo della covata, da 22 a 28° C.
Ibernazione: Indispensabile.
Nidificazione: Dipende dalla specie delle schiave che utilizza. Solitamente, usando schiave del genere Formica, nidifica in terra con nidi uguali a quelli della specie schiavizzata.
Nidi artificiali consigliati: Gesso, ytong (o gasbeton). Specie ausiliarie utilizzabili: tutte le specie del Genere Formica (F. fusca, fuscocinerea, cunicularia, rufibarbis, ecc.)
Periodo di sciamatura: Luglio - Agosto.
Sviluppo in natura: E' una formica schiavista (il corretto nome scientifico di questo comportamento è dulosi) che non è in grado di fondare autonomamente. Solitamente si insinua in nidi del Genere Formica e, successivamente, può adottare diverse tecniche per fondare. Ad esempio può uccidere la regina della colonia bersaglio e prenderne il posto; può convivere per un certo tempo nello stesso nido con la regina originale del formicaio o può rubare dei bozzoli per poi farli nascere lei in un altro luogo. Accudita dalle schiave, inizia a deporre le proprie uova che daranno origine a veri e propri soldati che non sono in grado di alimentarsi autonomamente. Solitamente il rapporto tra numero di schiave per singolo soldato Polyergus è di 10 a 1. Quando calano le schiave o aumenta il numero di soldati, viene mandato l'esercito a rubare bozzoli e larve da nidi di formiche bersaglio (preferibilmente del genere Formica), posti spesso anche a decine di metri dal formicaio base (vedi:Â http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=50&t=651 ).
Fondazione e sviluppo in cattività: Bisogna fornirgli da subito alcune ausiliarie e attendere che la regina venga accettata, cosa può avvenire dopo cruente scaramucce. E' bene soprattutto rifornire la nuova famiglia di diversi bozzoli e aumentarli pian piano che nascono le prime operaie schiave. Raggiunto un numero di 50-100 operaie, si aspetta che la regina inizi a deporre le prime uova (possono passare anche mesi). Man mano che aumentano le operaie Polyergus si danno nuovi bozzoli da far adottare.
Visto l'elevato numero di bozzoli di cui necessita questa specie, si consiglia vivamente di far sviluppare parallelamente almeno 2 formicai del genere Formica, così da avere sempre un buon numero di bozzoli. Non è, infatti, sempre facile reperire bozzoli in natura.
Per approfondimenti sull'allevamento in cattività vedi:
http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=13Â Â http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=57&t=3408
Difficoltà: Difficile, soprattutto in fase di fondazione e per le difficoltà legate al reperire un alto numero di bozzoli. Poi diventa un problema di gestione. Questo tipo di formica è un parassita "obbligatorio”, quindi per mantenere la colonia in crescita è necessario foraggiarla per sempre del numero di bozzoli che le sono indispensabili per prosperare. Quando la popolazione cresce, le operaie sono stimolate a cercare di uscire dal nido e cercare un nido bersaglio dove poter fare incursione, quindi ci si trova davanti a due problemi: o si accontenta la loro esigenza mettendo a disposizione un nido di serviformica con covata da rubare, oppure si devono saccheggiare personalmente nidi artificiali o naturali. In caso di incursione in nidi artificiali, il rischio di perdere la colonia bersaglio è legata al meccanismo naturale con cui Polyergus esegue le spedizioni: gli eserciti circondano il nido, e le operaie si strofinano sul corpo i feromoni di propaganda che creano il panico nel nido nemico. L'attacco è rapidissimo; le formiche rimangono pochi minuti, massimo una decina, dentro il nido. Questo limita i danni provocati dai feromoni, dalla grande quantità di acido formico prodotto da difensori ed attaccanti, e limita anche gli scontri corpo a corpo in cui le amazzoni sono letali grazie alle mandibole a sciabola, che bucano il cranio del nemico. Riprodurre questi attacchi in ambiente artificiale è molto difficile! La struttura stessa dei nidi artificiali (spesso con una sola entrata e senza vie di fuga per gli assaliti) limita le possibilità di fuga delle assalite e di far sfogare la grande quantità di veleni che all'aperto si volatilizzano, mentre nello spazio ristretto di nidi artificiali normali si accumulano. Da fonti precise (Prof. Donato Grasso, Università di Parma), per ricreare la classica colonna di attacco delle amazzoni, sono necessari almeno 5 metri di distanza fra i due nidi. Altrimenti l'incursione avviene ugualmente ma a piccoli drappelli, con il rischio di prolungare l'attacco e di non concentrarlo in pochi minuti. Un attacco prolungato nel tempo aumenta il rischio di far morire l'intera colonia bersaglio, proprio a causa dei veleni sprigionati dall'azione. E' quindi preferibile disporre di una stanza ampia dove disporre i nidi e la possibilità di arieggiare il locale. L'alternativa è rinunciare a vedere il comportamento delle formiche nell'atto stesso che le caratterizza e le rende interessanti, fornendo loro di volta in volta, i bozzoli necessari a mantenere la popolazione. A queste condizioni è evidente che l'allevamento di questa specie all'infuori di motivi effettivi di studio, risulta problematico e sconsigliabile ai profani. Superata l'interessante fase di fondazione la crescita della colonia è limitata dalle esigenze stesse di questa formica che in cattività non può essere mantenuta se non storpiando il motivo stesso della sue esistenza: la predazione e il parassitismo estremi.
Curiosità:
- Fin dal primo anno possono essere prodotti maschi;
- Inizialmente le operaie schiavizzate sembrano drogate dalla regina. Restano in cerchio intorno a lei senza fare praticamente nulla;
- E' facile trovare regine neo-sfarfallate appostate presso il formicaio madre (vedi il seguente post:Â http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=1240); questo comportamento deriva dal fatto che le regine in fondazione, usano seguire a distanza le scorrerie della propria specie, per approfittare della confusione generata dall'invasione nei nidi-bersaglio. Nel panico generato dai feromoni di migliaia di amazzoni, ora in ritirata, la regina si introduce nel nido di serviformica e tenta di raggiungere la stanza della regna. Se ci riesce senza essere intercettata, la uccide con un colpo di mandibole e prende il suo posto, emanando effluvi che "drogano” le serviformica inducendole ad adottarla.


Ultimo aggiornamento (Martedì 29 Settembre 2020 15:54)
Areale di distribuzione: Ampiamente diffusa, soprattutto nelle zone mediamente calde, arboricola.
Nome scientifico: Camponotus fallax
Famiglia: Formicidae
Sottofamiglia: Formicinae
Ginia: Monoginica.
Regina: 9,5 - 10,5 mm
Maschio: 6,5 - 7,5 mm
Operaie minor: 4 - 6 mm.
Operaie major: 7 - 9 mm
Colore: Nero lucido.
Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni viventi solitamente sul legno marcescente.
Alimentazione artificiale: Miele e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.
Umidità: 30-40%
Temperatura: 20-27°C
Ibernazione: Indispensabile.
Formicai in natura Prettamente arboricole, creano formicai piccoli costituiti di poche stanze in rami e tronchi marcescenti.
Formicai artificiali: Preferibilmente formicai in legno.
Difficoltà: Media
Indole: Molto pacifiche e timide. Raramente si scontrano con altre specie.
Periodo di sciamatura: Aprile.
Tipo di fondazione: le regine possono fondare in maniera claustrale, ma può essere utile nutrirle durante la fondazione ed eventualmente fornire bozzoli della stessa specie.


Ultimo aggiornamento (Sabato 24 Giugno 2017 22:38)

Formica cunicularia
Tassonomia: Tribù: Formicini; Sottofamiglia: Formica; Gruppo: Fusca
Areale di distribuzione: In tutte le regioni, relativamente in zone non fredde
Ginia: monoginica, occasionalmente poliginica
Tipica formica di prati e giardini di pianura e collina. F. cunicularia forma colonie popolose con classici monticelli esterni non particolarmente elevati, con diverse uscite circoscritte. Particolarmente attiva e laboriosa, adatta anche a principianti.
E’ facile confonderla con le altre del Genere, come Formica cinerea (più tendente al nero-grigiastro e dotata di una maggiore pelosità); F. cinerea crea colonie ancor più popolose (è poliginica) con molte uscite distribuite su una superficie estesa dove sono evidenti tracce di scavo; vive soprattutto presso gli argini dei fiumi, in terreno sabbioso, ed è molto più combattiva di cunicularia.
Regina: 8-9 mm nero opaco con inserti al torace e sulle zampe tendenti al rossastro scuro, quasi marrone
Maschio: 5-6 mm, nero
Operaie: 5-8 mm, nero opaco con tonalità marrone. Esistono anche varietà con colorazioni tendenti al rosso sul torace o sotto il capo. La colorazione non è sempre significativa per riconoscere la specie.
Alimentazione: moderatamente onnivora, in natura sostanze zuccherine da afidi, nettare di fiori ed insetti. Ideale in allevamento: soluzione di miele o zucchero diluito in acqua, e insetti di tutti i tipi, come farfalle, grilli, camole della farina, mosche, bruchi, ma anche avanzi da cucina come briciole, salumi, biscotti, dolci. Anche la frutta matura è molto gradita, soprattutto scaglie di mela.
Umidità: una parte del nido deve essere mantenuta relativamente umida.
Temperatura: consigliabile per lo sviluppo della covata, da 22 a 26° C.
Ibernazione: da ottobre a febbraio la regina smette di deporre e la colonia rallenta l’attività senza immobilizzarsi del tutto anche a basse temperature; può essere mantenuta fra i 5 e i 10° C. La colonia normalmente non sverna con covata latente.
Nidificazione: nidifica preferibilmente nel terreno, e si adatta anche sotto pietre assolate in primavera. Abbastanza reattiva ai traslochi, anche in natura.
Nidi artificiali consigliati: gasbeton (ytong), gesso, nidi con terra a lastre affiancate. E’ bene prevedere un’arena spaziosa e un nido che accolga l'esplosione demografica dopo il primo/secondo anno.
Periodo di sciamatura: piena estate, giugno/luglio.
Sviluppo: claustrale solitario, favorevole all’adozione di bozzoli esterni.
Periodo di sviluppo approssimativo a temperatura ideale:
da uovo a larva 10-15 giorni;
da larva a pupa: 8-10 giorni;
da bozzolo ad adulto, 10-16 giorni.
Comportamento in allevamento: inizio normalmente lento (poche operaie, 10 -20 al massimo, nate la prima estate), anche 100 il secondo anno per poi esplodere al terzo anno anche con migliaia di operaie.
Rischi: Nessuno, morso debole. Dotata di acido formico. Particolarmente veloce.
Descrizione: Le operaie sono molto laboriose e agili, dimostrando una risposta rapida al reclutamento da parte delle compagne in caso di rinvenimento prede, che vengono rapidamente portate nel nido. Inizialmente timide, nella colonia matura possono essere estremamente reattive in caso di avvistamento nemici nei pressi del formicaio. Discrete cacciatrici, trasportano rapidamente le prede all’interno del nido.

ATTENZIONE: L'allevamento di questa specie comporta la presa di coscienza che nel giro 3-5 anni ci si possa trovare di fronte al problema di dover "potare” la popolazione sopprimendo una parte delle operaie che escono in arena. Con alcune centinaia, poi 1000 o migliaia di operaie, la colonia necessita di spazi, alimentazione e cure da non sottovalutare. Le formiche forano il legno o il gesso, o il gasbeton, cercano nuovi spazi e diventano particolarmente aggressive e intraprendenti. Ci si potrebbe trovare inoltre di fronte alla possibilità di dover sopprimere la colonia nel caso in cui non possa essere reitera in natura nel luogo di origine della cattura (cosa comunque sconsigliabile: potremmo alterare delicati equilibri vitali liberandole). Consigliamo in questo caso di rivolgersi a musei, laboratori, oasi naturalistiche con personale competente, o contattare personalmente i moderatori per suggerimenti su misura. Ultimo aggiornamento (Venerdì 29 Aprile 2016 15:50)

Nome scientifico: Crematogaster scutellaris oppure Cremastogaster scutellaris Tassonomia: Tribù: Crematogastrini; Genere: Cremastogaster; Sottogenere: Crematogaster E’ presente in Italia con le specie: C. laestrygon (Sicilia), C. schmidti (nord est) e C. sordidula (Sicilia, aree mediterranee)
Distribuzione: Ampiamente diffusa in zone relativamente calde
Ginia: monoginica
Regina: 8-9 mm nera con capo rosso cupo.
Maschio: nero
Operaie: Monomorfe, 4-6 mm, nere con capo rosso; 2 spine propodeali rivolte verso l’addome; antenne a 11 segmenti con clava di 3; caratteristico addome a forma di cuore che viene puntato verso l’alto quando sono in allarme, per mostrare il pungiglione (cosa che in varie regioni ha meritato loro il soprannome di “rizzaculo”) che espelle una goccia di veleno repellente; hanno un morso tenace ma innocuo per l’uomo. Formano lunghe tracce di collegamento con le mandrie di afidi che allevano e proteggono. Rapida risposta di allarme e reclutamento.
Alimentazione: in natura ghiotta di sostanze zuccherine e insetti
Ideale in allevamento: soluzione di miele diluito in acqua, insetti come farfalle, bruchi, tuorlo d’uovo, sostanze proteiche in generale
Umidità: comune nelle zone mediterranee, si adatta anche in condizioni di ambiente freddo; preferibili nidi artificiali asciutti perché non ama l’umido eccessivo.
Temperatura: consigliabile, per lo sviluppo della covata, da 22 a 28° C.
Ibernazione: da novembre a febbraio va tenuta in luoghi freschi, fra i 5 e i 10°.
Nidificazione: nidifica preferibilmente nel legno, sotto le cortecce degli alberi, pietre in fessure dei muri, formando colonie popolose. E' facile rintracciare le regine e le colonie incipienti all'interno di galle di quercia, pioppo, e altre piante. Costruisce stanze di cartone masticato
Nidi artificiali consigliati: vetro, plastica, gesso con ampio spazio interstiziale antifuga, ma il miglior materiale per questa specie è il legno, sempre posto all'interno di teche con antifuga a tetto. Buca facilmente molti materiali grezzi.
Difficoltà: attenzione alle sue capacità di fuga, pare che sia in grado di forare ogni materiale su cui possa mettere le mandibole, insistendo con tenacia finché non si è creata un passaggio.
Potenzialmente, nell'estate successiva alla sciamatura, la colonia può crescere da 0 a diverse centinaia di individui. L'aumento delle operaie e della covata è esponenziale. Nonostante le dimensioni ridotte, prevedere la possibilità di espandere il primo nido in cui verrà ospitata dopo il trasferimento dalla provetta di fondazione.
Periodo di sciamatura: da fine agosto a ottobre, a seconda delle latitudini.
Longevità delle regine: 20 anni
Longevità delle operaie: 2 anni
Sviluppo: claustrale solitario, sciamando in autunno, la regina normalmente trascorre l’inverno in fase di stasi, anche se non è inusuale che deponga già in fase pre-letargica, se la stagione buona si protrae dalla sciamatura.
da uovo a larva: 10-12 giorni;
da larva a pupa: 10 giorni;
da pupa ad adulto: 10-15 giorni.
Le condizioni di sviluppo sono sempre soggette alle temperature del nido.
Curiosità: il nome Crematogaster era originariamente Cremastogaster (addome alzato), ma pare sia diventato com'è oggi per un banale errore di trascrizione all'origine. (Fonte: Fabrizio Rigato – Museo Storia Naturale di Milano)
Secondo altre fonti, "Crematogaster" significa "Gastro a forma di fiamma" (Grazie a Erreffe!) Bibliografia: Neptunalia di Serafino Teseo
foto: regina con la prima covata di Crematogaster scutellaris
 Ultimo aggiornamento (Sabato 01 Novembre 2014 00:25)

(foto: soldato di Pheidole pallidula in mezzo alle operaie.)
Specie: Pheidole pallidula Tassonomia: Sottofamiglia: Myrmicinae - Tribù: Pheidolini - Genere: Pheidole Areale di distribuzione: di origine africana, si è adattata in tutto il bacino Mediterraneo; preferisce zone asciutte e assolate, non si spinge sulle montagne. È una delle poche formiche italiane con una vera casta diversificata nettamente di soldati/operaie (l’altra è Colobopsis truncatus), senza taglie intermedie. La varietà Pheidole teneriffana è presente in Sicilia, mentre sono state segnalate nella stessa regione nidi di Pheidole megacephala (ancora da confermare).
Taglia delle regine: 6-8,5 mm
Taglia dei maschi: 3,7-5 mm
Taglia delle operaie: 1,6-2,6 mm
Taglia dei soldati: 3,4-4,9 mm
Colore della regina: Marrone scuro, marrone rossiccio
Colore delle operaie: molto variabile, da giallo a marrone scuro, a seconda della zona di appartenenza; possono avere anche tonalità rosso cupo. Le operaie sono di solito più chiare dei soldati.
Periodo di sciamatura: Da giugno ad agosto
Organizzazione: monoginica, benché sia possibile in colonie estese mature la presenza di regine annesse o reintegrate dopo il volo nuziale a formare colonie poliginiche. Il comportamento tipico di questa formica prevede il reclutamento di soldati a protezione di un bottino, mentre le operaie lo sminuzzano e lo trasportano al nido.
Nidi naturali: scavati nel suolo, sotto le pietre, nelle fessure dei muri, anche nelle case.
Nidi artificiali consigliati: gesso, materiali sintetici come lastre di plexiglas; gasbeton poco adatto a causa delle ridotte dimensioni delle operaie e della covata, che può cadere nelle porosità del materiale. Nidi a lastre affiancate sconsigliati sempre per le dimensioni ridotte che permetterebbero alle formiche di occultarsi nel terreno. Particolare attenzione alla possibilità di fuga dai raccordi delle operaie; per lo stesso motivo è meglio non eccedere nell'usare sabbia argillosa o terriccio comune per i terrari nell’arena
. Attenzione: queste formiche tendono ad accumulare rifiuti di scarto all'entrata del nido; lo stesso fanno con i detriti che possono raccogliere in arena. La tendenza è a creare una sorta barricata che delimita l'entrata stessa. Il nido deve essere tendenzialmente asciutto, ma con un’area localizzata sempre umida, risolvendo i problemi di approvvigionamento con una provetta d'acqua fissata in arena.
Le colonie hanno una crescita esponenziale rapida, dovuta al metabolismo accelerato della specie. Prevedere nidi espandibili o grandi in proporzione alla specie nella fase avanzata, o la possibilità di farle trasferirle autonomamente; ideale il sistema di rendere inospitale il vecchio nido scaldando il nuovo.
Il metodo antifuga deve prevedere impasti relativamente poco liquidi, che non colino in caso di temperature elevate. Molti lamentano la perdita di operaie che rimangono invischiate da queste colate o uccise dall'antifuga mentre tentano di superarlo. Il miglior sistema antifuga per formiche del genere è sempre posto su finestre a tetto, consiglaibile PASTA di vaselina (quella bianca) ben mescolata in parti uguali con oli minerali tipo lubrificanti per parti meccaniche e spalmata in strato leggero per almeno 1-2 cm sotto la finestra dell'arena. Funziona anche il talco mescolato ad alcool, ma va rinnovato frequentemente in relazione all'umidità della casa.
Attenzione: sono in grado di scavare anche il gesso se ammorbidito dall’eccessiva umidità, quindi tener conto delle loro piccole dimensioni. Prevedere un buono spessore fra il perimetro abitato e l’area coperta da vetrata. Raccordi all'arena protetti e ben fissati. Usare misture gesso-cemento o gesso non eccessivamente diluito in fase di colata.
Temperatura ottimale: 20/28 °C
Umidità ottimale: 30-60%
Alimentazione naturale onnivora: melata, piccoli semi, insetti morti.
Alimentazione artificiale: onnivora, comeTetramorium, ma più ghiotta di miele diluito somministrato preferibilmente su sostanze assorbenti come cotone o frutta (altrimenti le minuscole operaie potrebbero annegare o rimanere invischiate) e insetti di tutti i tipi, saltuariamente semi. Sperimentare anche avanzi da cucina (ossicini di pollo, uovo sodo, tonno, salse, briciole di biscotti…).
Periodo d’ibernazione: Non indispensabile, è buona norma far riposare la colonia nei due mesi centrali invernali
Temperatura di ibernazione: meglio non scendere sotto i 10°C
Sviluppo: La fondazione è claustrale solitaria (senza alimentazione).
da uovo a operaia circa 30 giorni a 25/28 gradi
da uovo a larva: circa 5 giorni
da larva a pupa: circa 14 giorni
da pupa a operaia: circa 12 giorni.
è possibile che la crescita di soldati sia qualche giorno più lunga; da qualche parte è stato scritto che sia un necessario in proposito un aumento della temperatura media del nido, ma è ancora da provare
Periodo attivo: da marzo ad ottobre
Difficoltà: inizio dalla fondazione abbastanza rapido; le temperature sono importanti e maggiore sarà il calore più rapido sarà lo sviluppo della covata; dopo che la colonia supera la fase iniziale (attenzione alle fughe delle prime operaie) cresce in maniera esponenziale e diventa molto numerosa e intraprendente.
foto: regina di Pheidole pallidula
foto: variabilità cromatica di Pheidole pallidula: colonia marrone scuro

(fotografie di L.L.)
Ultimo aggiornamento (Giovedì 22 Dicembre 2016 22:58)
Areale di distribuzione: Tutta l' Italia ed Europa in genere.
Nome scientifico: Lasius niger
Famiglia: Formicidae
Sottofamiglia: Formicinae
Ginia: Monoginica. Può a volte fondare per pleometrosi (più regine che findano insieme ma di cui poi resterà solo una poichè la colonia stessa ucciderà tutte le altre).
Regina: 9mm
Operaie: 3-5 mm - non presenti caste.
Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni.
Alimentazione artificiale: Miele e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.
Umidità: fornire un gradiente con parte asciutta (30-40%) e parte umida (min. 65%)
Temperatura: 20-27°C
Ibernazione: Consigliata ma non necessaria.
Formicai in natura Creano formicai preferibilmente nella terra. Spesso usano sassi e legni depositati sul suolo e riscaldati dal sole per tenervi sotto le pupe che richiedono più calore e umidità minore.
Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra.
Difficoltà: Molto semplice. Adatta a chi è alle prime esperienze.
Indole: Combattive e territoriali si difendono valorosamente anche contro le specie più grandi puntando ad un vantaggio numerico.
Periodo di sciamatura: Dalla fine di Giugno fino agi inizi di Settembre.
Tipo di fondazione: Claustrale. Può a volte fondare per pleometrosi, cioè più regine fondano insieme. Quando poi la colonia crescerà, le operaie uccideranno tutte le regine eccetto una.
Lasius niger è una specie molto diffusa sul nostro territorio e, per la sua facilità di allevamento e grande adattabilità, è perfetta per chi è alle prime esperienze nell'allevamento delle formiche. Crea colonie molto rapidamente e in meno di un annno si riescono ad avere centinaia di individui.
In cattività può vivere in quasi tutti i materiali eccetto il legno. Quindi vanno bene formicai in gesso, gasbeton, ytong, terra e sabbia.
(Colonia di Lasius niger con regina)

Ultimo aggiornamento (Martedì 15 Maggio 2012 23:11)
Ultimo aggiornamento (Lunedì 29 Luglio 2019 19:52)
Nome: Messor capitatus
Sottofamiglia: Myrmicinae
Genere: Messor

Areale di distribuzione: Tutta Italia ma rara nelle regioni del nord dove si può rintracciare sporadicamente in pianura; comune nelle zone mediterranee e soleggiate.
Ginia: Monoginica
Periodo di sciamatura: Da settembre a fine ottobre
.
Stile di fondazione: Indipendente. Niente alimentazione. Deposizione e prime operaie alla primavera successiva.
Regina: Dimensioni 15-16 mm. Colore: nero brillante e aspetto robusto; relativamente poco pelosa.
Operaie: Dimensioni variabili da pochi millimetri a circa 14 mm per le major più grandi. Colore nero lucido, o marrone molto scuro, con testa robusta e percettibilmente più tondeggiante che in Messor ibericus (ex structor). Sviluppa operaie piccole, intermedie e maggiori, non adibite a funzioni tipiche dei soldati, ma piuttosto a macinare i semi.
Longevità della regina:ÂÂ circa 15 anni
Longevità delle operaie: circa 2 anni
Alimentazione: Prevalentemente semi di diverse piante selvatiche e da coltivazione, cereali (anche semi da erba); sono graditi insetti e nelle colonie adulte è possibile fornire miele diluito, meglio se su supporti come cotone, o frutta (spesso però tendono a coprirlo e ignorarlo), gradiscono la frutta dolce.
In allevamento la colonia con le prime operaie può essere alimentata con semi di tarassaco o semi da erba, che anche le operaie più piccole possono triturare. In realtà, una volta trasportati i semi nel nido, la regina stessa può contribuire a sbriciolare i semi che le operaie non riescono ancora a intaccare. Raccomandabili proteine animali costituite da insetti morbidi come farfalle, camole, grilli, ragni. Possono essere un'ottima base proteica alimenti comuni di altro genere come prosciutto cotto (schegge molto piccole), pollo e tonno. Frutta dolce molto matura, ma anche mele e zucchine.
Nidi naturali: scavati nel suolo in profondità, molto estesi, con poche uscite concentrate.
Nidi artificiali: Gesso e gasbeton sono i più usati e funzionali, ma fare particolare attenzione alla possibilità che scavino entrambi (il gesso solo se ammorbidito dall’umidità). Prevedere quindi un discreto spessore fra il perimetro delle gallerie e l’area coperta da vetrata. Tendono a scavare dove sentono umido, quindi nei bordi esterni in basso dei nidi verticali; evitare lì abbozzi di scavo che potrebbero essere invitate a seguire. Meglio arrotondare lo scavo. Nel caso di nidi a lastre affiancate con argilla o terra comune con 1,5 – 2 cm di spessore; non usare semplice sabbia per evitare crolli. Utile un substrato alla base d’argilla espansa, se ospitate in questo tipo di nido.
Temperatura di sviluppo ottimale: 25 - 30 ° C
Umidità: Nido tendente al secco, anche se la colonia non ha problemi con umido eccessivo, però questo fa germogliare i semi accumulati. Le operaie portano volentieri i semi presso le fonti umide, sembra lo facciano per ammorbidirli. Prevedere quindi una zona dove la colonia può comunque trovare da bere, ma lasciare all’asciutto almeno il 70% del nido.
Arena esterna: asciutta, meglio con ghiaietto sottile o terriccio, che rivolteranno e sporcheranno facilmente, in quanto una colonia matura produce molti rifiuti, che tende ad accumulare in punti precisi. Le operaie gradiscono poter scavare e rivoltare, creare accumuli di materiale e hanno abitudini soprattutto notturne-serali.
Periodo d’ibernazione: Non obbligatorio, ma consigliato almeno per un breve periodo. Portare la colonia a 5-15 gradi per circa 2 mesi favorisce la deposizione primaverile e il riposo della regina.
Tempi di sviluppo covata: Da uovo a larva: circa 9-18 giorni - da larva a pupa: circa 12-15 giorni - da pupa ad operaia: circa 10-15/20 giorni.
La crescita è influenzata sia dalla temperatura, che dallo sviluppo in minor o major dell’operaia.
Particolarità: Allevamento semplice, colonie popolose necessitano spazio una volta sviluppate. Morso innocuo, veleno da contatto delle operaie, repellente e poco efficace. Timide e poco veloci, ma testarde quando iniziano a scavare. Producono grandi quantità di rifiuti che tendono ad accumulare in un angolo dell'arena, ma attenzione: se trovano spazio nel nido, possono accumularlo nelle stanze sporcandole e rendendole col tempo inservibili e impossibili da pulire. A questo proposito va previsto il cambio del nido almeno ogni uno-due anni.
Può essere utile a riguardo leggere il diario di 13 anni di una colonia di questa specie al link:ÂÂ http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=13&t=331
Stanza della covata in un nido di gasbeton

Regina di M. capitatus 
Ultimo aggiornamento (Lunedì 28 Settembre 2020 20:03)
Nome: Camponotus ligniperda;
Tassonomia:Â Tribù: Camponotini; Genere: Camponotus; Sottogenere: Camponotus
Regina: 16-18 mm, nero lucido con sfumatura rossastra che si estende sul primo anello dell’addome
Maschio: 8-12 mm, nero, sottile Ginia:Â monoginica o, raramente, in colonie molto grandi, poliginica; Areale di distribuzione:Â comune e ampiamente diffusa in tutta Italia, soprattutto fra i 500 e 1500 mt di quota
Operaie: maggiori e minori, 6-14 mm; nero lucido, rosso cupo sul torace con sfumatura che si estende sul primo tergite dell’addome (il primo "anello”), cosa che permette di distinguerla da C. herculeanus.
Quando la colonia cresce, nascono operaie maggiori che possono essere considerati “soldati” adibiti alla difesa, riconoscibili dalla taglia e dalle proporzioni massicce del capo. Una particolare osservazione: sembra che le operaie, che cacciano solitarie, prediligano rimanere in agguato sotto rami, foglie o cortecce, in attesa che passi una preda, contrariamente ad altre specie che più comunemente bottinano girovagando.
Alimentazione naturale: sostanze zuccherine, nettare, insetti (vivi e morti).
Alimentazione artificiale: miele diluito per gli adulti, insetti (vivi e morti) preferibilmente dal corpo molle (farfalle, bruchi, camole, mosche, grilli). Per le loro dimensioni, le larve hanno bisogno di molte proteine.
Umidità: 30-50 %
Temperatura: 18-28 ° C
Ibernazione: Necessaria, da ottobre alla fine di marzo a 5-8 °C.
Queste formiche tipiche delle zone di montagna seguono una diapausa invernale che le rallenta da settembre ad aprile, periodo in cui generalmente restano inattive e non allevano la covata; sono quindi molto lente nello sviluppo iniziale della colonia.
Nidificazione: preferibilmente sotto la corteccia, nel legno morto, ma anche sotto le pietre e nel terreno Nidi artificiali:Â preferibilmente progettare nidi in sughero o legno non trattato, prevedendo protezioni, in quanto, alla lunga, possono bucare le pareti
Difficoltà: semplice ma con tempi lunghi di crescita. Nonostante sia una formica bellissima, è sconsigliabile a un principiante, o a chi desidera vedere la propria colonia crescere in modo apprezzabile. Soffre molto le vibrazioni in fondazione, e si stressa facilmente.
Indole: morso potente, può tagliare in due le formiche delle altre specie europee; abbondante acido formico
Periodo di sciamatura: serate calde e afose, spesso dopo un temporale, dall'inizio alla fine di giugno, in collina o zone di montagna
Fondazione della colonia: Claustrale solitario.
Da uovo a larva: circa 10-16 giorni
Da larva a pupa: circa 10-14 giorni
Pupa - adulto: circa 10-24 giorni).
L’attività delle operaie è come abbiamo detto, da aprile a settembre, cosa che la rende adatta ad allevatori pazienti, per quanto, per la sua bellezza, sia una delle preferite anche dai principianti. Nonostante siano necessari anni per avere colonie adulte, occorre tenere presente lo spazio necessario per gestire formiche di queste dimensioni sia per l'arena che per il nido effettivo. Una regina di C. ligniperda con la sua prima covata  Una sciamatura di ligniperda: si possono vedere le tre caste (un maschio in basso al centro). Una sciamatura di ligniperda: si possono vedere le tre caste (un maschio in basso al centro).

Ultimo aggiornamento (Lunedì 28 Settembre 2020 19:24)

Specie: Tetramorium caespitum (detta “formica delle zolle”, o “dei marciapiedi”) Tassonomia: Sottofamiglia: Myrmicinae - Tribù: Crematogastrini - Genere: Tetramorium Dove vive: diffusa e comune in tutta Italia; sono presenti 12 distinte specie di Tetramorium di cui citiamo:T. semilaeve (centro e sud), T. meridionalis (centro, sud, Sardegna), T. impurum (diffusa localmente),T. brevicome (Sardegna), T. biskrense (Lampedusa), T. Santschi (Eolie, Sicilia e Calabra), etc.
Taglia delle operaie: 3-4 mm
Taglia delle regine: 6 mm
Periodo di sciamatura: Giugno-Agosto
Stile di fondazione: indipendente pleometrotico
(possono fondare in collaborazione fra più regine che saranno eliminate dalle operaie appena la popolazione si sarà stabilizzata). Si possono tenere le regine insieme per la fondazione accelerata ma (intorno alle 100-200 operaie) è meglio separarle se non si vuole vederle squartare o si vogliono avere più colonie indipendenti.
Ginia: monoginica
Nidi naturali: scavati nel suolo, sotto pietre, nelle fessure dei marciapiedi
Nidi artificiali: essendo molto piccole e abili a scavare vie di fuga, per un’osservazione accurata
è necessario approntare nidi trasparenti in lastre di vetro o plexi opportunamente modellati, altrimenti humus o sabbia di qualsiasi tipo (dove però le formiche tenderanno a nascondersi). Io consiglio nidi in gesso con buon margine di spessore esterno; miscelare il gesso con altri materiali o diluirlo con poca acqua per renderlo più duro è la soluzione migliore. Nel caso di uso del gesso, è bene prevedere sistema di somministrazione dell'acqua esterno al nido: il gesso bagnato si ammorbidisce e diventa facilmente scavabile.
Temperatura ottimale di sviluppo: 25/28 °C
Umidità ottimale: si adattano alle condizioni più disparate
Alimentazione naturale: rifiuti da cucina, artropodi d’ogni genere e dimensione, melata prodotta da afidi e nettare, semi molto piccoli
Alimentazione artificiale: Sono onnivore, con una netta preferenza per cibi solidi; particolarmente fameliche di cibo animale, quindi insetti di tutti i tipi (penetrano all’interno di coleotteri che non riescono a forare i Camponotus), avanzi di qualsiasi tipo di carne, formaggio, frutta ecc. Riguardo ai cibi dolci, accettano miele diluito preferibilmente assorbito da altre sostanze come legno o cotone.
Periodo di ibernazione: da 0 a 3 mesi, non obbligatoria
Temperatura di ibernazione: 8-11 °C
Longevità delle regine: 15-20 anni
Longevità delle operaie: 3-5 anni
Difficoltà: forano gesso e gasbeton
Tetramorium caespitum è una specie molto adattabile e facile da allevare. Essa supera in aggressività e tenacia la maggior parte delle altre specie nostrane.
Per avviare una colonia è sufficiente catturare una regina dealata durante il periodo della sciamatura – che si estende da Giugno ad Agosto, raggiungendo il suo picco a metà Giugno – e metterla in provetta o direttamente in un terrario. E' possibile anche consentire a due o più regine di fondare una colonia collettivamente. Le comunità di regine fondatrici coopereranno nella fondazione della colonia, ma, una volta che la colonia sarà abbastanza popolosa, fra le regine s’innescherà una competizione. Questa competizione sfocerà nell'uccisione di tutte le regine da parte delle operaie, eccezion fatta per la loro favorita, che si guadagnerà la funzione ovideponitrice stabile nella colonia. Rispetto alla normale fondazione da parte di una regina singola (aplometrosi), la fondazione da parte di più regine (pleometrosi) consente che la colonia si sviluppi più rapidamente e che raggiunga in minor tempo una grande popolazione, tuttavia comporta il rischio che, nella competizione, le operaie finiscano per eliminare tutte le regine. Un risultato più raro della competizione consiste, d'altra parte, in un fenomeno molto interessante, quale l'instaurazione di una oligoginia (la presenza di due o poche regine ovideponitrici in una colonia di una specie normalmente monoginica).
Tetramorium caespitum può scavare sia il gesso che l'ytong, quindi dovrebbero essere prese molte precauzioni riguardo ad eventuali fughe. Non è richiesta un’umidità precisa: queste formiche, infatti, possono benissimo adattarsi alla più larga varietà di climi ed ambienti. Potrebbero sopportare un ambiente arido come uno di tipo tropicale. Una fonte d’umidità, localizzata in un solo punto del nido, non deve comunque mancare.
Il periodo di ibernazione non è strettamente necessario, e potrebbe benissimo essere evitato. Far ibernare la colonia per un mese o poco più potrebbe comunque accentuare la deposizione in seguito alla disibernazione. La temperatura di ibernazione deve mantenersi preferibilmente fra gli 8 e gli 11 °C.
Non ci sono problemi riguardo all'alimentazione: Tetramorium caespitum accetta qualsiasi preda venga fornita, compresi artropodi dal corpo duro o di dimensioni relativamente grandi. Una dieta prevalentemente carnivora può essere integrata talvolta con una soluzione di acqua, miele e zucchero. In caso di scarsità di prede, queste potrebbero essere sostituite da miele diluito con latte a temperatura ambiente o tuorlo d'uovo.
Lo sviluppo è molto rapido e le regine molto prolifiche. Una colonia di Tetramorium caespitum può divenire molto popolosa in poco tempo.
Una frotta di operaie di Tetramorium caespitum si affolla attorno a un pezzo di carne di pollo. Più tardi, non potendolo trasportare presso il nido, potrebbero circondarlo di una sorta di muretto di detriti e lo pattuglieranno per difenderlo da incursioni di colonie vicine.

Ultimo aggiornamento (Venerdì 20 Ottobre 2017 11:19)
Taglia delle operaie: 1-2 mm
Taglia delle regine: 3 mm
Ginia: poliginica
Nidi naturali: prevalentemente nel terreno, nidi non troppo profondi, colonizzano soprattutto gli strati superiori del suolo, più aridi.
Nidi artificiali: nido in gesso, nido verticale scavabile
Temperatura ottimale: 25°C
Umidità ottimale: fornire un gradiente con aree umide e aree più secche (30-80%): le formiche si sposteranno a seconda delle esigenze della covata.
Alimentazione naturale: melata prodotta da afidi, nettare floreale, collemboli
Alimentazione artificiale: dieta Bhatkar, insetti di piccole dimensioni (collemboli a parte, è sconsigliato offrire insetti vivi a questo genere di formiche), acqua e zucchero di canna, acqua e miele, latte e miele.
Periodo di ibernazione: in natura coincide col periodo invernale, in cattività non è necessario
Temperatura di ibernazione: 10 °C

Plagiolepis pygmaea, come il nome della specie suggerisce, è una delle più piccole formiche italiane.
Le sue colonie si trovano prevalentemente in aree aride caratterizzate da una bassa vegetazione. In tali luoghi è comune trovare una colonia di P. pygmaea rivoltando una pietra esposta al sole. I nidi sotterranei di questa specie non sono mai troppo profondi, arrivando al massimo a 50cm di profondità.
Specie altamente poliginica, le colonie contengono di norma da 5 a 35 regine e si riproducono per gemmazione. Plagiolepis pygmaea è anche capace di fondazione indipendente, quindi anche una sola regina è sufficiente per iniziare una colonia.
Oltre alla poliginia, questa specie è anche caratterizzata da una spiccata polidomia: quindi è possibile trovare diverse colonie a brevissima distanza le une dalle altre, quasi come se in realtà formassero una sola "super-colonia" con centinaia di regine.
La differenza di dimensioni fra regina e operaie non è sempre evidente: per distinguere con certezza la regina dalle operaie è necessario esaminare con una lente il torace delle formiche e verificare la presenza di cicatrici alari nonchè la classica "gibbosità" da regina.
Queste formiche, a causa delle loro ridottissime dimensioni, presentano qualche difficoltà nell'allevamento in formicaio artificiale. Ad esempio, il nido dovrà essere costruito tenendo conto della loro capacità di insinuarsi nelle più piccole fessure; e il cibo dovrà essere sempre somministrato su spugna o cotone, con molta attenzione visto che in una sola goccia d'acqua possono annegare numerose piccole formiche.

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 17 Aprile 2013 14:46)

Areale di distribuzione: Tutta l' Italia ed Europa in genere.
Nome scientifico: Myrmica rubra
Famiglia: Formicidae
Subfamily: Myrmicinae
Genere: Myrmica
Ginia: Poliginica. Spesso formicai separati di una stessa zona sono in realtà un'unica grande colonia.
Regina: 5-6 mm
Operaie: 3-5 mm - non sono presenti caste.
Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni.
Alimentazione artificiale: Miele o zucchero diluiti e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.
Umidità: 40-60%
Temperatura: 18-25°C
Ibernazione: Necessaria.
Formicai in natura: Creano formicai preferibilmente nella terra, sotto pietre e vasi, meno comunemente in legni in decomposizione sul suolo.
Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra. Mantenere i nidi abbastanza umidi e freschi.
Difficoltà: Media. Può dare problemi a causa del bisogno di temperature non troppo caldi e umidità più elevata. temperature oltre i 27°C e climi secchi possono causare improvvise morie.
Indole: Combattive e territoriali sono munite di pungiglione e le loro punture sono molto dolorose.
Periodo di sciamatura: Solitamente ad Agosto.
Tipo di fondazione: Semiclaustrale. Le regine necessitano di alimentarsi e spesso escono per cacciare anche in fase di fondazione.
Myrmica rubra è una formica che vive in zone boscose ed ombreggiate con fitto sottobosco umido. Preferisce temperature fresche. E' di colore rosso/giallo e presenta dimorfismo colorimetrico tra giovani esemplari (gialli) e esemplari vecchi (marrone scuro).
Le colonie naturali sono molto numerose (vantaggio derivante dalla natura poliginica della specie) e formicai di una stessa zona sono spesso un'unica grando colonia.
Sono abili cacciatrici e spesso, al banchetto, si uniscono direttamente anche le regine.
In cattività non danno grandi problemi, purchè si tenga la colonia al fresco e il nido ben bagnato. al riguardo sono meglio nidi in gesso che non in gasbeton e ytong.
E' facilmente confondibile con Myrmica ruginodis, Myrmica sabuleti e Myrmica scabrinodis. Tra le tre specie la Myrmica rubra è sicuramente la più aggressiva e quella con la puntura più dolorosa. Inoltre si adatta meno delle altre a climi caldi e secchi.
(Colonia di Myrmica rubra con larve)

Ultimo aggiornamento (Martedì 15 Maggio 2012 23:11)

Nome: Camponotus vagus
Tassonomia:ÂÂ Tribù: Camponotini; Genere: Camponotus
Areale di distribuzione: comune in tutta Italia, preferisce ambienti caldi di pianura e riviera, boschi aperti e asciutti, ma è molto adattabile.

Ginia: monoginica;
Regina: 16-18 mm nero
Maschio: 8-12 mm, nero
Operaie: 6-14 mm, nero, opaco con peli abbastanza fitti che sull’addome creano un effetto grigiastro;
le colonie sviluppate hanno la popolazione divisa in operaie minor e major. Le operaie major possono essere considerati soldati adibiti alla difesa, e sono ben riconoscibili dalla taglia e dalle proporzioni massicce del capo.
Alimentazione: in natura si nutre di sostanze zuccherine e insetti. Le operaie cacciano solitarie e quando la colonia cresce diventano molto intraprendenti e aggressive.
Ideale in allevamento: soluzione di miele o zucchero diluito in acqua, insetti come blatte, farfalle, bruchi (anche vivi, dato che sono discrete cacciatrici), camole e grilli. Accettano volentieri frutta matura, rondelle di zucchina, melone, uovo sodo (sia tuorlo che albume), prosciutto, pollo.
Umidità: comune nella zona mediterranea, si adatta anche in pianura e zona collinare in condizioni di bosco aperto, preferibilmente in pineta od oliveto. Se il nido artificiale all'interno è molto asciutto, tenere riserve di acqua in arena.
Temperatura consigliata: per lo sviluppo della covata, da 22 a 28° C max.
Ibernazione: da novembre a febbraio entra in diapausa invernale, rallentando ogni attività; in questo periodo è consigliabile mantenerla in luoghi freschi, fra i 5 e i 10° C.
Nidificazione: nidifica preferibilmente nei tronchi d’albero, scavando tunnel nel legno morto seguendo generalmente le venature più deboli, ma si adatta anche sotto pietre assolate in zone più fredde.
Nidi artificiali consigliati: gasbeton (ytong), legno di pino, pioppo, quercia, faggio, sughero (tutti questi materiali possono essere facilmente perforati; prevedere rinforzi laterali).
Attenzione: i nidi di legno costruiti a incastro, inchiodatura o incollaggio, oppure scavati a fresa, vanno mantenuti il più possibile asciutti, per evitare sconnessioni o rigonfiamenti della struttura, che porterebbe a fessurazioni. Prevedere quindi un sistema di umidificazione alternativa, con provette di acqua accessibili, o un serbatoio interno che non entri a contatto col legno, a meno di usare un nido ricavato in un blocco unico (tipo con gallerie scavate direttamente nel materiale. Le operaie possono comunque bere per poi inumidire il legno in punti precisi, che poi, ammorbiditi,ÂÂ sono più facili da scavare.
Difficoltà: Prolifica, date le sue dimensioni richiede ampi spazi vitali; è la più adattabile e veloce nello sviluppo, fra le Camponotus maggiori europee C. herculeanus, C. cruentatus e C. ligniperda.
Già nel secondo anno dalla fondazione la colonia può passare da una cinquantina di individui a un migliaio. Date le sue dimensioni, prevedere nidi espandibili, o adatti ad ospitare un numero discreto di operaie per la seconda estate. Si trasferisce facilmente, se le si offre un nido adatto, ma vanno sempre tenute presenti le dimensioni e la velocità delle operaie.
Già al terzo anno di vita, se ben alimentata e con spazi adatti, la famiglia potrebbe raggiungere 1000-2000 operaie, cosa che renderà difficile gestire la popolazione. Le major iniziano a manifestare esigenze di scavo; uno dei sistemi di questa formica per indebolire il legno è di defecare sempre nello stesso punto, e lavorare poi il legno ammorbidito o marcescente! E' indispensabile alloggiare la colonia in un nido che non abbia falle e verificare mensilmente i tubi di collegamento: la plastica può essere rosa e asportata anche per alcuni cm, permettendo la fuoriuscita dagli snodi indeboliti. Si consiglia di schermare le pareti esterne con plexiglas. Le operaie manifestano un aumento dell'attività notturna e l'aggressività aumenta con l'aumentare della prole famelica.
Indole: formica molto veloce e combattiva, aggressiva non appena la colonia cresce di numero. Il morso delle maggiori è forte, innocuo per l'uomo ma comunque in grado di incidere la pelle, quindi fare attenzione. Dotata di abbondante acido formico, è capace di troncare in due le formiche avversarie con un solo morso potente. Se dovete maneggiare le operaie in grande quantità o per un certo tempo, è consigliabile indossare guanti di lattice.
Comportamento in natura: Le operaie maggiori fungono da veri soldati e hanno potenti mandibole. In natura questa formica ha un comportamento aggressivo e dominante verso le formiche di altra specie che confinano col suo territorio, al limite del teppismo. E' facile incontrare operaie solitarie intente a "disturbare” nidi di specie diverse, ponendosi all'entrata dei nidi e uccidendo le operaie in uscita una ad una.
Periodo di sciamatura: ai primi caldi, dall'inizio d’aprile.
Sviluppo da regina fondatrice: Claustrale, solitario, è possibile ma superfluo agevolare la fondazione con adozione di bozzoli. In cattività dalle 50 alle 100 operaie prima dell'inverno.
Periodo di sviluppo approssimativo a temperatura ideale:
da uovo a larva 10-16 giorni;
da larva a pupa: 15-18 giorni;
da pupa ad adulto, 10-24 giorni).
Attiva da marzo/aprile ad ottobre, inizia la fase di stasi a fine settembre; la regina, la cui vita è di circa 15-18 anni, smette di fare uova in questo periodo. Mantiene la covata inattiva durante il periodo invernale. In natura una colonia matura può essere costituita da più di 10.000 individui. Tenerne quindi conto se si decide di allevare questa specie, che necessita di molto spazio sia nel nido che in arena.
Diari di allevamento: diario 1,ÂÂ diario 2
Regina con operaie minor

Operaie che catturano un grillo

La deposizione della covata ha una accelerazione già dal secondo anno di vita...

ATTENZIONE: L'allevamento di questa specie comporta la presa di coscienza che nel giro 3-4 anni ci si possa trovare di fronte al problema di dover "potare” la popolazione sopprimendo una parte delle operaie che escono in arena. Con alcune centinaia, poi 1000 o migliaia di operaie, la colonia necessita di ampi spazi, alimentazione e cure da non sottovalutare. Le formiche forano il legno o il gesso, o il gasbeton, cercano nuovi spazi e diventano particolarmente aggressive e intraprendenti. Ci si potrebbe trovare inoltre di fronte alla possibilità di dover sopprimere la colonia nel caso in cui non possa essere rilasciata in natura nel luogo di origine della cattura (cosa comunque sconsigliabile: potremmo alterare delicati equilibri vitali liberandole). Consigliamo in questo caso di rivolgersi a musei, laboratori, oasi naturalistiche con personale competente, o contattare personalmente i moderatori per suggerimenti su misura.
Ultimo aggiornamento (Lunedì 28 Settembre 2020 19:44)
|